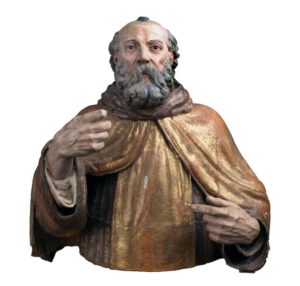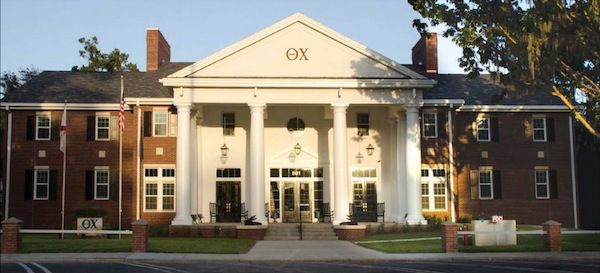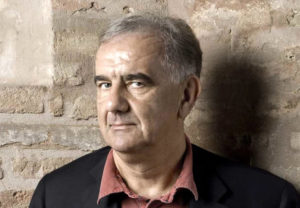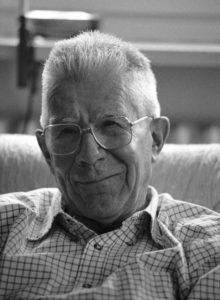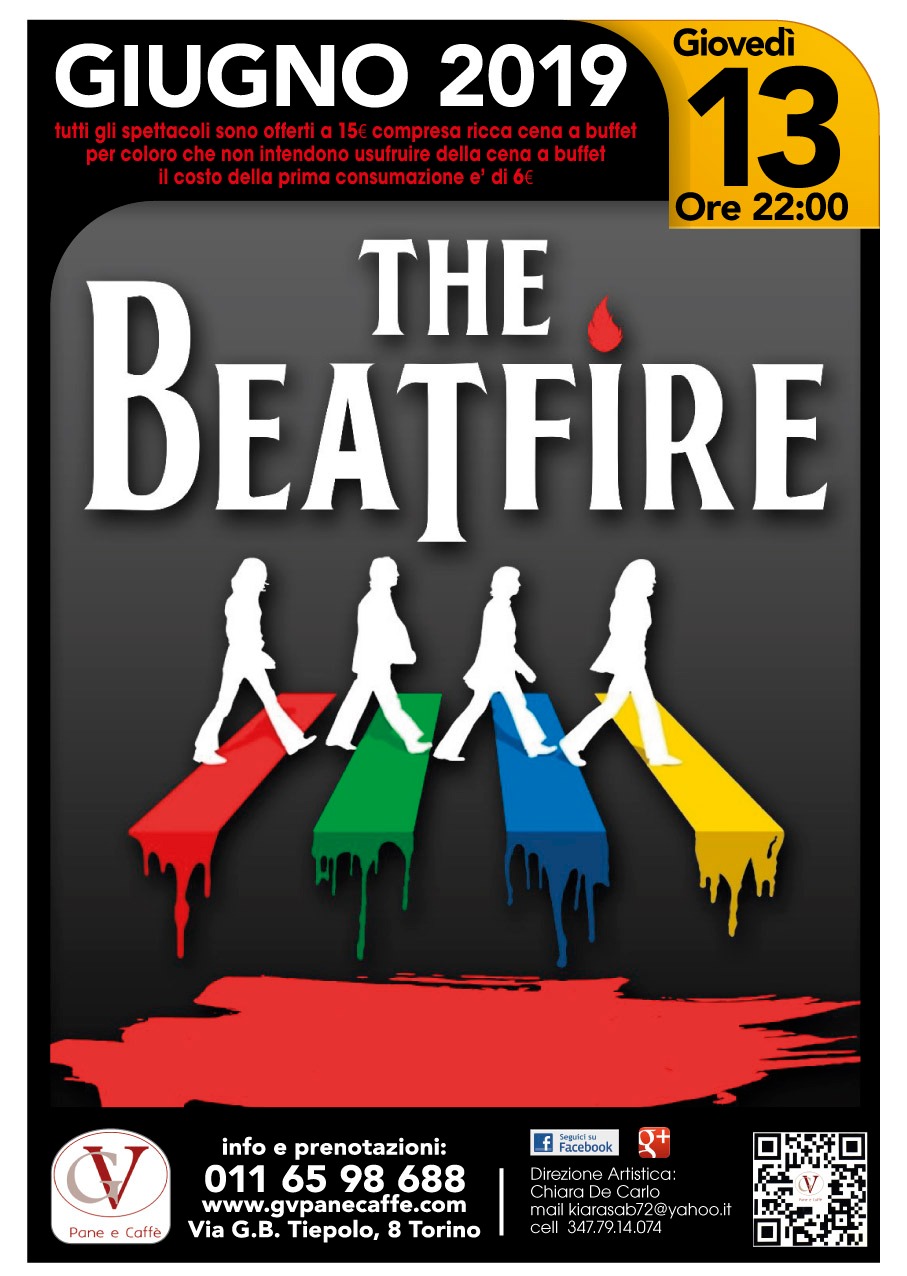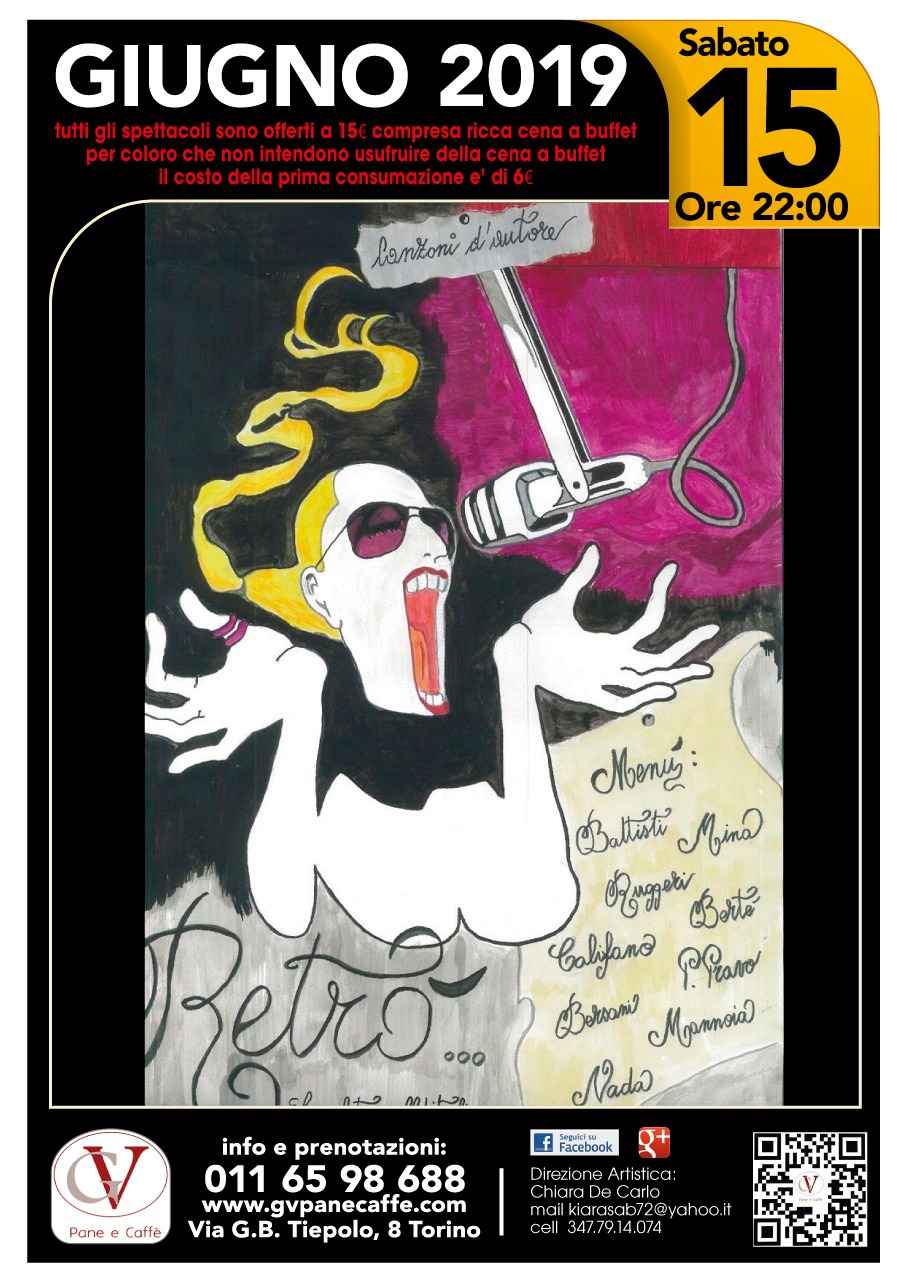Gli appuntamenti musicali della settimana
Lunedì. Al Jazz Club si esibisce la cantautrice Ima. Anteprima di “Collisioni” a Barolo con l’ex Pearl Jam Eddie Vedder, preceduto dal cantautore irlandese Glen Hansard.
Martedì. Al Jazz Club è di scena T Vernice. All’Off Topic si esibiscono i cantautori Fabrizio Cammarata e Verano. Al Blah Blah suona il trio francese Lysistrata mentre alla Tesoriera si esibiscono i Foxhound.
Mercoledì. Al Blah Blah suonano i Naxatras. Al Parco Dora canta Riccardo Fogli.
Giovedì. Al Jazz Club decimo compleanno con la Torino Jazz Orchestra diretta da Fulvio Albano. Edizione numero 11 per “Jazz:Re:Found” a Cella Monte nel Monferrato con la band techno tedesca Meute e Boosta dei Subsonica in duo con Alberto Tafuri.
Venerdì. Al Jazz Club suona il quartetto dell’organista Alberto Gurrisi. Per “jazz:Re:Found” si esibiscono Tullio De Piscopo,Gilles Peterson, Noyz Narcos, Colle der Formento. Alla Tesoriera sono di scena Paolo Benvegnù e Marina Rei. Per il “Monfrà Jazz Festival” al Castello di Casale suona l’Italian Trio di Dado Moroni, Rosario Bonaccorso e Roberto Gatto. Al Gru Village si esibiscono Benji & Fede, The Colors, Mondo Marcio.
Sabato. A Chivasso per “JazzAround You” è di scena la vocalist Deborah Carter. A Cella Monte suonano i britannici Kokoroko e Yussef Dayes con Tony Esposito, I Hate My Village, Kaos One e Area. A Casale jazz con il quartetto del batterista Gianni Cazzola. Al Gru Village si esibisce Irama. Alla Tesoriera è di scena il quintetto della cantante Amira Kheir mentre al Jazz Club suona la Easy Big Band diretta da Gabriele Manassi. In Val d’Aosta inaugurazione di “Musicastelle” con Luca Barbarossa. Per “Ruderi rock” a Villafalletto si esibisce Omar Pedrini.
Domenica. Al Gru Village è di scena l’ex cantante degli Spandau Ballet Tony Hadley mentre a Brusson canta Max Gazzè. Chiusura di “Jazz:Re:Found” con Dj Gruff,
Gianluca Petrella e Nikitch & Kuna Maze, David Rodigan, Chassol.
Pier Luigi Fuggetta