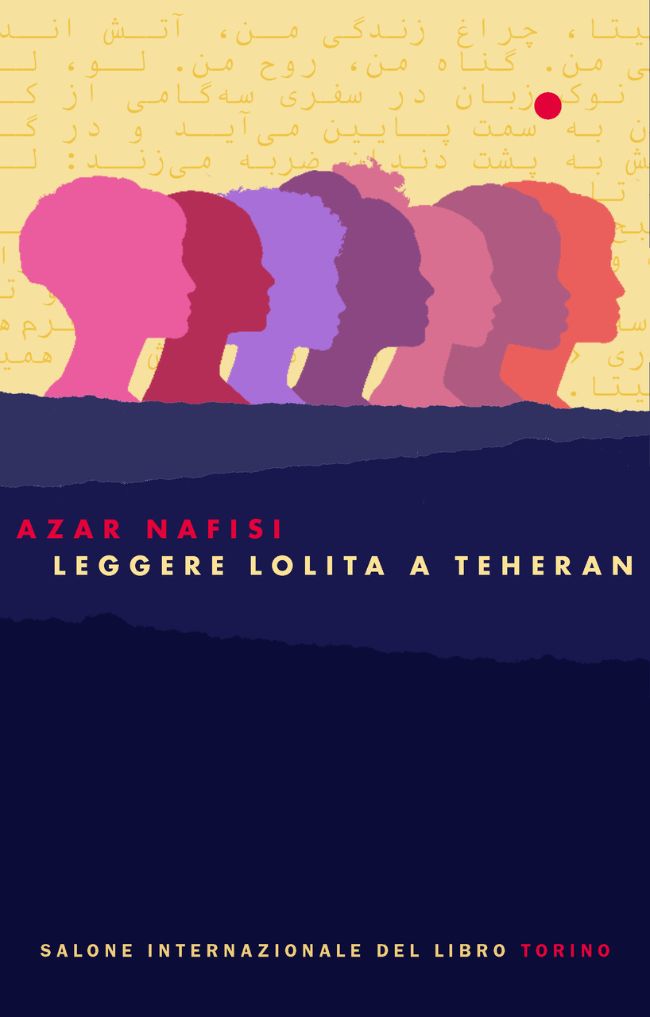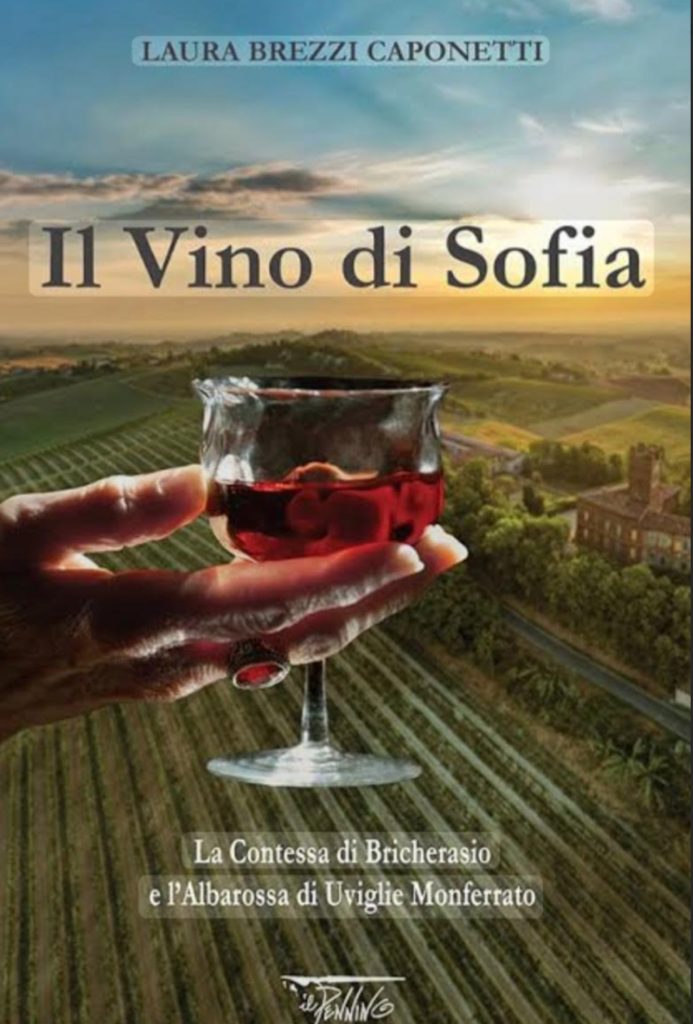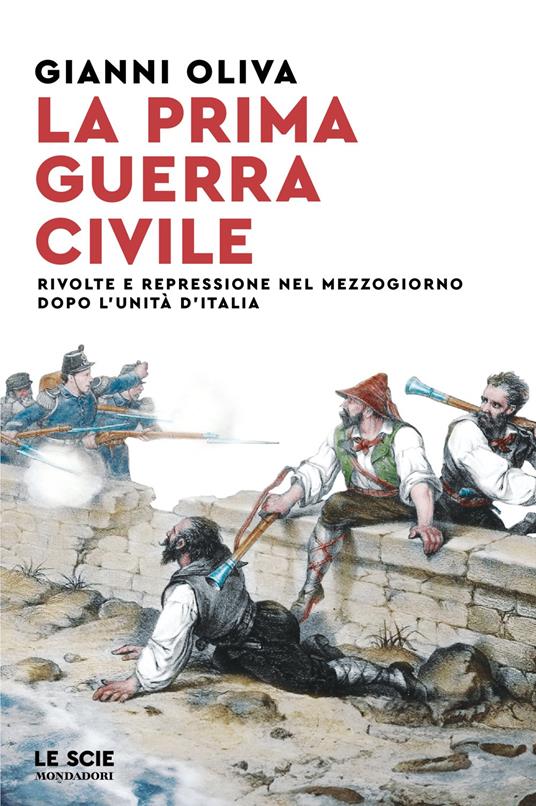Guardando tra i film in corsa per i premi finali
Primi giorni di TFF. Una decina di titoli del concorso già alle spalle. Siamo passati indenni in mezzo ad alcuni insulsi, qualcuno dalle troppe pretese, altri inconcludenti, tra le varie cinematografie che ci arrivano da mezzo mondo. Ancora non un panorama – sarà sempre impossibile farlo – di come vada il mondo, del cinema e quello reale, tra desideri di rivoluzioni e bambine cattive che girano per bordelli alla ricerca dei soldi che possano salvare da una maledizione, tra la delinquenza che è al continuo bisogno di denaro facile e che tiene a bada autisti costretti ogni notte a trasportare ragazze, tra illusioni che si disperdono per le strade difficili di qualsiasi età, tra le colpe del destino che possono scombussolare la vita di chiunque, a qualsiasi latitudine: c’è la consapevolezza dell’errore, c’è l’obbligo a campare, a trascinare la propria esistenza e quella degli altri, c’è il grande pianeta del sogno, che pare accogliere tutti, una fuga o un viaggio lontano, da soli o con gli amici, non importa dove, c’è la continua lotta, personale, tra la legge scritta e quella immaginata. C’è un titolo che sinora robustamente convince, arriva dall’Estonia, s’intitola “Mo Papa” e a dirigerlo è una giovane regista, Eeva Mägi, non ancora quarantenne, due anni fa ha dato vita a “Mo Mamma” vincendo numerosi premi, tra cui quello della Fondazione estone come miglior giovane regista. La storia che presenta al TFF è il suo secondo lungometraggio. Chissà se la rivedremo.
Non ancora trentenne, Eugen, che esce di prigione dopo aver scontato dieci anni per la morte accidentale del fratello minore (una tragedia in seguito alla quale la madre è morta suicida), fatica a rimettersi fra la gente e dentro la città. Suo padre, per lui un estraneo colpevole d’averlo abbandonato con il fratello e fatto crescere in un orfanotrofio, oggi ripara orologi, chiuso in quel negozio che è laboratorio e casa (ne esce soltanto per inserirsi nel coro della chiesa, che è tutta luci e gente composta e belle voci), con nessuna volontà di riprendere un misero straccio di rapporto (nel suo cellulare, al suono sotto la voce Eugen, s’inserisce una segreteria che offre le situazioni delle temperature dell’intero paese); poi due amici, Stina e Riko, che non se la passano bene di certo, nella mente e nel corpo. La neve e il mare ghiacciato, le corse in tram, i lavori saltuari necessari a sopravvivere, il timido tentativo a formare una coppia, un gruppo di balordi che lo vorrebbero spingere a rimettersi nel buio di prima, fuggire da tutto e sognare il sole del Brasile: ma ogni cosa è un tentativo, una solitudine, il rapporto principale si sfalda ancor prima d’iniziare, è autodistruzione, è la grande solitudine la notte di capodanno, tra i fuochi d’artificio. E dopo che sarà? I primi silenziosi quindici minuti, le riflessioni, i pochi dialoghi (ma non costruiti sul precipizio del vuoto, come in questi giorni già s’è visto), gli affetti e le urla, la forza del corpo come liberazione, le piccole ribellioni, tutto esce dalla macchina da presa (e dalla scrittura, prima) di Eeva Mägi con grande intelligenza e umanissima partecipazione, cogliendo il trauma e i particolari, i comportamenti, le intenzioni e i deboli risultati, tutto ricavato da esperienze di persone conosciute: “Questo film è per loro. È grezzo, non rifinito, ma profondamente umano: non l’ho fatto in modo meticoloso, ma collaborando in modo autentico con altre persone e condividendo una fede profonda.” Istintivo, urgente, libero, come il suo cinema, che “non ha bisogno di grandi budget o anni di perfezionismo”, io direi anche autenticamente sincero.
E poi? In coproduzione Argentina/Perù, Luciana Piantanida, arrivata anche lei al suo secondo lungometraggio, in 69’ rabbercia la storia di Marlene che si prende cura di una vecchia signora e che trova il tempo, in special modo nelle ore notturne, di girovagare per la città a indagare sulla fine di una vecchia amica con cui da giorni non riesce a mettersi in contatto. La scomparsa parrebbe condurre al macrocosmo delle tante nazionalità, al mondo del lavoro notturno, dei lavori sottopagati, sino a incontrare altre donne che hanno sviluppato dei superpoteri. Si vorrebbe parlare di rapporti tra datori di lavori e badanti, della vecchiaia e della morte, di valori extrasensoriali che arrivano inattesi e anche un po’ ridicoli, il film nella volontà di Piantanida aspirerebbe a essere un poliziesco “ma non ha poliziotti”, o “a suo modo fantastico”, salvo poi correre nel sociale, rivendicando la volontà “di affrontare un tema sociale da una prospettiva il più possibile umana”. Uscire dalla sala e sentirsi colpevole di non aver saputo afferrare da che parte ci volesse portare la regista. Da nessuna?
Fantasiosa anche la ragazzina di dieci anni che – il film ha doppia bandiera slovena e croata – è convinta di poter impedire la morte della nonna entrando nel coro della scuola (che non sia, il coro, un punto di rifugio privilegiato di questi tempi?), padre zoticone e mamma che fa le valige per andare a sentire i propri desideri da altre parti, le compagne di scuola che non sono certo delle beatitudini per tutti i giorni e le insegnanti che tracannano o menano ceffoni. Il film è firmato dalla trentenne o poco più Ester Ivakič, di Nova Gorica, laurea e ulteriori studi e menzioni a rassicurazione nostra, il titolo chilometrico (alla Wertmüller, per intenderci) “Ida che cantava così male che persino i morti si sono alzati e si sono uniti a lei nel canto”: puff! Una solitudine infantile attraverso cui “raccontare quello spazio che si crea tra la leggerezza della vita quotidiana e la presenza silenziosa e dolorosa di una perdita inevitabile”: nulla da ridire sul solito rifugio che da qualche parte dobbiamo pur trovare, questa volta “nell’immaginazione, nel gioco, nella solitudine”, alla ricerca di quella sicurezza che sembra essere negata. Ma come sempre quella ricerca va “riempita”, di azioni, di pensieri, di suggestioni, di dialoghi che lascino all’interno del racconto qualche segno, non lasciata alla troppa discrezione o all’incapacità magari di produrre una affascinante compiutezza.
Nella nostra personale e quotidiana bulimia, ancora eterni temi di ieri e di oggi si rimpallano all’interno di “La anatomìa de los caballos” (produzione Perù/Spagna, lungometraggio d’esordio del peruviano Daniel Vidal Toche. La storia del rivoluzionario Angel, immaginario (?) personaggio del XVIII secolo, che sconfitto dai nemici, si rifugia nel villaggio natale per ritrovarsi proiettato nei monti andini della nostra epoca, brulli e inaccoglienti: accidente misterioso provocato da un meteorite che, cadendo in quei luogo, ha creato un varco tra le due diverse epoche. Per lui, tra lo scalpitìo dei cavalli e il rumore di una locomotiva, ci sarà l’incontro con Eustaquia, che è alla ricerca della gemella scomparsa durante la lotta contro una compagnia mineraria: un incontro che li porta a un’unica domanda: qual è il senso della rivoluzione, oggi, contro cosa e per chi dobbiamo combattere? Potere e prevaricazione hanno colpito e continuano a perseguitare sempre le medesime persone ma vale continuare a combattere. “In Perù, come in tutta l’America Latina, ci sembra di ricominciare sempre dallo stesso punto, intrappolati in un ciclo che non si spezza”, sottolinea il regista: porta avanti le proprie rivendicazione lucidamente, e con mestizia, in certi momenti pare di tornare alle enunciazioni degli attori di Pasolini, ma il tutto, con il frazionamento delle azioni e con il posizionare la macchina da presa in modo inamovibile, dove l’azione si fissa con un sapore primitivo, non giocando di montaggio, si fa fermo e lento, quasi senz’anima, un interessante libro da leggere di cui a fatica si raggiungono le ultime pagine.
Elio Rabbione
Nelle immagini: scene da “Mo Papa” di Eeva Mägi (Estonia), “Ida che cantava…” diretto da Ester Ivakič e “La anatomia de los caballos” di Daniel Vidal Toche.