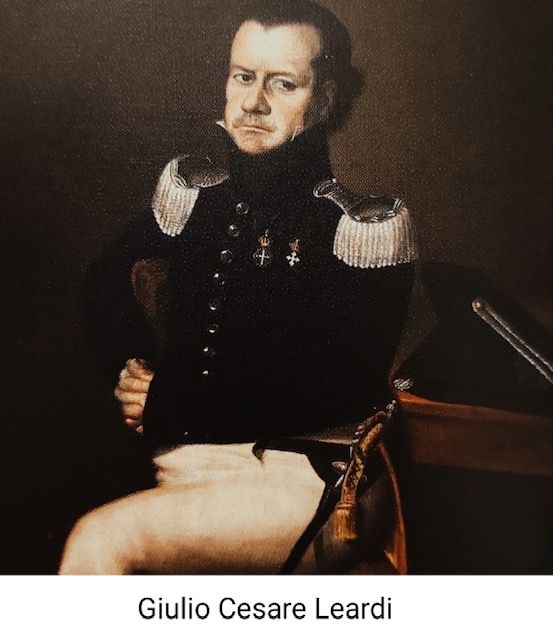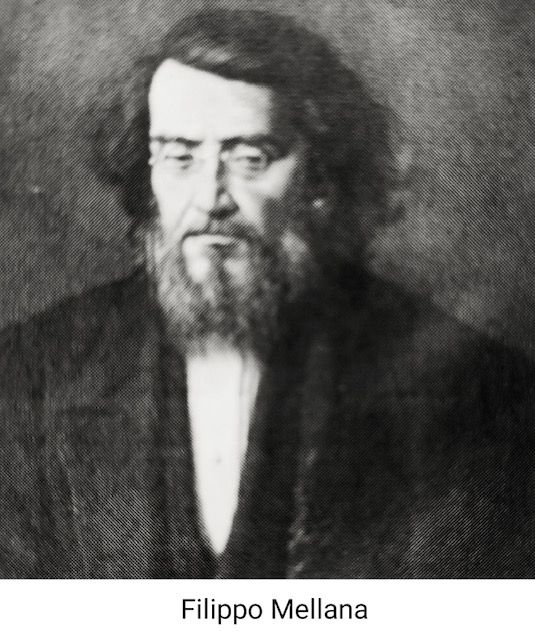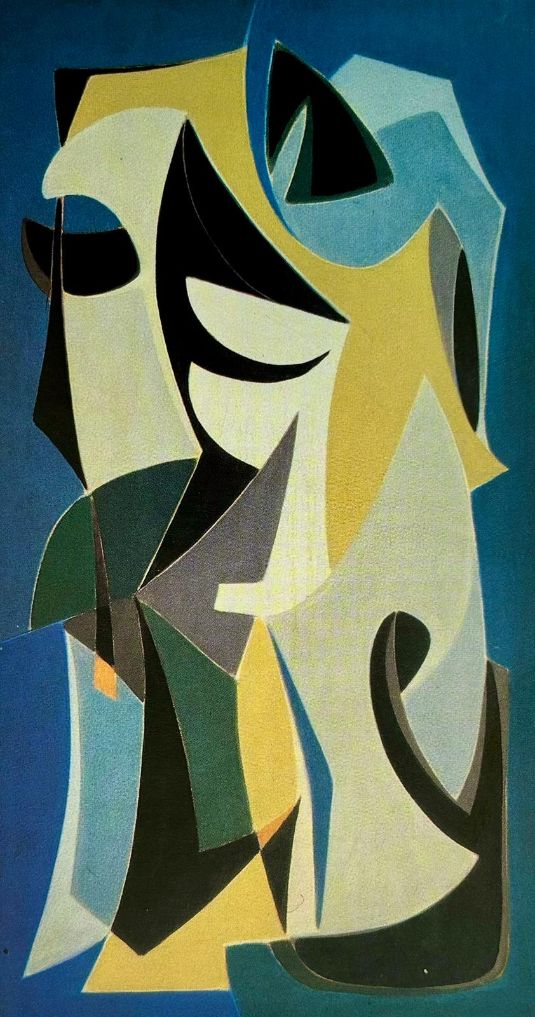La Fondazione Mirafiore, a Serralunga d’Alba, chiude l’anno con un dittico d’incontri che, pur provenendo da mondi lontani, condividono lo stesso intento: quello di leggere con sguardo critico e divertente il tempo in cui viviamo. Venerdì 19, alle ore 19, e sabato 20 dicembre, alle 18.30, la Fondazione porterà sul palco due protagoniste capaci di illuminare due realtà diverse, ma ugualmente decisive: da un lato la Cina contemporanea, raccontata da Giada Messetti, dall’altro il viaggio nel cielo guidato da Patrizia Balbo.
Parlare di Cina significa parlare anche di noi. Nel suo ultimo libro “La Cina è un’aragosta”, edito da Mondadori, Giada Morsetti, ospite del teatro della Fondazione Mirafiore di Serralunga d’Alba, venerdi 19 dicembre alle ore 19, descrivere un Paese in piena mutazione, alle prese cin un cambiamento profondo che riguarda tanto la politica quanto la società. Il giovane, alle prese con nuove incertezze, le donne, che ridefiniscono il proprio ruolo, gli anziani che si riappropriano del tempo, le città che cambiano volto per segnare un cielo sempre più limpido sopra Pechino. Un’evoluzione che ha concrete conseguenze sull’Europa e sull’Italia, e che richiede uno sguardo libero da stereotipi e pregiudizi. Sinologa e divulgative, Giada Messetti restituirà un ritratto vivo e non ideologico della Cina di oggi, mostrando come il dragono stia incidendo sulla nostra vita. Perché la Cina, come ricorda il titolo dell’incontro, non è solo vicina, ma già qui.
Sabati 20 dicembre, alle ore 18.30, l’attenzione si sposterà dal presente globale al futuro personale e collettivo, con l’appuntamento guidato da Patrizia Balbo, una delle voci più autorevoli dell’astrologia contemporanea. La Fondazione propone un incontro che invita a interrogare il cielo, non per cercare risposte magiche, ma per comprendere quali energie accompagneranno l’anno che sta per iniziare e come possono diventare un sostegno nelle nostre scelte quotidiane. Divulgatrice, consulente, ideatrice di format innovativi che intrecciano astrologia, psicologia e creatività, Patrizia Balbo offrirà una lettura chiara e coinvolgente del 2026, mettendo in relazione i movimenti dei pianeti con i temi che potrebbero caratterizzare il nuovo anno sul piano emotivo, sociale e relazionale. Il suo approccio, rigoroso e contemporaneo, restituisce all’astrologia il suo valore culturale e interpretativo, capace di aiutare ciascuno a conoscersi meglio e a guardare al futuro con lucidità e fiducia.
Ingresso libero per entrambi gli appuntamenti – prenotazione dal sito fondazionemirafiore.it
Mara Martellotta