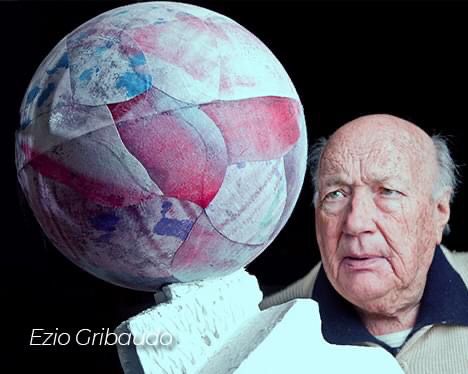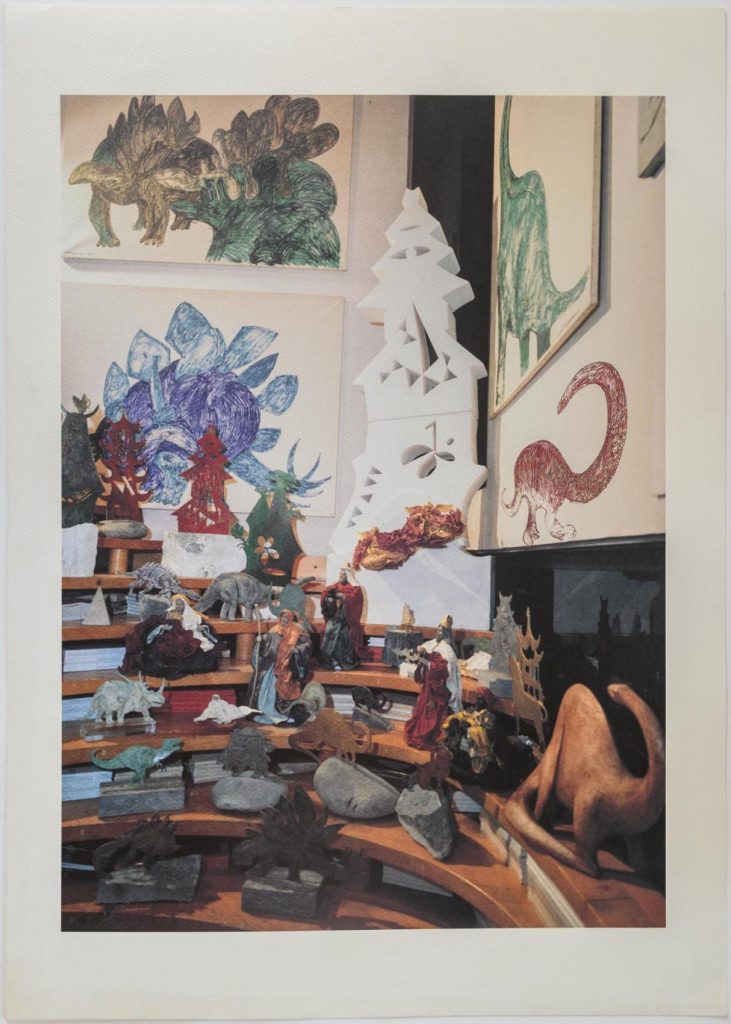Complottismo a teatro
Ispirato al libro di Wu Ming 1
Mercoledì 7 e domenica 11 dicembre
Per “fantasie di complotto” intendonsi “… quelle idee che riguardano una cospirazione universale, che ha come fine la conquista o la distruzione del mondo da parte di società segrete, confraternite occulte, ‘razze infide’ (…). Una cospirazione costantemente denunciata eppure sempre in pieno svolgimento, da decenni, da secoli”. Così l’attrice e drammaturga Debora Benincasa e la regista Silvia Marchetti spiegano il titolo e il messaggio del loro spettacolo, scritto a quattro mani, “Fantasie di complotto” portato in scena in anteprima nazionale, mercoledì 7 e domenica 11 dicembre (ore 21) allo “Spazio Kairòs”, ex fabbrica di colla ora trasformata in teatro, al civico 7 di via Mottalciata, a Torino. Lo spettacolo, ricordano ancora “racconta una storia contemporanea, in cui si intrecciano le difficoltà di ascoltare gli altri e sé stessi” e nasce grazie alla lettura di “La Q di Qomplotto” di Wu Ming 1, pseudonimo dello scrittore e traduttore ferrarese Roberto Bui, membro del Collettivo “Wu Ming” e del precedente “Luther Blissett”. Frutto di una proficua collaborazione fra due realtà teatrali, “Anomalia Teatro” e “Compagnia del Calzino”, la pièce vede protagonisti sul palco Debora Benincasa e Marco Gottardello. Lui ha una vita soddisfacente: una casa di proprietà, un lavoro a tempo indeterminato (in banca: cosa di meglio?) e una fidanzata. Eppure, la notte non riesce a dormire. Una vita come tante nella nostra società sempre più liquida e precaria, tesa a soddisfare aspettative difficili da mantenere (o da desiderare realmente) : sposarsi, guadagnare, mettere su famiglia…

“Camminiamo all’interno di un flusso continuo di informazioni, video, parole, immagini – spiegano ancora le autrici. Così, diventa sempre più difficile distinguere un articolo da una pubblicità, le false informazioni da quelle vere. Ciò che desideriamo da ciò che è desiderato per noi. Rimane solo un orologio che continua a ticchettare la notte: puoi definirti felice?”.
E proseguono: “Ci è sempre sembrato che il modo comune di parlare dei movimenti complottisti fosse estremamente denigratorio e a volte addirittura violento. Crediamo che questo tipo di narrazioni, volte a ridicolizzare gli individui che finiscono all’interno di questo tipo di pensieri, sia dannoso e nocivo e crei solo più distanza e rabbia”. Quale allora l’Obiettivo del vostro testo teatrale? “Quello di rendersi conto– precisano – che le risposte complottiste, come tutte le fantasie, fanno parte della nostra società, è il nostro modo di vivere stesso a crearle e accrescerle. In un mondo sempre più difficile e complesso, retto da un potere finanziario mascherato e dematerializzato, le fantasie di complotto danno invece risposte semplici e nemici specifici a cui dare la colpa. Con questo spettacolo, quello che speriamo, è che si possa arrivare a prendere atto della facilità con cui chiunque può cadere nella tana del bianconiglio, non cerchiamo di dare risposte ma solo di aprire delle possibilità”.
Una sorta di attesa fra domanda e risposta. Al cui interno si sviluppa il pensiero.
g.m.
Nelle foto: Debora Benincasa e Marco Gottardello in scena



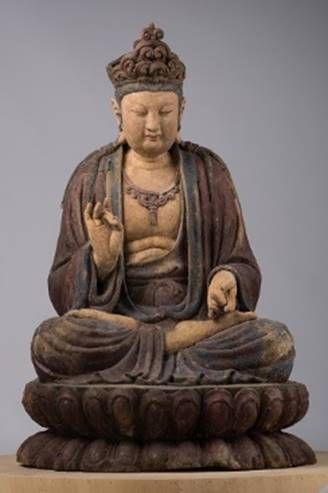







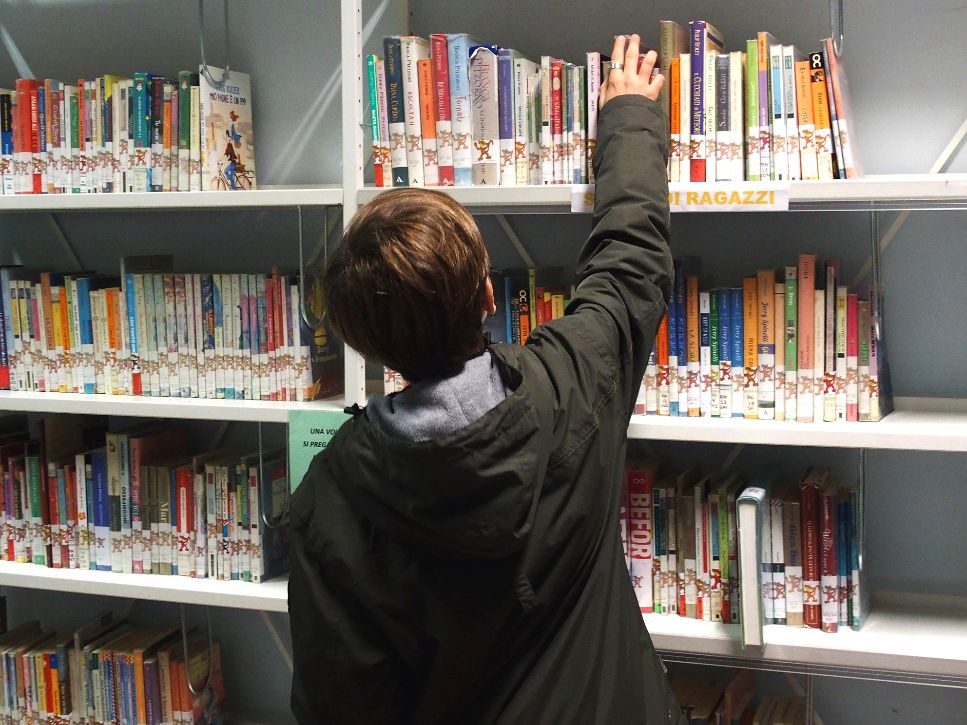
 Rubrica settimanale a cura di Laura Goria
Rubrica settimanale a cura di Laura Goria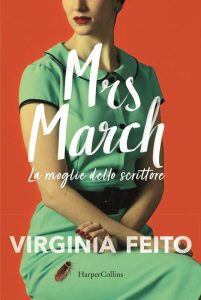 psicologico. Perché per puro caso viene a sapere che tutti pensano che la protagonista del libro di Charles sia lei. Onore o disgrazia?
psicologico. Perché per puro caso viene a sapere che tutti pensano che la protagonista del libro di Charles sia lei. Onore o disgrazia?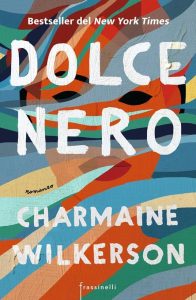 Siamo in California nel 2018, Eleanor -originaria di un’isola caraibica- prima di morire ha lasciato un lungo messaggio vocale che l’avvocato di fiducia deve fare ascoltare ai figli con i quali il legame si era sfilacciato da tempo.
Siamo in California nel 2018, Eleanor -originaria di un’isola caraibica- prima di morire ha lasciato un lungo messaggio vocale che l’avvocato di fiducia deve fare ascoltare ai figli con i quali il legame si era sfilacciato da tempo.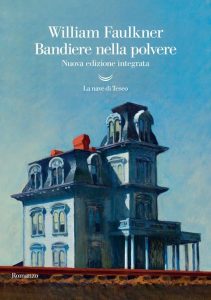 Ora torna in libreria in un’edizione in versione integrale e nuovamente tradotto, grazie all’attenzione della casa editrice “La nave di Teseo”, alla quale va il merito di riaccendere i riflettori sullo scrittore che seppe cantare l’America del profondo sud, degli anni della depressione, attraverso un imponente affresco familiare.
Ora torna in libreria in un’edizione in versione integrale e nuovamente tradotto, grazie all’attenzione della casa editrice “La nave di Teseo”, alla quale va il merito di riaccendere i riflettori sullo scrittore che seppe cantare l’America del profondo sud, degli anni della depressione, attraverso un imponente affresco familiare.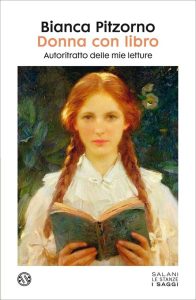 In queste tenere e colte pagine, la scrittrice 80enne -autrice televisiva e traduttrice- compone un memoir che la riporta bambina; alle prime letture, poi via via lungo il percorso della sua esistenza.
In queste tenere e colte pagine, la scrittrice 80enne -autrice televisiva e traduttrice- compone un memoir che la riporta bambina; alle prime letture, poi via via lungo il percorso della sua esistenza. Giallo, love story, riflessione sugli avvenimenti dell’ultimo decennio, dalla Brexit alla pandemia di Covid: questi sono gli ingredienti principale del romanzo del corrispondente da Londra per la Rai, volto noto e tra i giornalisti più esperti della “perfida Albione”.
Giallo, love story, riflessione sugli avvenimenti dell’ultimo decennio, dalla Brexit alla pandemia di Covid: questi sono gli ingredienti principale del romanzo del corrispondente da Londra per la Rai, volto noto e tra i giornalisti più esperti della “perfida Albione”.