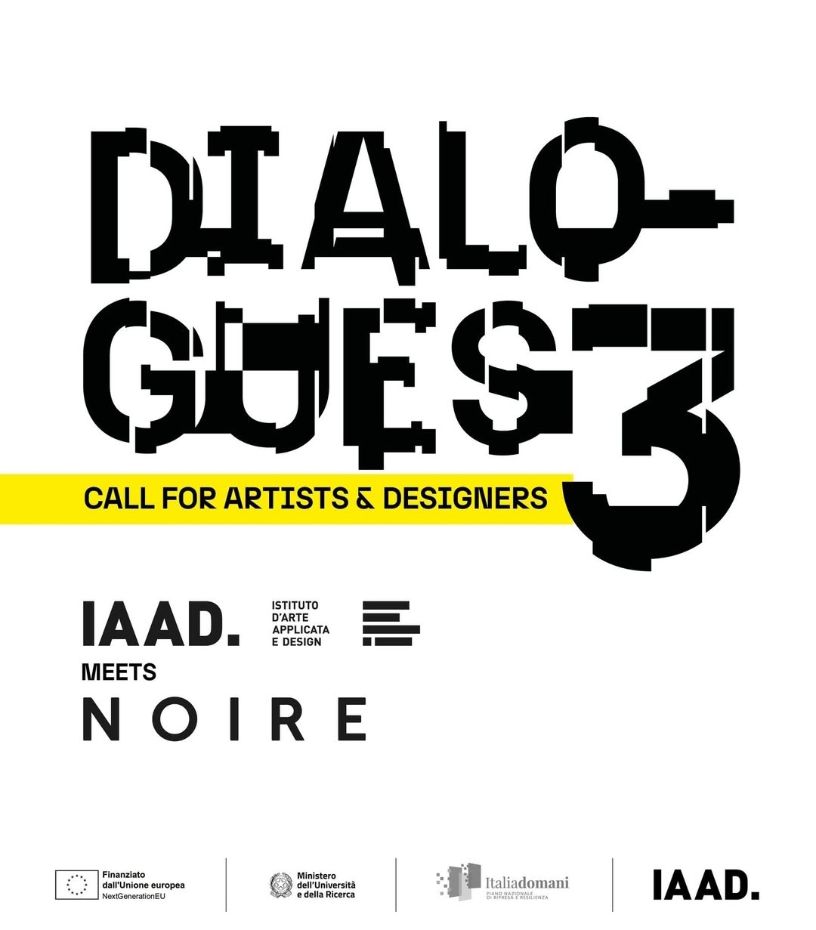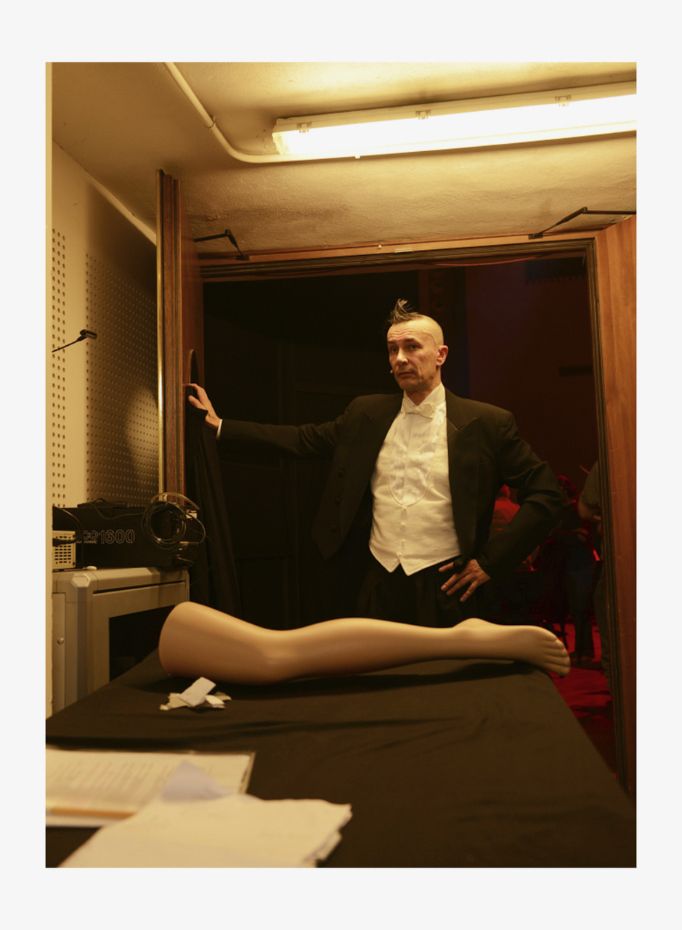Domenica 28 dicembre alle ore 10.30
Alla Fondazione Torino Musei, domenica 28 dicembre alle 10.30, si terrà la visita alla mostra “Notti. Cinque secoli di stelle, sogni e pleniluni”, che si trasforma in un viaggio speciale tra arte, scienza e pura immaginazione. Il percorso consente di esplorare come il buio, le stelle, la luce abbiano affascinato gli artisti per secoli, passando dai cieli osservati da Galileo fino alle intense visioni romantiche. Dai sogni più misteriosi fino alle opere contemporanee. È una narrazione suggestiva che svela la bellezza della notte, fatta di bagliori, riflessi, lune e luci che irrompono nell’oscurità. Dopo l’immersione nella mostra, l’esperienza prosegue nell’educational are, dove grandi e piccoli saranno protagonisti di un lavoro creativo dedicato alla luce notturna. Ogni bambino, con la sua famiglia, realizzerà una piccola creazione luminosa da portare a casa come un ricordo unico. Questa è un’occasione irripetibile per giocare insieme e condividere. L’età consigliata è dai 3 ai 5 anni. Il costo a partecipante è di 10 euro, il costo aggiuntivo per gli adulti è rappresentato dal costo del biglietto ridotto, gratuito per i possessori della carta Torino Musei.
Mara Martellotta