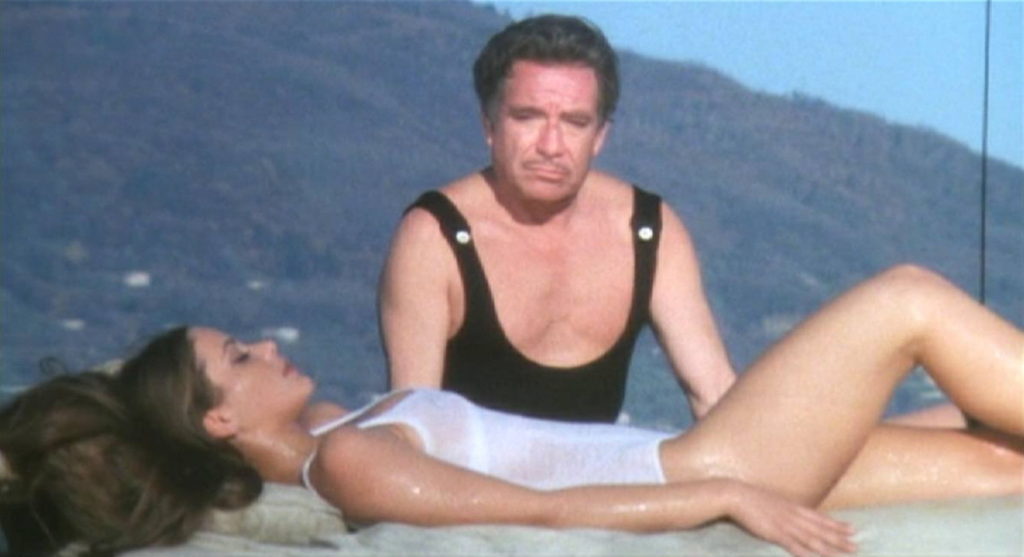Un piatto unico appagante e sfizioso
Gli hamburger fatti in casa sono perfetti per un piatto unico appagante e sfizioso. Genuini e privi di conservanti si preparano velocemente, pochi semplici ingredienti di qualita’e un risultato perfetto. Elemento principale la carne di “fassone” tenera, succulenta e saporita, apprezzata da tutti.
***
Ingredienti :
500gr. di carne tritata di “fassone”
1 cipolla media
2 tuorli
Sale e pepe q.b.
3/4 panini da hamburger
***
Stufare la cipolla affettata sottilmente con una noce di burro e un pizzico di sale. In una ciotola impastare a mano la carne tritata con il sale, il pepe, i due tuorli e la cipolla stufata. Formare i medaglioni di carne (con questa dose ne vengono 3 o 4, dipende dallo spessore) e cuocerli sulla piastra pochi minuti per parte. Tagliare i panini e tostare la parte interna in padella. A piacere spalmare un velo di senape sul pane, disporre la carne e completare con una fetta di pomodoro e una foglia di insalata verde. Servire con croccanti patatine fritte. Altro che fast food!
Paperita Patty