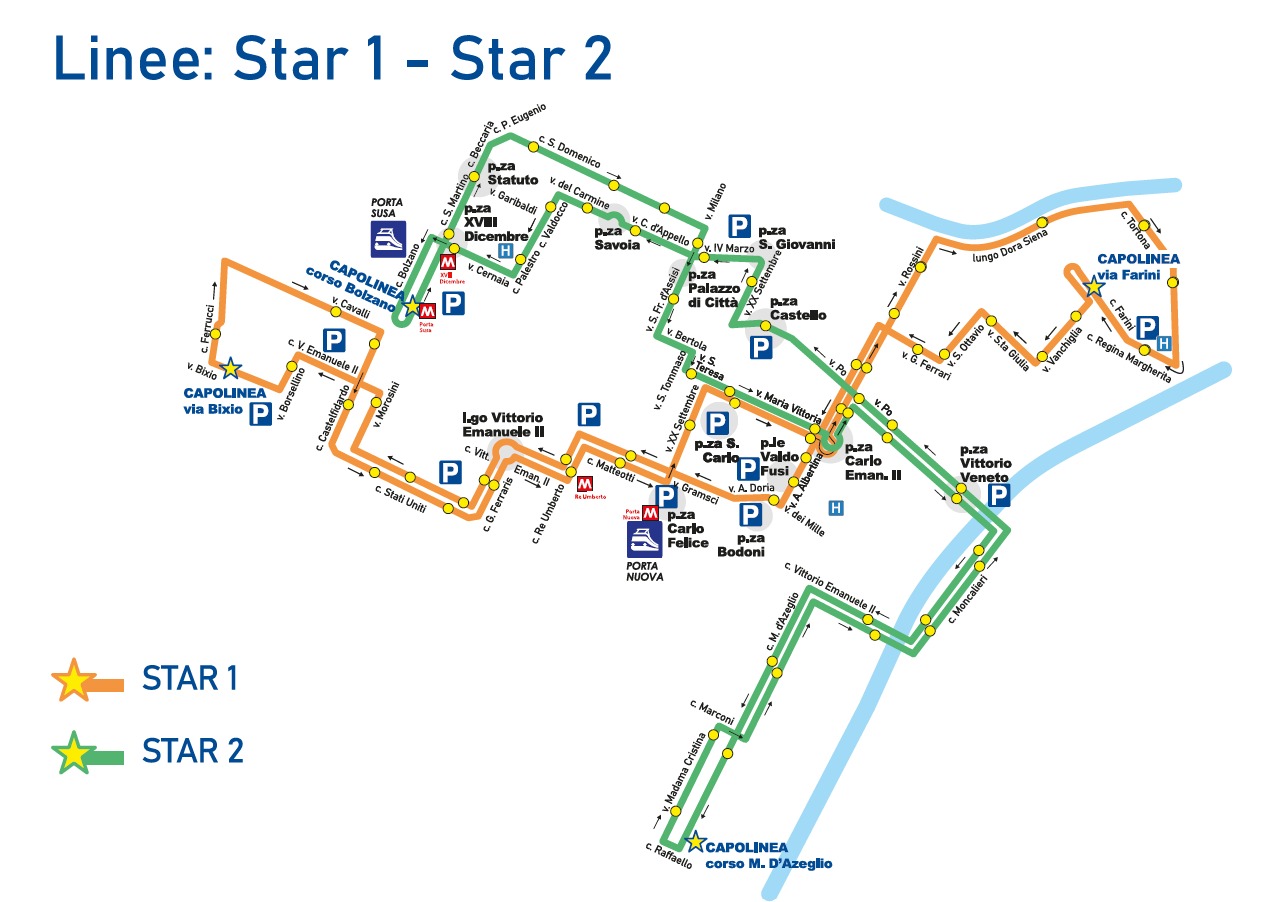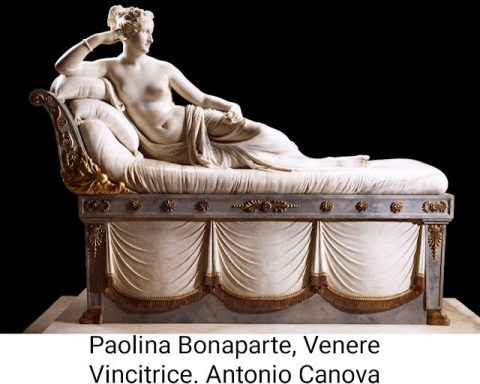Per la stagione dello Stabile, al Carignano sino al 14 dicembre
“Leggendolo, mi convinco una volta di più che non sono un drammaturgo.” Definitivo, brutale e pessimista, sino in fondo. E dire che, nell’autunno del 1895, scrivendo all’amico Aleksej Suvorin – magnanimo editore delle sue opere, un rapporto che durò una quindicina d’anni e che s’affievolì all’epoca dell’affare Dreyfuss per le differenti posizioni prese -, era partito fiero, col piede giusto, forgiato di ogni sicurezza: “Figuratevi, sto scrivendo un testo teatrale, sarà pronto non prima di novembre. Scrivo con gusto, anche se mando all’aria tutte le buone regole. È una commedia, ci sono tre parti femminili, sei maschili, quattro atti, un bel paesaggio (vista sul lago), molti discorsi sulla letteratura, poca azione, un quintale d’amore.” Una quintalata, e anche qualche grammo in più, che continua inevitabilmente ad abitare questa edizione del “Gabbiano” sulla cui protezione è calato un buon numero di Teatri Stabili e Teatri Nazionali, del Veneto – del quale il regista Filippo Dini da due anni è direttore -, Torino, Roma, Bolzano e Napoli, quintalate d’amore che avvolgono quel gruppo d’amici e parenti che vengono a occupare le stanze della villa dell’attrice Irina Arkadina, sulle rive di un grande lago, dove suo figlio Kostja, senza troppa convinzione del suo pubblico tenterà d’inscenare una sua breve composizione teatrale che piacerà quasi a nessuno: chiaro che il ventenne pieno di ribellione dentro il cuore e il cervello s’inferocisca mica poco, reclamando “nuove forme” di teatro, scalpitando contro una società abbarbicata su canoni antichi e che non vede più in là del proprio naso. Dini è come Kostja, anzi Dini “è” tout court Kostja. Ormai obbediente a quella fregola registica di porre azioni e attori dentro il contemporaneo, comincia con l’affidare, all’interno del primo atto, il testo di Kostja e la recitazione della giovane Nina, quasi fidanzatina che sfrigola a ogni istante, allo sguardo ribelle di Leonardo Manzan, controcorrentissimo, astruso e assurdo, strampalato e all’insegna del “famolo strano” a tutti i costi, sul sentiero di una moda che sta prendendo il posto di altre mode (forse): dopo che il triste e angry man aveva steso il proprio “manifesto” (per diretta definizione della madre) con un giro panoramico sul teatro del Novecento che senza batter ciglio citava e commentava Brecht ed Eduardo, con accenno musicale di “che gelida manina”.
Malinconia ma neppur tanta, arrivi e partenze, l’esistenza stracca, una sorta di forzata allegria e falsa spensieratezza a serpeggiare, il riconoscibile andare alla deriva di uno scampolo d’umanità che stava per buttarsi in braccio a rivoluzioni e guerre, sulle direttive del signor Cechov che reclamava sulle locandine il termine “commedia”, e poi noia tanta noia, e inseguimenti amorosi a perdifiato giù lungo i 150’ dello spettacolo, con lo squattrinato Medvedenko, spuntato dal nulla ad inizio spettacolo per cantare come un Rino Gaetano de noantri una canzone d’amore alla sua bella che più a squaciagola non si potrebbe, che ama Maša che insegue Kostja, il quale sogna disperatamente Nina – “d’amore si muore”, avrebbe detto Patroni Griffi qualche decennio dopo -, che sì all’inizio un pensierino ce lo farebbe ma che poi è catturata dal vortice che raccoglie il suo desiderio d’attrice e il successo dello scrittore Trigorin, che di professione fa l’uomo usa e getta, a secondo dei tempi e della bisogna, che da Irina è inseguito, senza dimenticare mamma Polina che ha un debole per il dottor Dorn. Un girotondo infinito, che si stacca e si ricompone, discorsi di letteratura e di spicciola filosofia quotidiana, due colpi di rivoltella, uno che fa il danno di un graffio e l’altro che porta alla morte. Su ogni azione, sui dialoghi caparbiamente urlati, sui tratti e il susseguirsi delle azioni a volte inverosimili costruiti a spintoni, c’è la mano di Dini, di gran lunga più accettabile nel suo primo Cechov che fu pochi anni fa “Ivanov”. Una regia sfrontata, dedita alla più forte esasperazione, urlata, votata allo stravolgimento – volontà del tutto registica – di tutto quel cecovismo che abbiamo visto in questi decenni: ferma restando in chi scrive la convinzione che non è certo onesto “trafugare” un testo al proprio legittimo proprietario e che, quando in un paio di ispirati momenti la stessa regia ritorna nell’alveo, è in quei momenti che ci si rifugia nella giusta ispirazione.
Forse Dini s’è voluto bellamente dimenticare che, pur nella ricerca della novità, entro cui spunta oggi quella necessaria quanto insondabile figura teatrale che è il dramaturg, pronto a essere cacciato a viva forza in ogni “rivisitazione” o “rilettura” alla moda (qui ha il nome di Carlo Orlando), sarebbe necessario il vecchio, oraziano, “est modus in rebus”, la misura, l’equilibrio, la negazione degli eccessi, il ponderare con acume fin dove spingersi. Magari non far diventare “il gabbiano” quasi un musical, con quelle canzoni, disinvolte e struggenti con tanto di microfono, spingendosi sino a quel capolavoro che è l’Oscar “Skyfall”, targato 007, per la voce di un’Adèle che non è neppure avvicinabile – ma, per carità, non era certo quello il fine, non siamo ancora arrivati ai “tali e quali” del signor Conti; magari, nella rabbia e nel disfacimento esistenziale del momento di Maša, non obbligare la povera Enrica Cortese, con i suoi tratti di borgatara pur essa arrabbita, a farsi una sputacchiera di pezzi più o meno sminuzzati di mela, sulla faccia del grande scrittore; magari non regalare alla Nina (che è una Virginia Campolucci a suo modo credibile) la patente di instabile permanente, magari soprattutto non regalare a Trigorin l’errore più vistoso della serata. Agghindato, come molti altri, nei costumi di Alessio Rosati – la scena fatta di sdraio computer albero spoglio e fondale lacustre e tetro, di Laura Benzi, essenziale prigione a specchio – più adatti a uno spettacolo da circo che a una commedia russa, Dini, al limite della caricatura, fa del suo antipaticissimo scrittore un rintontonito e balbuziente essere, eccessivo, bambinesco nei gesti, di cui difficilmente riusciamo a immaginare la scalata al successo, l’ingresso nei salotti, gli assatanati innamoramenti di due donne: semplicemente difficile. I più compos sui paiono la Irina di Giuliana De Sio (sebbene paia messa un po’ a lato, ben altra per forza nelle immagini di madre di “Agosto a Orage County” di Tracy Letts e “Cose che so di essere vere” di Bovell, passate nelle scorse stagioni sullo stesso palcoscenico del Carignano, in altri tempi cavallo di battaglie per le grandi attrici), gretta, autoritaria e vuota, tutta impegnata a raccontare di veri o presunti successi, fatta di tanti “amore della mamma”, e il Kostja di Giovanni Drago, che gira in lungo e in largo come una farfalla impazzita e si sbraccia in sparate sacrosante, animoso, eroe di breve durata chiuso nel suo lungo pastrano, passionale e intimamente più che sfrontatamente chiuso nella propria rivoluzione, purtroppo uno dei pochissimi fattori che ci abbiano convinto la sera della prima. Repliche sino 14 dicembre.
Elio Rabbione
Nelle immagini di Serena Pea, alcuni momenti dello spettacolo.
Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE