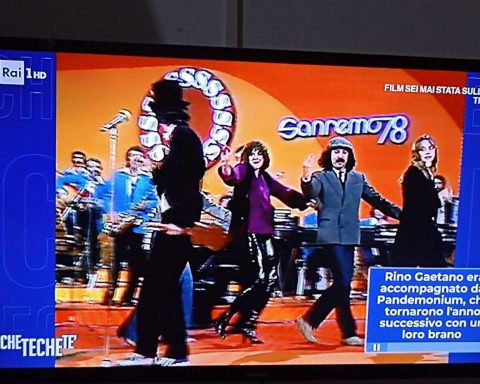Il testo di Bryony Lavery sul palcoscenico del Gobetti, sino a domenica 10 aprile
C’è un grumo rosso (come quello che attraversava l’orrore del ghetto di Cracovia sotto l’occhio in bianco e nero di Steven Spielberg in “Schindler’s List”, la bambina tragicamente smarrita e avvolta nel suo cappottino) sul palcoscenico del Gobetti che fino a domenica 10 aprile ospita “Ghiaccio” dell’autrice inglese Bryony Lavery, nella traduzione di Monica Capuani e Massimiliano Farau e messo in scena da Filippo Dini. È l’impermeabile della piccola Rhona, una Cappuccetto Rosso che non è uscita dalla penna dei Grimm ma che è travolta e immersa nell’orrore del nostro quotidiano, che mentre portava alla nonna un paio di cesoie da giardino ha incontrato il lupo cattivo, Ralph, un pedofilo, uno stupratore e killer seriale di bambine e ne è rimasta sopraffatta.

Il testo della pluripremiata (dopo il debutto nel 1998 al Birmingham Repertory Theatre) Lavery – che nel 2019 “The Indipendent” incluse nella sua classifica dei 40 testi teatrali migliori mai scritti – non è una favola, non è neppure l’amaro resoconto di un caso realmente avvenuto pochi o più anni fa, è un raggrupparsi di tante storie diverse, di attimi neri catturati qua e là, laceranti e sconvolgenti, che si raccolgono nella disperazione di una madre, Nancy, e nella distruzione di una intera famiglia, nella tragedia in cui si dibatte il mostro, nello scompiglio della sua mente criminale, nella esistenza angosciosa di una psichiatra americana di origini islandesi, Agnetha, che combatte con il ricordo della morte di un amico e che tra attacchi di panico tenta di portare avanti il proprio intervento, “Serial killer: si può perdonarli?”, e un personale studio secondo cui viene attribuito “a lesioni nei lobi frontali l’assenza di inibizione che induce comportamenti criminali”. Sottolineando che “il mio intervento è un esame critico delle differenze tra crimini frutto di malvagità e crimini frutto di patologia”.
Non soltanto questi tre personaggi. Non li vediamo in scena, ma ne avvertiamo la presenza, debolissima di Bob, il marito di Nancy, ben più presente quella di Ingrid, la figlia maggiore della coppia, attraverso le parole della madre un dolore che muta, che all’inizio affonda nella pretesa consapevolezza di una dolorosa sopravvivenza per poi passare ad una ribellione e al rifiuto di vivere nel culto della vittima, per affrontare un percorso buddistico, un viaggio verso l’Oriente all’inizio poco credibile, un misticismo di profonde radici che saprà liberarla dalle colpe che lei ha immaginato. Il risultato visivo sono quelle interminabili file di bandierine tibetane con cui Dini inonda nella conclusione la sala teatrale, multicolori, leggere, riappacificatrici. Due zone, un prima e un poi, per tutti. Le tre vite principali intrise di crimine e di vendetta, la determinazione a sopravvivere nel gelido stato, nel ghiaccio della conservazione, nel tentativo, nel mestiere di vivere: poi, dopo giorni mesi anni di disperazione e sempre eguali la scoperta del perdono da un lato, l’affrontare con il suicidio la propria cruenta realtà dall’altro. La vita riprendere a scorrere, non è più quella di prima ma porta finalmente con sé un alleggerimento, uno sguardo diverso, lo scioglimento di quel ghiaccio. La disgregazione in qualche modo si ricompone. “Ghiaccio” è uno spettacolo da vedere e applaudire, duro, di massima tensione, “crudele” nelle parole e negli atti, lo sguardo esatto da parte di Dini delle angosce dei personaggi, della disperazione, della morte dentro, che ci mette lucidamente di fronte ad una realtà troppe volte letta sui giornali o vista nei tiggì, in monologhi o in un dialogo aspro e faticoso e rotto, che riversa la propria ansia giù tra il pubblico, in un freddo labirinto inventato da Maria Spazzi, corridoi e plastica, sotto le luci improvvise o accecanti di Pasquale Mari. Uno spettacolo con tre spettacolari interpreti, che rendono appieno gli spasimi, i dolori, le incertezze, il cammino completo di Nancy, di Ralph, di Agnetha: Mariangela Granelli rende con una bravura rara ogni particolare del dolore e dell’inimmaginabile perdono di una madre, Filippo Dini concretizza la fragilità e il terrore come il rimorso del suo killer, Lucia Mascino disegna con magnifica convinzione i momenti di paura e il denso pensiero della sua psichiatra.

A proposito di perdono. Chi frequenti il cinema ricorderà un film del 2009 di Peter Jackson tratto dal romanzo omonimo di Alice Sebold, “Amabili resti”, dove la giovane protagonista Susie – come la Rhona della Lavery – è vittima del vicino di casa, che la violenta e la uccide. Si ritroverà a “sopravvivere” in un passaggio intermedio, tra il mondo terreno e il paradiso, ad osservare anche qui lo sfacelo della propria famiglia e le mosse dell’assassino. Considerate dopo le proiezioni di prova le reazioni degli spettatori, che considerarono le scene della morte del killer non troppo soddisfacenti e rivolte piuttosto ad un’agonia e ad una fine più cruda e atroce, Jackson s’impegnò a rifarle, “ho dovuto creare una scena di morte piena di sofferenza solo per dare alla gente la soddisfazione che desiderava”. Il perdono, in quell’occasione, rivolse gli occhi da un’altra parte. E non credo fosse soltanto pretesa spettacolarizzazione.
Elio Rabbione
Le immagini dello spettacolo sono di Luigi De Palma
Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE