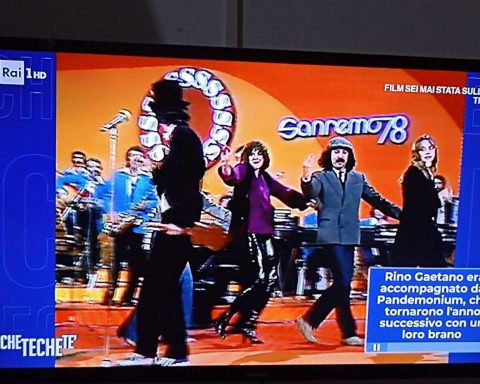PIANETA CINEMA di Elio Rabbione
PIANETA CINEMA di Elio Rabbione
Siamo all’inizio dei Cinquanta (il manifesto di Winchester ’73 ce lo dice), la macchina da presa inizia a scivolare sui corpi e sui visi che affollano Coney Island, sotto l’ombra della grande ruota che lascia intuire tutta la sua simbologia, mentre il bagnino belloccio Justin Timberlake, corifeo pronto a sostituire quanti in altre occasioni sono stati le voci favorevoli o contrarie, prende a narrare (ma la trovata si sfilaccia lungo la storia) dall’alto della sua postazione di salvataggio una storia che lo riguarda, un incrociarsi di quattro destini tra grandi sogni, molta noia, paure e piccole speranze senza sbocco. È il via alla Ruota delle meraviglie, puntuale appuntamento natalizio di un Woody Allen sempre più preda di bulimia cinematografica. Con l’antico risultato di un susseguirsi altalenante, di titoli che eccellono e di altri che cadono nella stanca ripetitività, di soggetti calibrati e di scritture frettolose. Su un versante che in questi ultimi anni ha dato decisamente un sicuro spazio alla componente “seria” del regista, dove non arrivano intellettualismi o situazioni con battute che preparano alla risata immediata, qui avverti il (tentativo del) capolavoro e allo stesso tempo uno scricchiolìo, un che di falsamente teatrale e forzato, un voler costruire delle vite come tutt’intorno si fa con le scenografie, posticce, che cadranno in un tempo brevissimo, ma lontano dalla realtà dolorosa che s’aggiustava come un guanto sulla Blanchett di Blue Jasmine o sul meccanismo del caso – la pallina indecisamente sulla rete – che colpiva le vittime e i carnefici di Match Point. Come pure le radici letterarie appaiono di sghembo, come tirate a forza nel gioco, i rimandi a O’Neill come a Tennesee Williams, mentre quest’ultimo era una cifra esatta per la Blanchett che tra menzogne e irrealtà s’aggirava nel mondo disturbato di Blanche Dubois.

Radici che sono nel cuore e nel futuro sperato di Mickey, un corso di drammaturgia per aspirare alla scrittura e ai palcoscenici della grande città. Anche all’amore, che pensa di trovare in Ginny, quarantenne, sempre pronta a rispolverare un passato di attrice, ridotta oggi a lavorare come cameriera in un piccolo ristorante e a tirare avanti senza sprazzi di felicità con un rozzo marito, Humpty, giostraio, una vita altrettanto grigia interrotta di tanto in tanto dal piacere di una gita a pesca con gli amici, che lei cerca di liberare dal vizio del bere e dalla violenza, e un figlio nato dal suo primo matrimonio che felicemente coltiva le manie dell’incendiario. A comporre il gruppo e ad annullare quella relazione che tra passione e insicurezza corre tra Ginny, inguaribile ultima Bovary di provincia in cerca di emozioni, e Mickey arriva Carolina (Juno Temple), la figlia di primo letto di Humpty, un rapporto interrotto da circa cinque anni dopo la fuga di lei con un piccolo ma quantomai sbrigativo gangster che adesso ha mandato due scagnozzi a cercarla per farla stare zitta, magari per sempre. Con il monologo di Ginny già nel sottofinale, tutto si sfalda, ritorna la noia, i sogni che tutti hanno coltivato dovranno lasciare il posto al grigio del giorno dopo giorno.

Allen allinea ancora una volta i temi che gli sono cari, le certezze cancellate in un baleno, gli uomini e le donne che inseguono i propri sentimenti ma che subito se li vedono scivolar via, si affida alla fotografia di Vittorio Storaro, ora fredda ora – per Ginny – caldissima in quei tramonti ambrati, soprattutto guarda con sostegno a un James Belushi che forse non è mai stato così convincente e con affetto a Kate Winslet, protagonista efficace, chiusa nell’avvilimento di un’esistenza che non le ha mai regalato nulla e che nulla continua a regalarle, dura e fragilissima al tempo stesso: tuttavia resta il dubbio detto all’inizio, che quel troppo di teatrale, di sopra le righe, di enfatico, di volutamente costruito finisca con rubare autenticità e i naturali sentimenti e le giuste espressioni all’intera vicenda.
Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE