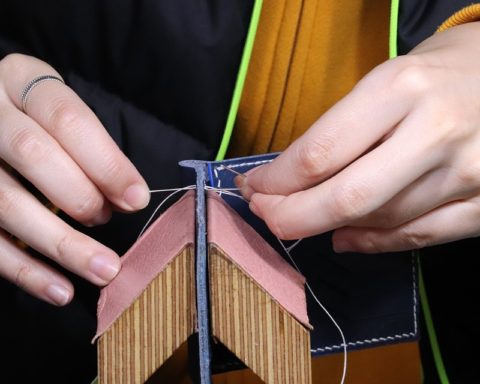Il “Macallè”, cioè Vanni Tagliaboschi, ha ereditato da suo padre – il “Negus” – una carbonaia in una valletta laterale della Vidabbia, poco sotto la vetta del Mottarone. Di carnagione scura , sembra un abissino nella stessa misura in cui l’aveva incarnato anche il padre, pure lui “nègar” anche se era originario di Sovazza. “Cosa volete farci, amici miei. Ho la pelle di mogano come un jazzista di New Orleans”, dice spesso il Vanni, con fine ironia, per motivare il colore ambrato, dovuto anche al fatto che la fuliggine gli è penetrata in ogni poro della pelle. Vestito con l’immancabile “toni”, la tuta blu da operaio, con tanto di “pettorina” e bretelle, passa una buona parte delle sue giornate a caricare il motocarro con i sacchi di juta zeppi di carbone. Le rimanenti le occupa a tagliar legna nei boschi. Una buona parte del carbone che commercia, ci tiene a farlo sapere, è “autarchico“, di “produzione propria“. “Roba di qualità, che la “brùsa” senza sprechi ed accidenti“, dice con tono fermo e convinto. Con i suoi due cugini , Pietro e Paolo, manda avanti l’attività della ditta con dedizione e professionalità. I due, detti i “santi” in ragione del nome e del carattere accomodante e disponibile, erano dei lavoratori instancabili. Da quando li conosco non li ho mai visti con le mani in
Il “Macallè”, cioè Vanni Tagliaboschi, ha ereditato da suo padre – il “Negus” – una carbonaia in una valletta laterale della Vidabbia, poco sotto la vetta del Mottarone. Di carnagione scura , sembra un abissino nella stessa misura in cui l’aveva incarnato anche il padre, pure lui “nègar” anche se era originario di Sovazza. “Cosa volete farci, amici miei. Ho la pelle di mogano come un jazzista di New Orleans”, dice spesso il Vanni, con fine ironia, per motivare il colore ambrato, dovuto anche al fatto che la fuliggine gli è penetrata in ogni poro della pelle. Vestito con l’immancabile “toni”, la tuta blu da operaio, con tanto di “pettorina” e bretelle, passa una buona parte delle sue giornate a caricare il motocarro con i sacchi di juta zeppi di carbone. Le rimanenti le occupa a tagliar legna nei boschi. Una buona parte del carbone che commercia, ci tiene a farlo sapere, è “autarchico“, di “produzione propria“. “Roba di qualità, che la “brùsa” senza sprechi ed accidenti“, dice con tono fermo e convinto. Con i suoi due cugini , Pietro e Paolo, manda avanti l’attività della ditta con dedizione e professionalità. I due, detti i “santi” in ragione del nome e del carattere accomodante e disponibile, erano dei lavoratori instancabili. Da quando li conosco non li ho mai visti con le mani in  mano, eccetto quelle rare volte che s’incontrano al circolo, la domenica pomeriggio, a farsi una briscola ed un “mezzino”. Ci danno l’anima, nel lavoro, nonostante la menomazione di Pietro che fatica di brutto a “caricare” il braccio destro dal giorno in cui gli è rovinata addosso la catasta della legna. Il fatto risale, più o meno, ad un paio d’anni fa e la colpa era tutta da addebitare al “Morello”, il mulo di Giacinto Guerla. Nell’ampia aia del suo cascinale, in Tranquilla, all’estremo nord di Oltrefiume, dove il “Macallè” accatastava i tronchi tagliati nei boschi che scendevano dalla Vidabbia all’alpe Scerèa e da lì fino alla vecchia casa del Salvatore, erano appena state scaricare alcune centinaia di quintali di rovere. La “pigna” era provvisoria, in attesa che – da lì a poco – i due cugini prelevassero un tronco alla volta per tagliarlo a pezzi con la sega circolare. L’attrezzo, rigorosamente fatto in casa, utilizzando un motore di una vecchia “Vespa” Piaggio 150 che forniva la forza motrice alla lama della sega, andava usato con grande cautela. L’Angelino “due dita“, che aveva lavorato per una decina d’anni con il padre di Vanni, ne sapeva qualcosa, essendosi “affettato” ben tre dita a causa della distrazione di un attimo. Il Guerla, che faceva l’allevatore in una cascina poco distante, era venuto lì per comprare un po’ di legna. Il suo “Morello”, pur essendo un mulo e come tale destinato a portar pesi, non era dell’idea di caricarsi quella legna sul basto. Si mise a tirar calci all’impazzata. Nonostante i tentativi di imbrigliarla , la bestia menava zoccolate a destra e manca. Fu così che la catasta, colpita dal mulo, rotolò addosso al povero Pietro che si fratturò una spalla oltre a “gibollarsi” tutto. A dispetto dell’essere un “santo” e del suo carattere si sfogò a male parola, chiamando in causa con l’ira di una furia tutti gli abitanti del paradiso. Comunque, incidenti a parte, quell’attività il Vanni ed i due cugini la mandavano avanti e non avevano nessuna intenzione di smettere. Ho notato, però, che con il passare del tempo, mi parla della vita dei boscaioli con un velo di tristezza. Come se, invecchiando, i ricordi – anche quelli più duri e aspri – s’addolcissero. Lasciando nelle parole una traccia di nostalgia. “ La nostra vita era sacrificata perché quello del boscaiolo era un mestiere duro. Ben più duro di com’è oggi . Il taglio dei boschi si faceva in autunno o in primavera. Sceglievamo sul posto gli alberi di alto fusto che, una volta tagliati, li portavamo a valle in spalla o trascinandoli sul sentiero con una corda legata ad un cugn da fèr, un cuneo di ferro piantato nel tronco. Quand’eravamo fortunati si poteva usare il palorcio, il filo a sbalzo: una piccola teleferica che faceva scivolare a valle il carico di legna“. Una volta preso l’abbrivio , il “Macallè” lascia correre la memoria come un fiume in piena. “Da noi ci chiamavano buscarò, in ossola e nei boschi della Val Grande “buratt”. Noi borradori, tagliatori di borre – che è la parte più pregiata del tronco, quella dritta, che serve per il legname da opera, siamo
mano, eccetto quelle rare volte che s’incontrano al circolo, la domenica pomeriggio, a farsi una briscola ed un “mezzino”. Ci danno l’anima, nel lavoro, nonostante la menomazione di Pietro che fatica di brutto a “caricare” il braccio destro dal giorno in cui gli è rovinata addosso la catasta della legna. Il fatto risale, più o meno, ad un paio d’anni fa e la colpa era tutta da addebitare al “Morello”, il mulo di Giacinto Guerla. Nell’ampia aia del suo cascinale, in Tranquilla, all’estremo nord di Oltrefiume, dove il “Macallè” accatastava i tronchi tagliati nei boschi che scendevano dalla Vidabbia all’alpe Scerèa e da lì fino alla vecchia casa del Salvatore, erano appena state scaricare alcune centinaia di quintali di rovere. La “pigna” era provvisoria, in attesa che – da lì a poco – i due cugini prelevassero un tronco alla volta per tagliarlo a pezzi con la sega circolare. L’attrezzo, rigorosamente fatto in casa, utilizzando un motore di una vecchia “Vespa” Piaggio 150 che forniva la forza motrice alla lama della sega, andava usato con grande cautela. L’Angelino “due dita“, che aveva lavorato per una decina d’anni con il padre di Vanni, ne sapeva qualcosa, essendosi “affettato” ben tre dita a causa della distrazione di un attimo. Il Guerla, che faceva l’allevatore in una cascina poco distante, era venuto lì per comprare un po’ di legna. Il suo “Morello”, pur essendo un mulo e come tale destinato a portar pesi, non era dell’idea di caricarsi quella legna sul basto. Si mise a tirar calci all’impazzata. Nonostante i tentativi di imbrigliarla , la bestia menava zoccolate a destra e manca. Fu così che la catasta, colpita dal mulo, rotolò addosso al povero Pietro che si fratturò una spalla oltre a “gibollarsi” tutto. A dispetto dell’essere un “santo” e del suo carattere si sfogò a male parola, chiamando in causa con l’ira di una furia tutti gli abitanti del paradiso. Comunque, incidenti a parte, quell’attività il Vanni ed i due cugini la mandavano avanti e non avevano nessuna intenzione di smettere. Ho notato, però, che con il passare del tempo, mi parla della vita dei boscaioli con un velo di tristezza. Come se, invecchiando, i ricordi – anche quelli più duri e aspri – s’addolcissero. Lasciando nelle parole una traccia di nostalgia. “ La nostra vita era sacrificata perché quello del boscaiolo era un mestiere duro. Ben più duro di com’è oggi . Il taglio dei boschi si faceva in autunno o in primavera. Sceglievamo sul posto gli alberi di alto fusto che, una volta tagliati, li portavamo a valle in spalla o trascinandoli sul sentiero con una corda legata ad un cugn da fèr, un cuneo di ferro piantato nel tronco. Quand’eravamo fortunati si poteva usare il palorcio, il filo a sbalzo: una piccola teleferica che faceva scivolare a valle il carico di legna“. Una volta preso l’abbrivio , il “Macallè” lascia correre la memoria come un fiume in piena. “Da noi ci chiamavano buscarò, in ossola e nei boschi della Val Grande “buratt”. Noi borradori, tagliatori di borre – che è la parte più pregiata del tronco, quella dritta, che serve per il legname da opera, siamo  gente a cui il lavoro non ha mai fatto schifo e la fatica non ci spaventa. Polenta e latte al mattino, minestra e una trincata dal fiasco di rosso alla sera. La “benzina” per i muscoli stava tutta lì, in quegli anni di fame e miseria. Ai tempi dei grandi tagli s’andava per squadre di una ventina di boscaioli ed un paio di “bocia”, cioè i ragazzini chedovevano svolgere lavoretti e piccole commissioni, come fare la spesa o portare gli attrezzi più leggeri. Ad ognuno di noi , se il taglio era a contratto, toccava tagliare più o meno un centinaio di metri quadri di bosco e ci davano un tanto per ogni metro quadrato tagliato. Pensa che i più bravi, in una stagione, riuscivano a lavorare fino a 1.000 quintalidi legname“. Dopo essersi bagnato la gola con un fiato di Sizzano, il “rosso” che preferiva, mi fa vedere gli attrezzi che tiene nel capanno. L’accetta e la scure, la roncola, la sega (resiga), la piccola zappa (sapìn), il trentìn, enorme sega lunga cerca due metri. I grandi “tagli” in Val Grande – tra Verbano e Ossola, oggi Parco nazionale, a tutela di quest’area “wilderness”, la più estesa dell’Europa occidentale – nella prima metà del ‘900, produssero un pesantissimo disboscamento per il quale fu addirittura costruita una “decauville”, una linea ferroviaria a scartamento ridotto di 4 km nel cuore della valle che vedeva, poco oltre la confluenza del Rio Caulì, un ponte sospeso – lungo 62 metri ed alto 22 – sul fiume, sul quale transitavano carrelli e vagoncini che trasportavano le “borre”. “Ma i tronchi si trasportavano anche grazie alle “cioende” “, aggiunge Vanni. “ Adesso non se ne trovano più ma erano degli scivoli di tronchi livellati, una sorta di “viadotti di legno”, a tratti pensili, in cui i tronchi erano fatti scendere in inverno, quando per l’occasione il “percorso” era inondato d’acqua e neve che, gelando, facilitava lo scorrimento del legname. Lungo la cioenda c’erano dei boscaioli come me, impegnati nel pericoloso compito di disincagliare i tronchi nei punti morti del tracciato. Guarda qua, leggi“. E mi mette sotto il naso un testo di Don Tullio Bertamini. Leggo: “ Le cioende si svilupparono nel secolo XIX fino ad essere delle vere meraviglie di abilità ed ingegnosità. Ne furono costruite lungo quasi tutte le valli. Quella che da Macugnaga giungeva a Ceppomorelli rimase in funzione una ventina d’anni. Un’altra cioenda restò in funzione per lunghi anni attorno al 1880 lungo la Val Cairasca partendo dall’alpe Veglia e scendendo fino a Varzo, allorchè furono fatti i grandi tagli di quell’alpe. Un’altra scendeva dalla Colmine fra le varie frazioni di Varzo ed era in funzione ancora nel primo decennio di questo secolo. Pochissimi ricordano la cioenda che scendeva dalla Val Bognanco”.Ogni volta che capitavo sotto le grinfie del “Macallè” era una lezione di storia del bosco o dei boscaioli. Ma, oggi, in vena di confidenze, mi ha parlato del “Babbo”. Piccolo, secco come il manico di una scopa, irascibile e pronto alla battuta come tutti i toscani ( era di Pistoia), faceva il “mestiere” con il papà del Vanni. Non riusciva a stare senza fumare al punto che, per una disattenzione, un giorno rischiò di mandare in cenere il capannone. Buttò via una cicca ancora accesa su di un mucchietto di segatura bella asciutta che, con una vampata, prese fuoco. Tra le fiamme il “Babbo” saltava quasi fosse stato morso da una tarantola. Si dimenava come un matto, urlando e imprecando. Padre e figlio, i due “abissini”, con coperte umide e secchiate d’acqua, avevano sudato sette camicie per soffocare l’incendio. Ma si rifecero quando, per scherzo, mischiarono il tabacco con la polvere da sparo, pigiando entrambi ben bene nella pipa del vecchietto. Appena avvicinò lo zolfanello al tabacco, tirando la pipa, una fiammata tremenda gli bruciò il ciuffo di capelli e le sopracciglia, lasciandolo inebetito ne con la faccia nera. Le parole che pronunciò si farebbe peccato mortale a scriverle e persino a sfiorarle col pensiero. Nel raccontare la storia, Vanni ride a crepapelle e mi appioppa delle manate sulle spalle. Non proprio carezze, sapete. Del resto le sue, sono mani da boscaiolo.
gente a cui il lavoro non ha mai fatto schifo e la fatica non ci spaventa. Polenta e latte al mattino, minestra e una trincata dal fiasco di rosso alla sera. La “benzina” per i muscoli stava tutta lì, in quegli anni di fame e miseria. Ai tempi dei grandi tagli s’andava per squadre di una ventina di boscaioli ed un paio di “bocia”, cioè i ragazzini chedovevano svolgere lavoretti e piccole commissioni, come fare la spesa o portare gli attrezzi più leggeri. Ad ognuno di noi , se il taglio era a contratto, toccava tagliare più o meno un centinaio di metri quadri di bosco e ci davano un tanto per ogni metro quadrato tagliato. Pensa che i più bravi, in una stagione, riuscivano a lavorare fino a 1.000 quintalidi legname“. Dopo essersi bagnato la gola con un fiato di Sizzano, il “rosso” che preferiva, mi fa vedere gli attrezzi che tiene nel capanno. L’accetta e la scure, la roncola, la sega (resiga), la piccola zappa (sapìn), il trentìn, enorme sega lunga cerca due metri. I grandi “tagli” in Val Grande – tra Verbano e Ossola, oggi Parco nazionale, a tutela di quest’area “wilderness”, la più estesa dell’Europa occidentale – nella prima metà del ‘900, produssero un pesantissimo disboscamento per il quale fu addirittura costruita una “decauville”, una linea ferroviaria a scartamento ridotto di 4 km nel cuore della valle che vedeva, poco oltre la confluenza del Rio Caulì, un ponte sospeso – lungo 62 metri ed alto 22 – sul fiume, sul quale transitavano carrelli e vagoncini che trasportavano le “borre”. “Ma i tronchi si trasportavano anche grazie alle “cioende” “, aggiunge Vanni. “ Adesso non se ne trovano più ma erano degli scivoli di tronchi livellati, una sorta di “viadotti di legno”, a tratti pensili, in cui i tronchi erano fatti scendere in inverno, quando per l’occasione il “percorso” era inondato d’acqua e neve che, gelando, facilitava lo scorrimento del legname. Lungo la cioenda c’erano dei boscaioli come me, impegnati nel pericoloso compito di disincagliare i tronchi nei punti morti del tracciato. Guarda qua, leggi“. E mi mette sotto il naso un testo di Don Tullio Bertamini. Leggo: “ Le cioende si svilupparono nel secolo XIX fino ad essere delle vere meraviglie di abilità ed ingegnosità. Ne furono costruite lungo quasi tutte le valli. Quella che da Macugnaga giungeva a Ceppomorelli rimase in funzione una ventina d’anni. Un’altra cioenda restò in funzione per lunghi anni attorno al 1880 lungo la Val Cairasca partendo dall’alpe Veglia e scendendo fino a Varzo, allorchè furono fatti i grandi tagli di quell’alpe. Un’altra scendeva dalla Colmine fra le varie frazioni di Varzo ed era in funzione ancora nel primo decennio di questo secolo. Pochissimi ricordano la cioenda che scendeva dalla Val Bognanco”.Ogni volta che capitavo sotto le grinfie del “Macallè” era una lezione di storia del bosco o dei boscaioli. Ma, oggi, in vena di confidenze, mi ha parlato del “Babbo”. Piccolo, secco come il manico di una scopa, irascibile e pronto alla battuta come tutti i toscani ( era di Pistoia), faceva il “mestiere” con il papà del Vanni. Non riusciva a stare senza fumare al punto che, per una disattenzione, un giorno rischiò di mandare in cenere il capannone. Buttò via una cicca ancora accesa su di un mucchietto di segatura bella asciutta che, con una vampata, prese fuoco. Tra le fiamme il “Babbo” saltava quasi fosse stato morso da una tarantola. Si dimenava come un matto, urlando e imprecando. Padre e figlio, i due “abissini”, con coperte umide e secchiate d’acqua, avevano sudato sette camicie per soffocare l’incendio. Ma si rifecero quando, per scherzo, mischiarono il tabacco con la polvere da sparo, pigiando entrambi ben bene nella pipa del vecchietto. Appena avvicinò lo zolfanello al tabacco, tirando la pipa, una fiammata tremenda gli bruciò il ciuffo di capelli e le sopracciglia, lasciandolo inebetito ne con la faccia nera. Le parole che pronunciò si farebbe peccato mortale a scriverle e persino a sfiorarle col pensiero. Nel raccontare la storia, Vanni ride a crepapelle e mi appioppa delle manate sulle spalle. Non proprio carezze, sapete. Del resto le sue, sono mani da boscaiolo.
Marco Travaglini
Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE