


In esposizione negli spazi di via Chiabrera, testimonianze, immagini, oggetti e documenti che restituiscono le esperienze delle scuole allievi FIAT e Lancia
Il Museo Nazionale dell’Automobile apre al Centro Storico FIAT la mostra “Capolavori di Torino”, realizzato insieme all’Associazione Ex Allievi FIAT, che restituisce, attraverso un racconto corale, la straordinaria esperienza novecentesca delle scuole FIAT e Lancia, fatta di teoria, pratica, disciplina ed eccellenza tecnica. Il progetto, ideato e curato dall’artista Nicola Nunziata, è articolato su tre componenti: la call to action partecipativa, la mostra e la pubblicazione, e si distingue per una combinazione unica di cittadinanza attiva, ricerca attiva e metodo partecipativo. “Capolavori” è il termine che definisce gli oggetti che gli allievi realizzavano come prove tecniche durante il loro percorso formativo, a dimostrazione delle capacità acquisite, oggi riletti nel progetto come manufatti simbolici e fossili di lavoro individuale. In occasione di questa mostra, il termine si dilata accogliendo un’idea più ampia di eccellenza e impegno, in un gioco di parole che congiunge il gesto operaio alla dimensione museale, e conferisce il titolo all’intero progetto di ricerca e sperimentazione attraverso il quale, il Museo Nazionale dell’Automobile attiva un dialogo con la cittadinanza, recuperando materiale diffuso tra i cittadini, per raccontare una vicenda storicamente importante. L’obiettivo è rintracciare e acquisire attraverso la raccolta, la digitalizzazione e la catalogazione quella parte di archivi privati invisibili, considerati complementari al materiale ufficiale, diffusi nel tessuto urbano torinese e non ancora emersi.
“Con ‘Capolavori di Torino’, l’archivio del Centro Storico FIAT, in particolare le scuole di FIAT e Lancia – afferma Nicola Nunziata – diventa materiale di partenza per la creazione di nuove opere d’arte. Un censimento pubblico estende il campo d’azione artistica, trasformando la ricerca d’archivio in un processo partecipativo. ‘Ex allievi cercasi’ è una call to action rivolta ai cittadini di Torino con l’obiettivo di ampliare la documentazione esistente con i materiali dei loro archivi privati, finora latenti, per costruire insieme una mostra al Centro Storico FIAT. L’istituzione culturale riafferma la propria natura di laboratorio di produzione s sperimentazione attivando un dialogo diretto tra artisti e cittadini. Questi ultimi si riappropriano degli spazi museali, riconoscendoli come luoghi accessibili e di trasformazione. Emerge uno scenario in cui ricerca artistica, umanità e tecnologia, complice la memoria, cooperano per accogliere un futuro dove l’arte è bene comune, accessibile e condiviso.
La storia delle scuole aziendali FIAT e Lancia (1923-1983) è storia novecentesca. Di quel secolo ha ereditato le asprezze, la disciplina imposta da due guerre mondiali, la povertà diffusa prima del boom e le promesse di una vita per i figli migliore di quella dei padri. Entrambe le scuole rappresentavano molto più di un semplice avviamento al lavoro: il motto della scuola allievi FIAT era: “Prima educare, poi istruire”, e l’obiettivo era quello di formare giovani che per eccellenza professionale e senso di appartenenza costituisse la spina dorsale di aziende capaci di crescere senza perdere la loro identità, in un processo di crescita che sembrava non dovesse finire mai.
Sono in esposizione materiali d’archivio e manufatti d’epoca, in dialogo con videoinstallazioni, interviste e fotografie realizzate oggi agli studenti di un tempo. La mostra è un pretesto per la ricerca artistica e per interrogare l’archivio con il materiale da cui generare nuove opere d’arte, un campo d’azione dove la pratica artistica del riuso agisce per associazioni libere, attraverso l’ibridazione e la coesistenza di diversi linguaggi dell’arte. La mostra, aperta venerdì 21 novembre, si chiuderà domenica 22 marzo 2026 al primo piano del Centro Storico FIAT, Dirimpetto a quella che fu la scuola allievi di corso Dante 103, un modo per ancorare a un luogo la memoria di una delle più grandi esperienze formative mai temtate dall’industria italiana.
Mara Martellotta
Articolo 1: Torino geograficamente magica
Articolo 2: Le mitiche origini di Augusta Taurinorum
Articolo 3: I segreti della Gran Madre
Articolo 4: La meridiana che non segna l’ora
Articolo 5: Alla ricerca delle Grotte Alchemiche
Articolo 6: Dove si trova ël Barabiciu?
Articolo 7: Chi vi sarebbe piaciuto incontrare a Torino?
Articolo 8: Gli enigmi di Gustavo Roll
Articolo 9: Osservati da più dimensioni: spiriti e guardiani di soglia
Articolo 10: Torino dei miracoli
 Articolo 2: Le mitiche origini di Augusta Taurinorum
Articolo 2: Le mitiche origini di Augusta TaurinorumNelle alte valli delle Alpi era usanza liberare una mucca prima di fondare una borgata; l’animale andava al pascolo tutto il giorno per poi trovare il punto in cui distendersi a terra e riposarsi. Quello sarebbe stato il luogo in cui i montanari avrebbero iniziato ad edificare il borgo: «la mucca può “sentire” cose che all’uomo sfuggono, se il posto è sicuro o meno e se di lì si irradiano energie benefiche o maligne».
Anche la fondazione di Torino potrebbe rientrare in una di tali credenze. Ma a questa versione, tutto sommato verosimile e riconducibile a qualche usanza rurale, fanno da controparte altre ipotesi, decisamente più complesse e letteralmente “divine”, poiché hanno come protagonisti proprio degli dei, Fetonte ed Eridano. Avviciniamoci allora a queste due figure. Secondo il mito greco, Fetonte, figlio del Sole, era stato allevato dalla madre Climene senza sapere chi fosse suo padre. Quando, divenuto adolescente, ella gli rivelò di chi era figlio, il giovane volle una prova della sua nascita. Chiese al padre di lasciargli guidare il suo carro e, dopo molte esitazioni, il Sole acconsentì. Fetonte partì e incominciò a seguire la rotta tracciata sulla volta celeste. Ma ben presto fu spaventato dall’altezza alla quale si trovava. La vista degli animali raffiguranti i segni dello zodiaco gli fece paura e per la sua inesperienza abbandonò la rotta. I cavalli si imbizzarrirono e corsero all’impazzata: prima salirono troppo in alto, bruciando un tratto del cielo che divenne la Via Lattea, quindi scesero troppo vicino alla terra, devastando la Libia che si trasformò in deserto. Gli uomini chiesero aiuto a Zeus che intervenne e, adirato, scagliò un fulmine contro Fetonte, che cadde nelle acque del fiume Eridano, identificato con il Po. Le sorelle di Fetonte,, le Eliadi, piansero afflitte e vennero trasformate dagli dei in pioppi biancheggianti. Le loro lacrime divennero ambra. Ma precisamente, dove cadde Fetonte? In Corso Massimo d’Azeglio, proprio al Parco del Valentino dove ora sorge la Fontana dei Dodici Mesi. In un altro mito, Eridano, fratello di Osiride, divinità egizia, era un valente principe e semidio. Costretto a fuggire dall’Egitto, percorse un lungo viaggio costeggiando la Grecia e dirigendosi verso l’Italia. Dopo aver attraversato il mar Tirreno sbarcò sulle coste e conquistò l’attuale regione della Liguria, che egli chiamò così in onore del figlio Ligurio. Attraversò poi l’Appennino e si imbatté in una pianura attraversata da un fiume che gli fece tornare alla mente il Nilo. Qui fondò una città, che dedicò al dio Api, venerato sotto forma di Toro.

Un giorno Eridano partecipò ad una corsa di quadrighe, purtroppo però, quando già si trovava vicino alla meta, il principe perse il controllo dei cavalli che, fuori da ogni dominio, si avviarono verso il fiume, ed egli vi cadde, annegando. In sua memoria il fiume venne chiamato come il principe, “Eridano”, che è, come abbiamo detto, anche l’antico nome del fiume Po, in greco Ἠριδανός (“Eridanos”), e in latino “Eridanus”. Questa vicenda ci riporta alla nostra Torino, simboleggiata dall’immagine del Toro, come testimoniano, semplicemente, e giocosamente, i numerosissimi toret disseminati per la città. Storicamente il simbolo è riconducibile alla presenza sul territorio della tribù dei Taurini, che probabilmente avevano il loro insediamento o nella Valle di Susa, o nei pressi della confluenza tra il Po e la Dora. L’etimologia del loro nome è incerta anche se in aramaico taur assume il valore di “monte”, quindi “abitanti dei monti”. I Taurini si scontrarono prima con Annibale e poi con i Romani, infine il popolo scomparve dalle cronache storiche ma il loro nome sopravvisse, assumendo un’altra sfumatura di significato, risalente a “taurus”, che in latino significa “toro”. È indubbio che anche oggi l’animale sia caro ai Torinesi, sia a coloro che per gioco o per scaramanzia schiacciano con il tallone il bovino dorato che si trova sotto i portici di piazza San Carlo, sia a quelli vestiti color granata che incessantemente lo seguono in TV. C’è ancora un’altra spiegazione del perché Torino sorga proprio in questo preciso luogo geografico, si tratta della teoria delle “Linee Sincroniche”, sviluppata da Oberto Airaudi, che fonda, nel 1975, a Torino, il Centro Horus, il nucleo da cui poi si sviluppa la comunità Damanhur. Le Linee Sincroniche sono un sistema di comunicazione che collega tutti i corpi celesti più importanti. Sulla Terra vi sono diciotto Linee principali, connesse fra loro attraverso Linee minori; le diciotto Linee principali si riuniscono ai poli geografici in un’unica Linea, che si proietta verso l’universo. Attraverso le Linee Sincroniche viaggia tutto ciò che non ha un corpo fisico: pensieri, energie, emozioni, persino le anime. Il Sistema Sincronico si potrebbe definire, in un certo senso, il sistema nervoso dell’universo e di ogni singolo pianeta. Inoltre, grazie alle Linee Sincroniche è possibile veicolare pensieri e idee ovunque nel mondo. Esse possono essere utilizzate come riferimenti per erigere templi e chiese, come dimostra il nodo centrale in Valchiusella, detto “nodo splendente”, dove sorge, appunto, la sede principale della comunità Damanhur. Secondo gli studi di tale teoria Torino nasce sull’incrocio della Linea Sincronica verticale A (Piemonte-Baltico) e la Linea Sincronica orizzontale B (Caucaso).Vi sono poi gli storici, con una loro versione decisamente meno macchinosa, che riferiscono di insediamenti romani istituiti da Giulio Cesare, intorno al 58 a.C., su resti di villaggi preesistenti, forse proprio dei Taurini. Il presidio militare lì costituitosi prese il nome prima di “Iulia Taurinorum”, poi, nel 28 a.C, divenuto un vero e proprio “castrum”, venne chiamato, dal “princeps” romano Augusto, “Julia Augusta Taurinorum”. Il resto, come si suol dire, è storia.
Queste le spiegazioni, scegliete voi quella che più vi aggrada.
Alessia Cagnotto
Venerdì 21 novembre, alle ore 17, partirà il tour artistico e culturale, da piazza Gherzi a Lu, noto come “Monferrato Decorato”, alla scoperta delle volte degli edifici antichi di Lu – Cuccaro Monferrato
Venerdì 21 novembre, a Lu – Cuccaro Monferrato, vi sarà un percorso luese alla scoperta dei soffitti colorati. Il tour artistico e culturale rappresenta un viaggio alla scoperta del patrimonio colorato monferrino, il paese di Lu – Cuccaro Monferrato, e si terrà venerdì 21 novembre, alle ore 17, con appuntamento a Lu, in piazza Luigi Gherzi. L’evento, ideato da Anna Maria Bruno, è promosso dalla Fondazione Ecomuseo della Pietra da Cantoni, e si propone di far conoscere il patrimonio artistico e decorativo, che nella storia ha determinato la storia di numerose abitazioni monferrine, indipendentemente dalla classe e dal ceto sociale. La prima tappa sarà a Casa Signorini, incantevole dimora situata nel borgo Monferrino, custode di fascino e bellezza. A seguire l’itinerario proseguirà nell’eleganza di palazzo Paleologi, al cui interno sono attivi il relais palazzo Paleologi e il ristorante Daimon. Quindi, il tour si allungherà in un’ala del ristorante Antico Monastero, il cui soffitto a cassettoni rimanda a suggestioni ancestrali.
“Per la prima volta a Lu, con ‘Monferrato Decorato’, potremo farci sorprendere dalle meravigliose volte di due edifici antichi, che ancora oggi trasudano di arte, bellezza e storia – commenta il Presidente Corrado Calvo – con Anna Maria Bruno riscopriremo risvolti meno noti e avremo il privilegio per un giorno di ammirare i bellissimi ambienti decorati e i loro diversi stili”.
La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione al numero 348 2211219 – chebisa@virgilio.it
Mara Martellotta
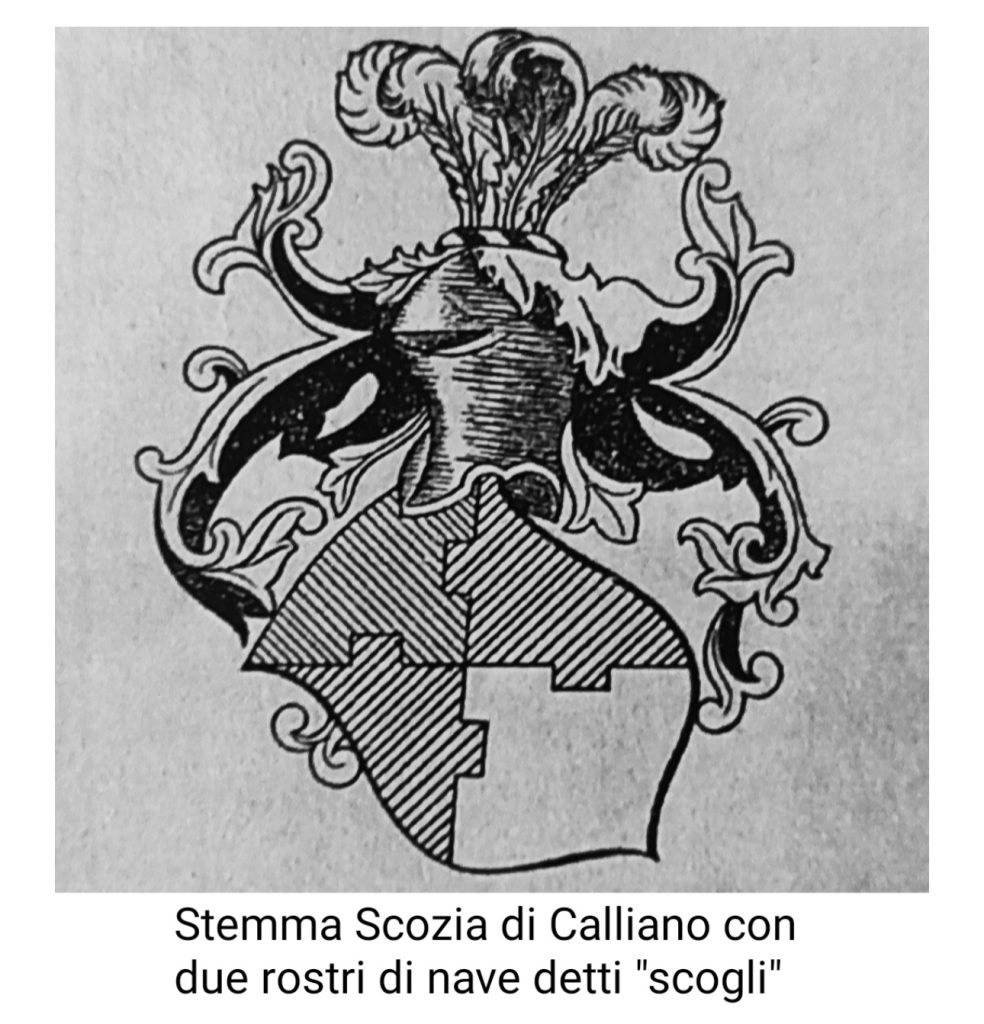
Malinconica e borghese, Torino è una cartolina d’altri tempi che non accetta di piegarsi all’estetica della contemporaneità.
Il grattacielo San Paolo e quello sede della Regione sbirciano dallo skyline, eppure la loro altitudine viene zittita dalla moltitudine degli edifici barocchi e liberty che continuano a testimoniare la vera essenza della città, la metropolitana viaggia sommessa e non vista, mentre l’arancione dei tram storici continua a brillare ancorata ai cavi elettrici, mentre le abitudini dei cittadini, segnate dalla nostalgia di un passato non così lontano, non si conformano all’irruente modernità.
Torino persiste nel suo essere retrò, si preserva dalla frenesia delle metropoli e si conferma un capoluogo “a misura d’uomo”, con tutti i “pro e i contro” che tale scelta comporta.
Il tempo trascorre ma l’antica città dei Savoia si conferma unica nel suo genere, con le sue particolarità e contraddizioni, con i suoi caffè storici e le catene commerciali dei brand internazionali, con il traffico della tangenziale che la sfiora ed i pullman brulicanti di passeggeri “sudaticci” ma ben vestiti.
Numerosi sono gli aspetti che si possono approfondire della nostra bella Torino, molti vengono trattati spesso, altri invece rimangono argomenti meno noti, in questa serie di articoli ho deciso di soffermarmi sui primati che la città ha conquistato nel tempo, alcuni sono stati messi in dubbio, altri riconfermati ed altri ancora superati, eppure tutti hanno contribuito – e lo fanno ancora- a rendere la remota Augusta Taurinorum così pregevole e singolare.
1. Torino capitale… anche del cinema!
2.La Mole e la sua altezza: quando Torino sfiorava il cielo
3.Torinesi golosi: le prelibatezze da gustare sotto i portici
4. Torino e le sue mummie: il Museo egizio
5.Torino sotto terra: come muoversi anche senza il conducente
6. Chi ce l’ha la piazza più grande d’Europa? Piazza Vittorio sotto accusa
7. Torino policulturale: Portapalazzo
8.Torino, la città più magica
9. Il Turet: quando i simboli dissetano
10. Liberty torinese: quando l’eleganza si fa ferro
9. Il Turet: quando i simboli dissetano
Eccoci quasi arrivati alla fine del ciclo di articoli sui primati torinesi, e come in tutti gli elenchi ho voluto lasciare “il meglio” per ultimo.
Lo sapete da dove deriva la parola “rubinetto”? Questa la definizione dal dizionario: “Dal fr. robinet, der. di robin, nome dato pop. ai montoni, perché le chiavette, in passato, avevano spesso la forma di una testa di montone •sec. XVI.” Si, l’etimologia fa riferimento ai “montoni”, forse proprio per questo motivo le fontane costruite tra il Quattrocento e il Cinquecento hanno spesso forma di testa di animale, tale tradizione svanisce tuttavia nel corso dei secoli, per lasciare spazio a costruzioni più semplici e lineari. Questo accade quasi dappertutto, tranne che in una città, indovinate quale?
Il record di cui vorrei raccontarvi oggi è assai peculiare, nonché decisamente riconducibile alla nostra urbe, mi riferisco ai famosi “torèt”.
Credo che per noi abitanti del luogo, tale dettaglio urbano, sia qualcosa di “abituale”, una presenza quasi scontata e banale, perché come tutti siamo anestetizzati e distaccati nei confronti dei beni che già possediamo, mentre tutto il nostro desiderio si rivolge costantemente alle meraviglie che si trovano dall’altra parte del mondo.
Quando re-impareremo a guardare, ci accorgeremo del minuzioso incanto delle fontanelle che pullulano tra le nostre piazze e le nostre vie, mi riferisco a quelle strutture a forma di “torèt” che i turisti si fermano a fotografare, spesso divertiti e stupiti, giacché non capita in molte altre metropoli di imbattersi in simili fonti d’acqua.

Anche il numero di tali impianti è sbalorditivo: sono 800 i “piccoli tori” che si occupano senza sosta di dissetare gratuitamente la cittadinanza e i visitatori.
È bene ricordare che la comunità pedemontana continua a costruire le proprie sorgenti cittadine, sempre con tali sembianze, da più di centosessant’anni, rifacendosi all’antica tradizione che associa per assonanza – e altre motivazioni relative alla mitologia- l’effige del toro e la denominazione “Torino”.
Si sa, l’acqua corrente non è sempre stata disponibile presso le abitazioni del popolo. Nell’Ottocento le persone prelevavano l’acqua dai pozzi dislocati nei vari cortili o in quelli artesiani, dove le acque sotterranee emergevano naturalmente, senza bisogno di specifici strumenti di estrazione. Tale abitudine comportava però problemi igienico-sanitari, annessi ad esempio all’inquinamento delle fonti o alle eventuali contamizioni delle falde.
La città sabauda allora – che ci piaccia o meno- si ispira ad un progetto diffusosi nelle capitali della Francia, ossia un sistema idrico costituito da fontanelle che forniscono acqua 24 ore su 24. Per differenziarsi dai nemici-amici gallici i torinesi ideano una specifica forma, tutta nostrana, per sorgenti urbane: ecco la nascita del “torèt”.
Grazie a tali invenzioni, anche nel capoluogo piemontese, diventa possibile ovviare alle numerose difficoltà quotidiane incontrate dalla popolazione. Intorno al 1859, viene progettato il primo acquedotto che irrori svariate fontanelle pubbliche, inoltre, nel 1861 – dopo un mese dall’unità d’Italia- la Giunta Comunale individua ben 81 zone da predisporre proprio come “punti d’acqua” potabile.
Un anno dopo vengono presentati i famigerati progetti delle “fontanelle”, tali e quali a quelli che tutt’ora possiamo visionare passeggiando per le strade. Da subito vengono redatte delle mappe per rendere più facilmente trovabili queste costruzioni, all’inizio si contano ben 45 “torèt”, poi nel tempo, il numero delle fontane aumenta sempre più, fino a raggiungere la moltitudine da record odierna.
Il primo esemplare viene edificato all’angolo tra via San Donato e via Balbis, nei pressi di Piazza Statuto; oggi però la struttura appare piuttosto nuova, questo perchè dopo più di cent’anni di onorato servizio il piccolo toro originale è stato sostituito, la collocazione però è rimasta la medesima.
Il “torèt” si presenta sempre uguale in ciascuna delle sue copie: forma parallelepipeda di circa un metro d’altezza, l’estremità superiore è arcuata, con una griglia di scolo in basso, spesso dotata di una conca centrale da cui possono bere anche gli amici a quattro zampe. Il materiale utilizzato è la ghisa, il colore che ricopre la lega ferrosa è un particolare tono di verde, facilmente definibile “verde bottiglia”. E poi c’è ovviamente l’elemento distintivo: il rubinetto a forma di testa di toro.
Fin dal principio tali gorghi mostrano un’estetica inconfondibile, divengono subito un caratteristico arredo urbano, tant’è che oggi sono addirittura acquistabili in formato di gadget-portachiavi, piccoli souvenir ideati dal Comune di Torino per promuovere l’immagine dell’antica città dei Savoia.
Dietro all’apparente frivolezza dell’oggetto si cela un’attenzione rivolta all’ambiente e alla salute, la manutenzione delle fontane è affidata alla SMAT (la Società Metropolitana Acque Torino), che si occupa di erogare agli avventori assetati acqua gratuita, di buona qualità e regolarmente controllata, il ricambio costante del flusso impedisce così la formazione di ristagni che potrebbero generare la proliferazione di batteri. È bene sottolineare inoltre che non vi è alcuno spreco idrico: l’acqua “non bevuta” ritorna infatti nelle falde sotterranee – oltretutto in qualità ancora migliore rispetto a prima-.
Esistono anche dei “torèt” versione “ingrandita”, si tratta delle ironiche e bizzarre sculture realizzate da Nicola Russo a partire dal 2021. Il lavoro dell’artista nasce dall’idea che i piccoli tori possano rompere la fontanella che li tiene soggiogati, mostrandosi in tutta la propria possanza di mammifero artiodattilo. Le sculture possono apparire panciute e goffe, ma si sa, “noi del nord” non siamo noti per ilarità e autoironia, Nicola Russo ha così dovuto spiegare le proprie creazioni poste sul territorio cittadino: “il toret vede la sua amata città vivere un momento di difficoltà a causa del Covid e allora decide di uscire dal suo guscio in ghisa, per dare un segno di cambiamento e per spingere tutta la città a una rinascita.
Non importa se è panciuto e goffo, lui si mostra così com’è fatto per portare il suo messaggio di speranza. Il suo è quindi “un gesto di coraggio, perché senza coraggio non c’è futuro”.
È bene dunque superare lo scetticismo del primo sguardo, anche perchè l’iniziativa dello scultore ha un duplice intento virtuoso: da una parte egli si appoggia solo ad aziende piemontesi, in modo da incentivare una ricaduta economica sul territorio, dall’altra lo scultore ha deciso di devolvere parte dei ricavati alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus di Candiolo.
Anche stavolta mi viene da terminare con un “ Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι ” (“la favola insegna che”). Mai fermarsi alle apparenze, perché dietro la semplicità si cela sempre la preziosità di un grande insegnamento e nella goffaggine di un sorriso si può trovare la forza per proseguire ciascuno nel proprio percorso.
Alessia Cagnotto
C’è un primato poco noto che Torino condivide con Vienna. È quello dei caffè storici, che nel capoluogo piemontese eccellono per numero, bellezza e storia: sono veri e propri salotti cittadini, anzi crocevia, ai cui tavolini si incontravano (e talvolta si incontrano ancora) intellettuali, giornalisti, aristocratici. Proprio a questo intreccio di cultura e sapori sarà dedicato l’appuntamento in programma lunedì 24 novembre alle 18.30 allo storico Caffè Pepino, in piazza Carignano 8 a Torino. L’occasione è la presentazione della monografia “Caffè & Locali storici di Torino”, ottavo volume della collana “Bellezze di Torino, blësse ‘d Turin” (edizioni Inspire Communication). L’incontro è promosso dall’Associazione Monginevro Cultura insieme all’Associazione Caffè Storici di Torino e del Piemonte, presieduta da Edoardo Cavagnino. Il libro, bilingue in italiano e piemontese, racconta in immagini e parole i caffè simbolo dell’eleganza sabauda: locali ancora in attività o scomparsi, ma rimasti impressi nella memoria cittadina. A condurre la serata sarà Sergio Donna, coordinatore del progetto editoriale, affiancato da alcuni coautori e dai fotografi Carla Colombo, Beppe Lachello e Vittorio Greco. Ad accompagnare il pubblico nel viaggio tra passato e presente ci saranno letture, aneddoti e poesie, impreziosite dalla presenza di figuranti in abiti d’inizio Novecento. Protagonista dell’aperitivo sarà naturalmente il vermouth di Torino, il vino aromatizzato che è diventato, negli anni, il simbolo dei caffè storici torinesi. La degustazione, al costo di 15 euro, è su prenotazione: segreteria@monginevrocultura.net, 011 0437207.
Fino al 2 febbraio 2026
Occasione contingente, il riallestimento della “Sala Tessuti”. Da questa pratica incombenza, nasce una mostra di notevole valore culturale, storico e didattico che racconta, attraverso sei secoli di altissima arte tessile una storia che passa per ricami minuti e intricati e preziosi merletti, arrivando al più iconico degli abiti femminili di colore bianco, il colore naturale della seta e del lino: l’abito da sposa. Si presenta così la mostra dal titolo (non per nulla) di “Bianco al Femminile” curata da Paola Ruffino e allestita nella “Sala Tessuti” di “Palazzo Madama” fino a lunedì 2 febbraio 2026. In rassegna, trovano adeguato spazio cinquanta manufatti tessili, appartenenti alle Collezioni del Palazzo che fu “Casa dei secoli” per Guido Gozzano, di cui sei restaurati per questa precisa occasione e quattordici esposti per la prima volta: autentici capolavori nati dal sorprendente lavoro (più che artigianale) passato, per tradizioni secolari, attraverso “mani femminili” che hanno operato con minuta diligenza sul “ricamo in lino medievale”, così come sulla lavorazione dei “merletti ad ago” o “a fuselli” o ancora sul “ricamo in bianco su bianco”. Donne artigiane, donne artiste, donne “autrici, creatrici, nonché raffinate fruitrici e committenti di tessuti e accessori di moda”. Comune fil rouge, per tutte, il colore bianco, colore “in stretta connessione, materiale e simbolica, proprio con la donna”. E che trova il suo massimo apice in Francia e in Europa, sul finire del XVIII secolo, complice il fascino esercitato dalla statuaria greca e romana su una moda che guarda, affascinata non poco, all’antico. “Le giovani – si legge in nota – adottano semplici abiti ‘en-chemise’, trattenuti in vita da una fusciacca; il modello del ‘cingulum’ delle donne romane sposate, portato alto sotto al seno, dà avvio ad una moda che durerà per trent’anni. I tessuti preferiti sono mussole di cotone, garze di seta, rasi leggeri, bianchi o a disegni minuti, come le porcellane dei servizi da tè”.
Dal XIV – XV secolo fino al Novecento (dietro l’angolo) l’iter espositivo prende avvio dai primi “ricami dei monasteri femminili”, in particolare di area tedesca e della regione del lago di Costanza (lavorati su tela di lino naturale e poi diffusisi, per la povertà dei materiali e per la facilità di esecuzione, anche in ambito domestico – laico, per la decorazione di tovaglie e cuscini) per poi passare a documentare la lavorazione del “merletto” nell’Europa del XVI e XVII secolo che vide protagonisti i lini bianchissimi e la straordinaria abilità delle “merlettaie veneziane e fiamminghe”. In rassegna una scelta di bordi e accessori in pizzo italiani e belgi illustra gli eccezionali risultati decorativi di quest’arte “esclusivamente femminile”, che nel Settecento superò gli stretti confini della casa o del convento e si organizzò in “manifatture”. E proprio l’inizio della “produzione meccanizzata” causò, nel XIX secolo, la perdita di quell’insostituibile virtuosismo nell’arte manuale del “merletto”, che riemerse invece nel ricamo in filo bianco sulle sottili “tele batista” (in trama fatta con filati di titolo sottile) e sulle “mussole” dei “fazzoletti femminili”. Quattro splendidi esemplari illustrano l’alta raffinatezza raggiunta da questi accessori, decorati con un lavoro a ricamo che restò sempre un’attività soltanto al femminile, anche quando esercitata a livello professionale.
L’esposizione si conclude nel XX secolo con uno dei temi che più vedono uniti la donna e il colore bianco nella nostra tradizione, l’ “abito da sposa”, con un abito del 1970, corto, accompagnato non dal velo ma da una avveniristica cagoule (cappuccio), scelta non scontata “che ribadisce la forza e la persistenza del rapporto tra l’immagine della donna e il candore del bianco”.
La selezione di tessuti è accostata nell’allestimento a diverse “opere di arte applicata”, fra cui miniature, incisioni, porcellane e legature provenienti dalle Collezioni del “Museo”.
In occasione del nuovo allestimento delle Collezioni Tessili, “Palazzo Madama” propone, inoltre, un “laboratorio di cucitura in forma meditativa” a cura di Rita Hokai Piana nelle giornate di sabato 15 e 22 marzo, 5 e 12 aprile, dalle ore 10 alle ore 13. Tutte le info su: www.palazzomadamatorino.it
Gianni Milani
“Bianco al Femminile”
Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica, piazza Castello, Torino; tel. 011/4433501 o www.palazzomadamatorino.it
Fino al 2 febbraio 2026
Orari: lun. e da merc. a dom. 10/18; mart. chiuso
Nelle foto: “Sala Tessuti” (Ph. Studio Gonella); Caracò, Italia 1750-60; Corpetto, Germania sud-occidentale, 1750-75
|
L’esposizione organizzata dai Musei Reali in collaborazione con l’Archivio di Stato di Torino, in occasione delle Nitto ATP Finals 2025, presenta tre opere che analizzano da un punto di vista storico, artistico e culturale uno degli sport più apprezzati e praticati a livello globale e documenta come l’antenato del gioco del tennis appartenesse alla vita di corte e fosse praticato con entusiasmo anche dai duchi di Savoia.
Per l’occasione, lunedì 10 novembre 2025 dalle ore 15 alle ore 16, a Casa Tennis in Piazza Castello a Torino si terrà l’incontro Alle origini del tennis: racchette e giochi di corte, un viaggio nel tempo alla scoperta del tennis di ieri e di oggi. In occasione della quinta edizione delle Nitto ATP Finals, i Musei Reali in collaborazione con l’Archivio di Stato di Torino presentano una mostra dossier dal titolo Alle origini del tennis: racchette e giochi di corte, che analizza da un punto di vista storico, artistico e culturale uno degli sport più apprezzati e praticati a livello globale.
La piccola ma preziosa esposizione, allestita da sabato 8 a martedì 18 novembre 2025 al secondo piano della Galleria Sabauda, propone tre opere legate alla storia e alla cultura della corte, che documentano come il gioco del tennis – o il suo antenato, il “jeu de paume” o “pallacorda” – appartenesse alla vita di corte e venisse praticato con entusiasmo anche dai duchi di Savoia. “Gioco dei re e re dei giochi”, il tennis conosce una grande fortuna in Francia e nelle principali corti del Rinascimento italiano (Firenze, Milano, Ferrara, Mantova), tanto che già nel 1555 il filosofo Antonio Scaino scrive il primo Trattato del giuoco della palla con precisi riferimenti al “gioco della racchetta”. Per questo motivo, il tennis rientra nell’educazione e negli svaghi dei principini sabaudi, come testimonia il disegno presente nel prezioso manoscritto cartaceo in prestito dall’Archivio di Stato contenente i ritratti dei conti e dei duchi di Savoia con le rispettive consorti, alternati agli avvenimenti più rilevanti della storia sabauda e accompagnati dai commenti poetici dello storiografo Filiberto Pingone (1525 – 1582). Su una delle pagine esposte, il giovane principe Carlo Giovanni Amedeo (1488 -1496), all’età di sei anni, stringe un uccellino legato con un laccio, mentre accanto a lui sono raffigurate una racchetta e una pallina, chiaro riferimento ai passatempi infantili e all’educazione del principe. Nella pagina accanto, da un baule dotato di ruote, quasi una moderna cesta dei giochi, spuntano una fionda, un cavalluccio, una trottola, un corno, un tamburello e una girandola, pronti per accompagnare il divertimento dei giovani rampolli della corte.
Allo stesso tema fa riferimento il doppio ritratto della Galleria Sabauda in cui i due figli maggiori di Vittorio Amedeo I e Cristina di Francia sono effigiati con i loro giochi preferiti: il piccolo Carlo Emanuele, futuro duca, di due anni, trattiene tra le dita un piccolo volatile legato con un sottile cordino mentre il maggiore, Francesco Giacinto di quattro anni, guarda lo spettatore tenendo in mano una palla e una racchetta. Di fronte a questa tela è esposto un raffinato dipinto di soggetto allegorico della Galleria Sabauda, eseguito dal pittore fiammingo Jan Brueghel il Giovane: attraverso il caotico accumulo di oggetti in primo piano che rimandano alla musica, al gioco, all’arte, alla scienza, alla guerra e ai piaceri dei sensi, il pittore mette in mostra un vero e proprio inventario delle passioni e delle tentazioni umane: al centro della composizione sono rappresentate due racchette e tre palline che contribuiscono, insieme agli altri elementi, a evocare simbolicamente la vanità delle ricchezze terrene.
Per approfondire i temi culturali e storici proposti dall’esposizione, lunedì 10 novembre 2025 dalle ore 15 alle ore 16 a Casa Tennis, in Piazza Castello a Torino, si terrà l’incontro Alle origini del tennis: racchette e giochi di corte. Nel corso dell’appuntamento, parte del programma di Live tennis, Love Torino & Piemonte, Paola D’Agostino, Direttrice dei Musei Reali, Annamaria Bava, Responsabile delle Collezioni d’arte e di archeologia dei Musei Reali, Stefano Benedetto, Direttore dell’Archivio di Stato di Torino e Alessandro Tosi, Direttore del Museo della Grafica e docente di Storia dell’Arte Moderna all’Università di Pisa, accompagneranno gli spettatori in un viaggio nel tempo alla scoperta del tennis di ieri e di oggi, concentrandosi sulle origini di questo sport, nato come elegante passatempo nelle corti europee.
Live tennis, Love Torino & Piemonte propone, inoltre, a Casa Tennis, venerdì 14 novembre 2025, alle ore 17.30, l’incontro Il “divino” Guido Reni nelle collezioni sabaude e sugli altari del Piemonte, per scoprire la modernità del “divino” Guido Reni, maestro della pittura seicentesca amato dalla corte sabauda e protagonista della mostra in corso ai Musei Reali (Galleria Sabauda, secondo piano), visitabile fino al 18 gennaio 2026. Le curatrici Annamaria Bava e Sofia Villano racconteranno la vita e l’arte del pittore emiliano in occasione dei 450 anni dalla sua nascita, attraverso le oltre venti opere esposte tra dipinti, disegni e incisioni. Tra i capolavori, la pala dell’Assunzione della Vergine, riscoperta ad Abbadia Alpina di Pinerolo e restaurata per l’occasione, accanto a tele provenienti da collezioni piemontesi e dal Musée des Augustins di Tolosa. Un viaggio tra devozione e bellezza, classicismo e luce, per riscoprire l’armonia perfetta del “divino Guido” come già era chiamato dai suoi contemporanei.
La visita alle due mostre dossier è compresa nel biglietto di ingresso ai Musei Reali. I possessori del biglietto delle partite Nitto ATP Finals potranno accedere ai Musei Reali di Torino con tariffa scontata a 10 euro, a fronte dell’acquisto di un biglietto intero di accesso al museo per l’accompagnatore (formula 1 intero + 1 ridotto).
ALLE ORIGINI DEL TENNIS: RACCHETTE E GIOCHI DI CORTE Torino, Musei Reali | Galleria Sabauda, secondo piano 8-18 novembre 2025 Orari: Dal giovedì al martedì, 9-19 (la biglietteria chiude alle ore 18) Chiuso il mercoledì
Ingresso alla Galleria Sabauda compreso nel biglietto dei Musei Reali Intero € 15,00; Ridotto: € 2,00 (ragazzi di età dai 18 ai 25 anni)
Prenotazione obbligatoria per gli incontri a Casa Tennis, con ingresso gratuito:
Nella foto Jan Brueghel il Giovane, La vanità della vita umana,1631, olio su tavola, 64 x 106 cm, Torino, Musei Reali – Galleria Sabauda |
