Era sempre la stessa storia. Ogni volta che un gerarca veniva sul lago, in visita alle isole Borromee, a Stresa o in un’altra località nelle vicinanze, Gino e Lucio finivano ammanettati nella rimessa delle barche, proprio sotto la passeggiata del lungolago di Baveno.

Le disposizioni, del resto, erano chiare: tutti coloro sui quali si nutriva anche solo il sospetto d’essere dei sovversivi andavano controllati e, se necessario, messi a tacere. I due, pur avendo schivato il confino non potevano evitare quella restrizione della loro libertà. E quindi, giù sotto, in riva al lago, al riparo da sguardi indiscreti. Incatenati ai grandi anelli di ferro dove venivano assicurate le cime da ormeggio delle imbarcazioni, non erano in condizione di nuocere. “Anche se si lamentassero, là sotto, nessuno potrà udirli”, sentenziò il maresciallo Rustici. Fascista antemarcia, il graduato dei carabinieri evadeva così la spinosa “pratica” di “quelle due teste calde”. “Oh, Carmelo – disse, rivolgendosi al carabiniere scelto Esposito -; ma ti pare che dovevano proprio capitare tra i piedi a noi questi rompiballe?”. Carmelo, buono come un pezzo di pane, annuì per far piacere al suo superiore ma in cuor suo non li avrebbe costretti a star lì, quasi a mollo nel lago, in quell’antro umido e inospitale. Già l’ultima volta, per un soffio, non c’era scappato il morto. I due – ai quali era stato aggregato anche Olimpo Bronzelli – erano finiti ammanettati agli anelli  d’ormeggio perché era stata annunciata la visita di un pezzo grosso all’hotel Beau Rivage. L’Hotel era proprio lì, dall’altra parte della strada che attraversava il paese. Olimpo, scalpellino nella cava di granito rosa, era finito ai ferri perché reo di aver canticchiato in un’osteria un motivetto che il Podestà aveva giudicato offensivo nei confronti del regime e del Regno. In realtà, il povero tagliapietre – un po’ brillo – aveva improvvisato un’innocua e vecchia tiritera che più o meno suonava così: “Viva il Re, viva la regina e viva la capra della Bettina”, animale reso famoso dall’eccellente e copiosa produzione di latte. Uno scioglilingua che però era stato mal interpretato e così, ai soliti due reprobi si aggiunse pure il terzo. Il problema derivò dal maltempo. Una forte perturbazione stava imperversando tra il lago e le alture del Mottarone e, in poco tempo, le onde s’ingrossarono trasformandosi in schiumosi cavalloni che s’infrangevano sulla massicciata ricavata dalla passeggiata del lungolago. Immaginarsi che inferno anche là sotto, per i tre prigionieri. A tratti le onde li sommergevano per poi ritirarsi, lasciandoli infreddoliti e in balia di altri, gelidi, schiaffi d’acqua. Tutti e tre furono costretti, loro malgrado, a bere quell’acqua dal cattivo sapore. Soprattutto Lucio che, una volta liberato, giurò di non toccar più una goccia di quel liquido tremendo, limitandosi – pur nelle restrizioni dell’epoca – a sorseggiare soltanto vino, compreso quello aspro e ruvido, che legava in bocca, spillato dalla botte dell’osteria della Miniera, su in Tranquilla.
d’ormeggio perché era stata annunciata la visita di un pezzo grosso all’hotel Beau Rivage. L’Hotel era proprio lì, dall’altra parte della strada che attraversava il paese. Olimpo, scalpellino nella cava di granito rosa, era finito ai ferri perché reo di aver canticchiato in un’osteria un motivetto che il Podestà aveva giudicato offensivo nei confronti del regime e del Regno. In realtà, il povero tagliapietre – un po’ brillo – aveva improvvisato un’innocua e vecchia tiritera che più o meno suonava così: “Viva il Re, viva la regina e viva la capra della Bettina”, animale reso famoso dall’eccellente e copiosa produzione di latte. Uno scioglilingua che però era stato mal interpretato e così, ai soliti due reprobi si aggiunse pure il terzo. Il problema derivò dal maltempo. Una forte perturbazione stava imperversando tra il lago e le alture del Mottarone e, in poco tempo, le onde s’ingrossarono trasformandosi in schiumosi cavalloni che s’infrangevano sulla massicciata ricavata dalla passeggiata del lungolago. Immaginarsi che inferno anche là sotto, per i tre prigionieri. A tratti le onde li sommergevano per poi ritirarsi, lasciandoli infreddoliti e in balia di altri, gelidi, schiaffi d’acqua. Tutti e tre furono costretti, loro malgrado, a bere quell’acqua dal cattivo sapore. Soprattutto Lucio che, una volta liberato, giurò di non toccar più una goccia di quel liquido tremendo, limitandosi – pur nelle restrizioni dell’epoca – a sorseggiare soltanto vino, compreso quello aspro e ruvido, che legava in bocca, spillato dalla botte dell’osteria della Miniera, su in Tranquilla.
Marco Travaglini








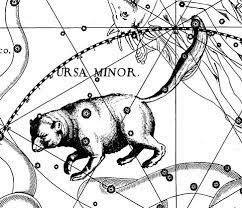




 Il dovere era sempre il dovere. “I treni devono viaggiare in orario”, affermava compito scrutando orgoglioso il suo Perseo meccanico, a carica manuale, con la lucida locomotiva turca disegnata sulla cassa. Quest’orologio da tasca, fissato al panciotto con una catena d’argento, era il tratto distintivo del ferroviere, quasi un segno del comando. L’orologio assumeva un’importanza vitale e serviva a garantire l’assoluta precisione nel calcolo per regolare il traffico su rotaia. Tutto dipendeva dal tempo: tabelle, orari, coincidenze, scambi. E la sincronizzazione degli orologi era indispensabile. Quello in possesso di Amleto non è un orologio comune ma un modello costruito appositamente per le Ferrovie dello Stato e quindi era “l’Orologio”, quello con la “o” maiuscola. Preciso, infallibile, perfettamente funzionante. “L’orologio per noi è un po’ come l’Arma dei Carabinieri: nei secoli fedele”, sentenziava al bancone del Circolo Operaio il Ballanzoni, lisciandosi la barba. Magari non durava proprio dei secoli ma qualche decennio sì. E il suo Perseo era lì, testimone muto ma preciso, a confermarlo. Il destino del ferroviere e quello del suo orologio erano talmente indissolubili che, di norma, andavano in pensione insieme. Deposto il berretto e riconsegnati fischietto e paletta, l’orologio rimaneva di proprietà, quasi fosse una medaglia, un distintivo, un segno di riconoscimento per chi aveva fatto parte della grande famiglia dei ferrovieri. Proprio a quell’orologio mirava la gazza ladra. Per Mirella rappresentava l’oggetto del desiderio. Un lucente e ticchettante trofeo da aggiungere alla sua collezione, il pezzo più pregiato, la “chicca” della quale potersi vantare a destra e manca. Iniziò a svolazzare con aria indolente attorno alla stazione. Un battito d’ali così svagato non avrebbe destato i sospetti del capostazione che, tra l’altro, non pareva avere (così almeno pensava Mirella) grandi conoscenze in fatto di uccelli e quindi particolare timore nell’avvistare nei dintorni il volteggiare di una gazza. Così, in quei giorni che anticipavano l’avvio delle feste di fine anno, proprio mentre iniziò a nevicare, accadde il fatto più inatteso e terribile che l’Amleto Ballanzoni si sarebbe mai immaginato di vivere: il furto dell’orologio.
Il dovere era sempre il dovere. “I treni devono viaggiare in orario”, affermava compito scrutando orgoglioso il suo Perseo meccanico, a carica manuale, con la lucida locomotiva turca disegnata sulla cassa. Quest’orologio da tasca, fissato al panciotto con una catena d’argento, era il tratto distintivo del ferroviere, quasi un segno del comando. L’orologio assumeva un’importanza vitale e serviva a garantire l’assoluta precisione nel calcolo per regolare il traffico su rotaia. Tutto dipendeva dal tempo: tabelle, orari, coincidenze, scambi. E la sincronizzazione degli orologi era indispensabile. Quello in possesso di Amleto non è un orologio comune ma un modello costruito appositamente per le Ferrovie dello Stato e quindi era “l’Orologio”, quello con la “o” maiuscola. Preciso, infallibile, perfettamente funzionante. “L’orologio per noi è un po’ come l’Arma dei Carabinieri: nei secoli fedele”, sentenziava al bancone del Circolo Operaio il Ballanzoni, lisciandosi la barba. Magari non durava proprio dei secoli ma qualche decennio sì. E il suo Perseo era lì, testimone muto ma preciso, a confermarlo. Il destino del ferroviere e quello del suo orologio erano talmente indissolubili che, di norma, andavano in pensione insieme. Deposto il berretto e riconsegnati fischietto e paletta, l’orologio rimaneva di proprietà, quasi fosse una medaglia, un distintivo, un segno di riconoscimento per chi aveva fatto parte della grande famiglia dei ferrovieri. Proprio a quell’orologio mirava la gazza ladra. Per Mirella rappresentava l’oggetto del desiderio. Un lucente e ticchettante trofeo da aggiungere alla sua collezione, il pezzo più pregiato, la “chicca” della quale potersi vantare a destra e manca. Iniziò a svolazzare con aria indolente attorno alla stazione. Un battito d’ali così svagato non avrebbe destato i sospetti del capostazione che, tra l’altro, non pareva avere (così almeno pensava Mirella) grandi conoscenze in fatto di uccelli e quindi particolare timore nell’avvistare nei dintorni il volteggiare di una gazza. Così, in quei giorni che anticipavano l’avvio delle feste di fine anno, proprio mentre iniziò a nevicare, accadde il fatto più inatteso e terribile che l’Amleto Ballanzoni si sarebbe mai immaginato di vivere: il furto dell’orologio. “Ma come? Non avverte, quel pennuto, il mio fascino? Non incrocia mai il mio sguardo. Anzi, mi pare che tenga sempre gli occhi fissi davanti a se… E quel suo rimanere lì, impettito come uno stoccafisso? E’ una mia idea o quello se la tira un po? “. Mirella, come tutte le gazze, era caratteriale, piuttosto scontrosa, scorbutica. Ma il fascino esercitato da quell’uccelletto del cucù era troppo forte e lei, nonostante tutto l’orgoglio, non poteva (e non voleva) resistergli. “Che sia sensibile ai regali?”, pensò Mirella. Forse subiva anche lui l’attrazione degli oggetti lucenti. Chissà che quell’uccello, forse per timidezza, non avendo il coraggio di volar via da quella strana casetta, non avesse bisogno di qualche incoraggiamento? Mirella volò al suo nido e, preso un bottone dorato, lo posò sulla mensola a fianco del pendolo a cucù. Allo scoccare dell’ora, puntualmente, l’uccelletto fece capolino cantando e, senza rivolgere lo sguardo né a destra né a sinistra, ritornò dietro l’uscio. Forse il bottone era poca e misera cosa, pensò la gazza, e poco per volta si privò di tutto il suo patrimonio, accumulato di furto in furto. Cedette anche il pezzo più pregiato: l’orologio sottratto al capostazione mettendo a segno il colpo più bello della sua vita. Era innamorata persa, la povera Mirella. Innamorata senza speranza, ignara del fatto che l’uccello di legno dell’orologio a cucù non poteva corrisponderle l’affetto essendo un finto volatile, tutto legno e senza cuore. Così, dopo tutto quel gran darsi da fare senza ottenere in cambio nemmeno uno sguardo, con il cuore gonfio di amarezza, la gazza fece per riprendersi le sue cose ma, colmo della disperazione, oltre al bottone, ai tappi e alla spilla non trovò più l’orologio. Amleto Ballanzoni l’aveva visto sulla mensola e, incredulo, si era dato una gran manata in fronte: “Eccolo lì, il mio Perseo! Vecchio balordo, cominci a perdere i colpi! L’avevo davanti agli occhi e non riuscivo a vederlo da tanto ch’ero agitato. Meno male, va… D’ora in poi starò più attento a dove metto le cose”. Il capostazione, recuperato il prezioso orologio, decise di lasciare al suo posto anche il pendolo a cucù. Ormai faceva parte dell’arredamento. Funzionava bene e, per di più, era perfettamente in integrato con l’ambiente della stazione ferroviaria. L’unica modifica che Amleto decise di introdurre riguardava quel fastidioso cuculo che cantava, monotono, ogni ora. L’eliminazione avvenne senza troppe storie. Bastò spegnere il meccanismo della suoneria con l’apposita levetta e l’uccello restò, segregato e silenzioso, dentro la sua casetta trasformatasi in prigione. Mirella, ormai disperata, vedendo quella porticina sempre chiusa, decise di andarsene via, il più lontano possibile da quell’odioso uccello pieno di boria che chissà poi chi si credeva di essere. Volò via verso Loita dove conobbe, proprio la vigilia di Natale, una gazza maschio. Tra i due scoccò l’amore e di comune intesa, rastrellando oggetti in quattro e quattr’otto, abbellirono la loro dimora nel bosco che saliva verso Campino. Amleto Ballanzoni, intanto, fischiando e agitando la paletta all’arrivo e alla partenza dei treni nella sua stazione, con il berretto rosso in testa e l’orologio ben saldo alla catenella del panciotto, salutava i bambini che si sporgevano dai finestrini dei convogli gridando “E’ Babbo Natale! E’ Babbo Natale!”. L’uccelletto di legno riposò nella penombra della sua dimora in attesa di tornare a cantare allo scoccare di ogni ora. Può darsi che accadrà presto ma noi non lo sappiamo. Forse è anche già accaduto ma questa è un’altra storia.
“Ma come? Non avverte, quel pennuto, il mio fascino? Non incrocia mai il mio sguardo. Anzi, mi pare che tenga sempre gli occhi fissi davanti a se… E quel suo rimanere lì, impettito come uno stoccafisso? E’ una mia idea o quello se la tira un po? “. Mirella, come tutte le gazze, era caratteriale, piuttosto scontrosa, scorbutica. Ma il fascino esercitato da quell’uccelletto del cucù era troppo forte e lei, nonostante tutto l’orgoglio, non poteva (e non voleva) resistergli. “Che sia sensibile ai regali?”, pensò Mirella. Forse subiva anche lui l’attrazione degli oggetti lucenti. Chissà che quell’uccello, forse per timidezza, non avendo il coraggio di volar via da quella strana casetta, non avesse bisogno di qualche incoraggiamento? Mirella volò al suo nido e, preso un bottone dorato, lo posò sulla mensola a fianco del pendolo a cucù. Allo scoccare dell’ora, puntualmente, l’uccelletto fece capolino cantando e, senza rivolgere lo sguardo né a destra né a sinistra, ritornò dietro l’uscio. Forse il bottone era poca e misera cosa, pensò la gazza, e poco per volta si privò di tutto il suo patrimonio, accumulato di furto in furto. Cedette anche il pezzo più pregiato: l’orologio sottratto al capostazione mettendo a segno il colpo più bello della sua vita. Era innamorata persa, la povera Mirella. Innamorata senza speranza, ignara del fatto che l’uccello di legno dell’orologio a cucù non poteva corrisponderle l’affetto essendo un finto volatile, tutto legno e senza cuore. Così, dopo tutto quel gran darsi da fare senza ottenere in cambio nemmeno uno sguardo, con il cuore gonfio di amarezza, la gazza fece per riprendersi le sue cose ma, colmo della disperazione, oltre al bottone, ai tappi e alla spilla non trovò più l’orologio. Amleto Ballanzoni l’aveva visto sulla mensola e, incredulo, si era dato una gran manata in fronte: “Eccolo lì, il mio Perseo! Vecchio balordo, cominci a perdere i colpi! L’avevo davanti agli occhi e non riuscivo a vederlo da tanto ch’ero agitato. Meno male, va… D’ora in poi starò più attento a dove metto le cose”. Il capostazione, recuperato il prezioso orologio, decise di lasciare al suo posto anche il pendolo a cucù. Ormai faceva parte dell’arredamento. Funzionava bene e, per di più, era perfettamente in integrato con l’ambiente della stazione ferroviaria. L’unica modifica che Amleto decise di introdurre riguardava quel fastidioso cuculo che cantava, monotono, ogni ora. L’eliminazione avvenne senza troppe storie. Bastò spegnere il meccanismo della suoneria con l’apposita levetta e l’uccello restò, segregato e silenzioso, dentro la sua casetta trasformatasi in prigione. Mirella, ormai disperata, vedendo quella porticina sempre chiusa, decise di andarsene via, il più lontano possibile da quell’odioso uccello pieno di boria che chissà poi chi si credeva di essere. Volò via verso Loita dove conobbe, proprio la vigilia di Natale, una gazza maschio. Tra i due scoccò l’amore e di comune intesa, rastrellando oggetti in quattro e quattr’otto, abbellirono la loro dimora nel bosco che saliva verso Campino. Amleto Ballanzoni, intanto, fischiando e agitando la paletta all’arrivo e alla partenza dei treni nella sua stazione, con il berretto rosso in testa e l’orologio ben saldo alla catenella del panciotto, salutava i bambini che si sporgevano dai finestrini dei convogli gridando “E’ Babbo Natale! E’ Babbo Natale!”. L’uccelletto di legno riposò nella penombra della sua dimora in attesa di tornare a cantare allo scoccare di ogni ora. Può darsi che accadrà presto ma noi non lo sappiamo. Forse è anche già accaduto ma questa è un’altra storia.


