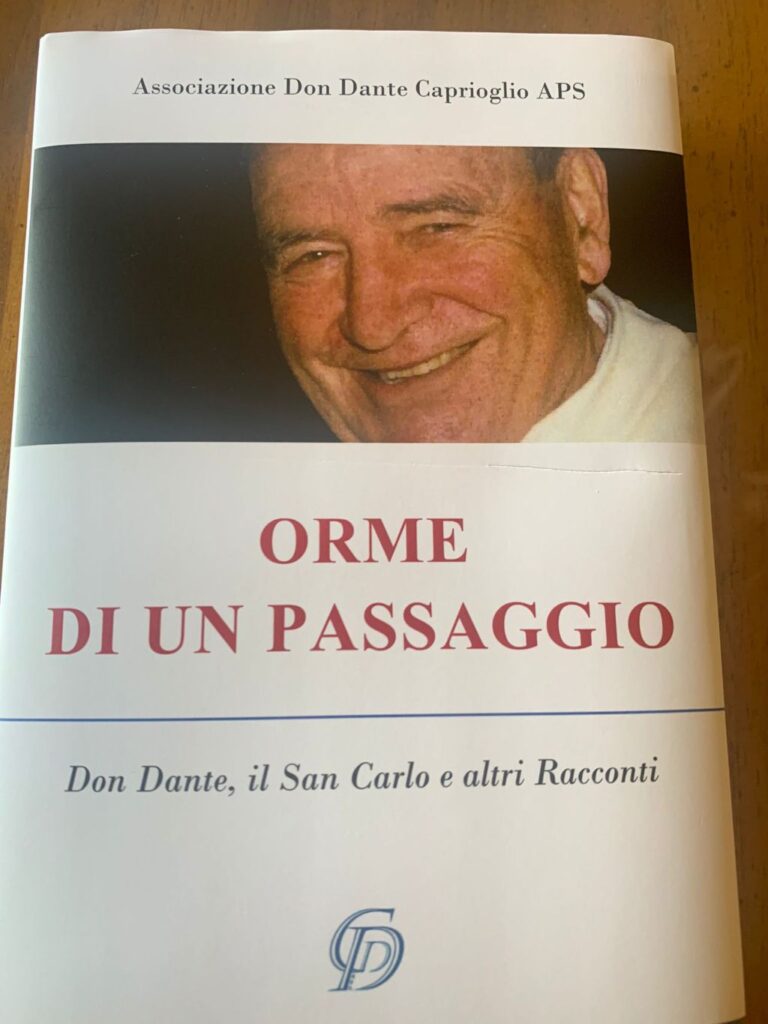MISIC TALES LA RUBRICA MUSICALE
“Poi il resto viene sempre da sé
I tuoi “Aiuto!” saranno ancora salvati
Io mi dico è stato meglio lasciarci
Che non esserci mai incontrati”
Fabrizio Cristiano De André, noto come Fabrizio De André (Genova, 18 febbraio 1940 – Milano, 11 gennaio 1999), è stato un cantautore italiano.
Ne abbiamo parlato la settimana scorsa e sono ancora ferma qui…siamo nel 1975, io ho tre anni, e si parla di un brano che si intitola “giugno ’73”, siamo temporalmente a due anni prima.
Spesso è difficile andare a fondo dei loro significati senza ricorrere a concetti banalizzanti oppure senza andare completamente fuori strada. Giugno ’73, in particolare, ha un testo abbastanza criptico che va compreso sulla base di vicende autobiografiche dell’autore. Infatti, qui De André racconta della fine di una sua relazione ed arriva a questa conclusione: meglio lasciarci che non esserci mai incontrati.
Innanzitutto va specificato, infatti, come Giugno ’73 sia autobiografica e per comprenderla occorre conoscere un minimo di contesto: De André si rivolge ad una donna, di nome Roberta, con cui ha avuto una relazione intensa e importante fra la prima e la seconda moglie.
Dalla prima il nostro autore è separato, pertanto dalla nuova “suocera” viene visto male, ma anche perché è un cantante e logicamente un artista per di più separato per la donna non può certo sembrare il partito ideale della figlia.
Ma De André si difende: sa fare quel che fa, ha avuto successo, non è un cantante mediocre o sconosciuto, infatti forse il suo talento è superiore alla capacità che ha la donna di vergognarsi di lui.
Come l’uccello del malaugurio (la gazza ladra) ci ha già fatto capire, la storia finirà per concludersi (ovvero l’accettazione mancata da parte della famiglia di lei), poi ce ne spiega un altro: i due sono diversi, troppo diversi, anche per le comitive che frequentano. E in effetti corrisponde a verità essendo questa Roberta una borghese. Le differenze sociali sono un ostacolo insormontabile. I due hanno troppo poco in comune.
Chiude con “meglio essersi lasciati che amati mai”
“Alcune persone non meritano il nostro sorriso, figuriamoci le nostre lacrime.”
Buon ascolto del brano, che possa far parte del vostro bagaglio
https://www.youtube.com/watch?v=9j-8gbIbc6E&ab_channel=FabrizioDeAndr%C3%A9-Topic
 Chiara De Carlo
Chiara De Carlo
scrivete a musictales@libero.it se volete segnalare eventi o notizie musicali!
Ecco a voi gli eventi della settimana!





 Era l’opera che Cesare Pavese – scrittore, poeta, traduttore, critico letterario, fra i maggiori intellettuali del secolo scorso –considerava come la più importante del suo percorso di scrittura e della sua attività letteraria. Il suo “capriccio”, il suo “quarto di luna” ebbe a definire lui stesso i“Dialoghi con Leucò” (27 racconti brevissimi, a sfondo mitologico e simbolico in cui divinità ed eroi della Grecia classica discutono i grandi temi universali dell’esistenza) in occasione della prima pubblicazione nel 1947. Libro per lui così importante (“l’unico che valga qualcosa”, scriveva manu propria in una lettera indirizzata a Parigi, il 25 agosto del ’50, al critico cinematografico Nino Frank) da diventare spazio su cui lasciare impresse le sue ultime parole rivolte al mondo. Era il 27 agosto del 1950, quando il corpo senza vita di Cesare Pavese, nato il 9 settembre del 1908 a Santo Stefano Belbo nell’Alta Langa, fu trovato disteso sul letto – dopo avere ingerito oltre dieci bustine di sonnifero- in una camera dell’albergo “Roma” in piazza Carlo Felice a Torino, dove soggiornava dal giorno precedente. Accanto, sul tavolino, a fargli compagnia nel suo estremo viaggio, proprio il libro da lui più amato, i “Dialoghi con Leucò”, recanti sulla prima pagina le sue ultime parole: “Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate troppi pettegolezzi”. Qualche mese prima, nel giugno del ’50, aveva vinto il “Premio Strega” con “La bella estate” e, dieci giorni prima, aveva scritto sul diario (pubblicato postumo nel 1952 con il titolo “Il mestiere di vivere. Diario 1935 – 1950”): “Questo il consuntivo dell’anno non finito, che non finirò…Tutto questo fa schifo. Non parole. Un gesto. Non scriverò più”. Parole che scavano l’anima, in cui si legge a chiare lettere il profondo disagio esistenziale di un uomo, di uno scrittore per cui tutto è ormai buio totale. Silenzio, dolore, massacro dell’anima. La sua fama superò di gran lunga, però, la sua breve vita. E le sue parole, le sue opere, continuano e continueranno ad accompagnarci come fossero appena partorite dalla sua penna e dal suo pensiero. Nasce di qui l’dea di omaggiare il grande scrittore di Santo Stefano Belbo con una nuova proposta editoriale, nata dalla collaborazione fra la “Fondazione Cesare Pavese” ed “Emons” dedicata proprio ai suoi tanto amati “Dialoghi”: una proposta da leggere e da ascoltare, un audiolibro con le voci recitanti di sei attori (fra i più apprezzati del panorama teatrale italiano, da Michela Cescon a Paolo Cresta, da Alessandro Curti a Marcello Fois a Iaia Forte e a Neri Marcoré), accompagnato dal libro cartaceo, con la curatela dello scrittore Marcello Fois, che andrà a far parte della nuova collana “Double face” di “Emons”, editrice leader nella realizzazione di audiolibri. Così, nell’anno in cui sono scaduti i diritti per la pubblicazione delle opere pavesiane, i “Dialoghi con Leucò” saranno presentati, nella nuova veste editoriale, il prossimo giovedì 9 settembre, giorno del compleanno di Pavese, a Santo Stefano Belbo (Cn) nel corso del “Pavese Festival”, organizzato ogni anno dalla “Fondazione” a lui dedicata e diretta da Pierluigi Vaccaneo. Alle ore 18.30, sul palco di Piazza Umberto I, Marcello Fois, la “Fondazione” ed “Emons” racconteranno il progetto e leggeranno, con sottofondo musicale di Gavino Murgia, diverse pagine dei racconti. Alle ore 21.30 l’attore Alessandro Preziosi proporrà in prima nazionale un ampio viaggio, tra letture e musica, nell’opera di Pavese. “Nei ‘Dialoghi con Leucò’ il lettore trova uno specchio – spiega Pierluigi Vaccaneo – in cui trovare e ritrovare il proprio percorso umano, attraverso il Mito e la traduzione che del Mito fa Pavese stesso. I ‘Dialoghi’ sono dunque una conversazione a più voci, dove lettore, autore, personaggi e Mito sono sullo stesso piano, svelati. Dare voce a questo dialogo, attraverso l’audiolibro che assieme a ‘Emons’ abbiamo realizzato, è offrire a un pubblico sempre più vasto, attraverso grandi artisti italiani, una nuova opportunità di conoscenza e consapevolezza. Una sfida che la casa editrice Emons ha accolto con entusiasmo e passione, condividendo una visione inclusiva e partecipata della cultura che la nostra ‘Fondazione’ sta portando avanti con le sue diverse attività”.
Era l’opera che Cesare Pavese – scrittore, poeta, traduttore, critico letterario, fra i maggiori intellettuali del secolo scorso –considerava come la più importante del suo percorso di scrittura e della sua attività letteraria. Il suo “capriccio”, il suo “quarto di luna” ebbe a definire lui stesso i“Dialoghi con Leucò” (27 racconti brevissimi, a sfondo mitologico e simbolico in cui divinità ed eroi della Grecia classica discutono i grandi temi universali dell’esistenza) in occasione della prima pubblicazione nel 1947. Libro per lui così importante (“l’unico che valga qualcosa”, scriveva manu propria in una lettera indirizzata a Parigi, il 25 agosto del ’50, al critico cinematografico Nino Frank) da diventare spazio su cui lasciare impresse le sue ultime parole rivolte al mondo. Era il 27 agosto del 1950, quando il corpo senza vita di Cesare Pavese, nato il 9 settembre del 1908 a Santo Stefano Belbo nell’Alta Langa, fu trovato disteso sul letto – dopo avere ingerito oltre dieci bustine di sonnifero- in una camera dell’albergo “Roma” in piazza Carlo Felice a Torino, dove soggiornava dal giorno precedente. Accanto, sul tavolino, a fargli compagnia nel suo estremo viaggio, proprio il libro da lui più amato, i “Dialoghi con Leucò”, recanti sulla prima pagina le sue ultime parole: “Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate troppi pettegolezzi”. Qualche mese prima, nel giugno del ’50, aveva vinto il “Premio Strega” con “La bella estate” e, dieci giorni prima, aveva scritto sul diario (pubblicato postumo nel 1952 con il titolo “Il mestiere di vivere. Diario 1935 – 1950”): “Questo il consuntivo dell’anno non finito, che non finirò…Tutto questo fa schifo. Non parole. Un gesto. Non scriverò più”. Parole che scavano l’anima, in cui si legge a chiare lettere il profondo disagio esistenziale di un uomo, di uno scrittore per cui tutto è ormai buio totale. Silenzio, dolore, massacro dell’anima. La sua fama superò di gran lunga, però, la sua breve vita. E le sue parole, le sue opere, continuano e continueranno ad accompagnarci come fossero appena partorite dalla sua penna e dal suo pensiero. Nasce di qui l’dea di omaggiare il grande scrittore di Santo Stefano Belbo con una nuova proposta editoriale, nata dalla collaborazione fra la “Fondazione Cesare Pavese” ed “Emons” dedicata proprio ai suoi tanto amati “Dialoghi”: una proposta da leggere e da ascoltare, un audiolibro con le voci recitanti di sei attori (fra i più apprezzati del panorama teatrale italiano, da Michela Cescon a Paolo Cresta, da Alessandro Curti a Marcello Fois a Iaia Forte e a Neri Marcoré), accompagnato dal libro cartaceo, con la curatela dello scrittore Marcello Fois, che andrà a far parte della nuova collana “Double face” di “Emons”, editrice leader nella realizzazione di audiolibri. Così, nell’anno in cui sono scaduti i diritti per la pubblicazione delle opere pavesiane, i “Dialoghi con Leucò” saranno presentati, nella nuova veste editoriale, il prossimo giovedì 9 settembre, giorno del compleanno di Pavese, a Santo Stefano Belbo (Cn) nel corso del “Pavese Festival”, organizzato ogni anno dalla “Fondazione” a lui dedicata e diretta da Pierluigi Vaccaneo. Alle ore 18.30, sul palco di Piazza Umberto I, Marcello Fois, la “Fondazione” ed “Emons” racconteranno il progetto e leggeranno, con sottofondo musicale di Gavino Murgia, diverse pagine dei racconti. Alle ore 21.30 l’attore Alessandro Preziosi proporrà in prima nazionale un ampio viaggio, tra letture e musica, nell’opera di Pavese. “Nei ‘Dialoghi con Leucò’ il lettore trova uno specchio – spiega Pierluigi Vaccaneo – in cui trovare e ritrovare il proprio percorso umano, attraverso il Mito e la traduzione che del Mito fa Pavese stesso. I ‘Dialoghi’ sono dunque una conversazione a più voci, dove lettore, autore, personaggi e Mito sono sullo stesso piano, svelati. Dare voce a questo dialogo, attraverso l’audiolibro che assieme a ‘Emons’ abbiamo realizzato, è offrire a un pubblico sempre più vasto, attraverso grandi artisti italiani, una nuova opportunità di conoscenza e consapevolezza. Una sfida che la casa editrice Emons ha accolto con entusiasmo e passione, condividendo una visione inclusiva e partecipata della cultura che la nostra ‘Fondazione’ sta portando avanti con le sue diverse attività”.
 Un manifesto che si potrebbe definire corporativo. Non ho più risposto di recente sul tema delle foibe a Barbero che ho la colpa di aver contribuito a far conoscere quando era un modesto professorino di Pinerolo e non esibiva davanti a me la gloriosa tessera del PCI firmata da Berlinguer oggi ostentata come una reliquia . Ho chiuso il discorso con lui in un capitoletto a lui dedicato nel mio ultimo libro e non intendo riaprire il discorso oggi che, seguendo il suo degno compare Montanari, contesta il giorno del ricordo del 10 febbraio vedendolo come una risposta di stampo fascista alla giornata della memoria. Barbero dimentica perfino che quel giorno venne votato dal pds e sostenuto da Violante e Fassino. Ma forse ha l’attenuante che nel 2004 ,quando venne istituito il giorno del ricordo, forse egli si occupava solo di Medio Evo e non seguiva più la politica, essendo ormai un orfano inconsolabile del suo amato PCI. Non posso tuttavia non ricordargli che il 10 febbraio è la data del Trattato di pace che privò l’Italia dei suoi territori dell’Adriatico Orientale è una data infausta della nostra storia imposta dalla sinistra per votare il giorno del ricordo: un compromesso all’italiana anche sulle vittime delle foibe. Non è il caso di attenzionare ulteriormente Barbero , ma non si può non condannare con tutta la durezza necessaria l’ennesima comparsata mediatica sul Green Pass che è stata condannata persino da Gramellini il quale ha definito ipocrita la posizione del Vercellese. Barbero e i suoi colleghi che condannano il green pass si credono dei cittadini speciali in diritto di ribellarsi alle norme sancite da un governo democratico che gode della fiducia del Parlamento. Forse essi vedono il Green pass come il giuramento imposto ai professori dal Fascismo, mentre si rivelano soltanto dei cittadini poco responsabili. I professori dovrebbero dare per primi l’esempio. Innanzi tutto si loro studenti. Certi manifesti ci portano a pensare, seppur in tempi e contesti differenti, ai documenti degli anni 70 che armarono la mano agli assassini del commissario Calabresi. Chissà cosa penserebbe di Barbero il suo maestro Giovanni Tabacco che era un uomo pacato e uno scienziato che non cercò mai visibilità. Una volta che venne a parlare al Centro Pannunzio, si stupì molto di un mio invito a Barbero. Aveva ragione. Mille volte ragione. Una volta o l’altra scriverò cosa mi disse.
Un manifesto che si potrebbe definire corporativo. Non ho più risposto di recente sul tema delle foibe a Barbero che ho la colpa di aver contribuito a far conoscere quando era un modesto professorino di Pinerolo e non esibiva davanti a me la gloriosa tessera del PCI firmata da Berlinguer oggi ostentata come una reliquia . Ho chiuso il discorso con lui in un capitoletto a lui dedicato nel mio ultimo libro e non intendo riaprire il discorso oggi che, seguendo il suo degno compare Montanari, contesta il giorno del ricordo del 10 febbraio vedendolo come una risposta di stampo fascista alla giornata della memoria. Barbero dimentica perfino che quel giorno venne votato dal pds e sostenuto da Violante e Fassino. Ma forse ha l’attenuante che nel 2004 ,quando venne istituito il giorno del ricordo, forse egli si occupava solo di Medio Evo e non seguiva più la politica, essendo ormai un orfano inconsolabile del suo amato PCI. Non posso tuttavia non ricordargli che il 10 febbraio è la data del Trattato di pace che privò l’Italia dei suoi territori dell’Adriatico Orientale è una data infausta della nostra storia imposta dalla sinistra per votare il giorno del ricordo: un compromesso all’italiana anche sulle vittime delle foibe. Non è il caso di attenzionare ulteriormente Barbero , ma non si può non condannare con tutta la durezza necessaria l’ennesima comparsata mediatica sul Green Pass che è stata condannata persino da Gramellini il quale ha definito ipocrita la posizione del Vercellese. Barbero e i suoi colleghi che condannano il green pass si credono dei cittadini speciali in diritto di ribellarsi alle norme sancite da un governo democratico che gode della fiducia del Parlamento. Forse essi vedono il Green pass come il giuramento imposto ai professori dal Fascismo, mentre si rivelano soltanto dei cittadini poco responsabili. I professori dovrebbero dare per primi l’esempio. Innanzi tutto si loro studenti. Certi manifesti ci portano a pensare, seppur in tempi e contesti differenti, ai documenti degli anni 70 che armarono la mano agli assassini del commissario Calabresi. Chissà cosa penserebbe di Barbero il suo maestro Giovanni Tabacco che era un uomo pacato e uno scienziato che non cercò mai visibilità. Una volta che venne a parlare al Centro Pannunzio, si stupì molto di un mio invito a Barbero. Aveva ragione. Mille volte ragione. Una volta o l’altra scriverò cosa mi disse.
 Ci eravamo conosciuti al Gruppo d‘Unione “Camillo di Cavour” con Vittorio Prunas Tola e Metello Rossi di Montelera. Fondammo insieme il centro studi “Gimmy Curreno“, il quindicenne patriota medaglia d’Oro al Valor Militare agli ordini di Mauri, eroicamente caduto per mano dei tedeschi. Eravamo ambedue impegnati per ricordare una Resistenza tricolore, volta a superare le vulgate ideologizzate. Un comune amico fu Domenico Giglio Presidente del circolo “Rex” di Roma, mancato in luglio. Pich aveva una cultura liberal-democratica e vide con simpatia la nascita del Centro Pannunzio , prendendo parte a qualche iniziativa. Fu lui a farmi conoscere ij Brande’, la poesia di Pinin Pacot e di Nino Costa. Un altro comune amico fu Tavo Burat che arrivò a dialettizzare anche il cognome. Fu uno dei fiori all’occhiello del centro studi piemontesi. Il suo identificarsi con la cultura e con la lingua piemontese contribuì ad allentare il nostro rapporto. Qualche volta tramite mio Mario Soldati gli chiedeva la corretta scrittura di parole piemontesi e la sua risposta era sempre pronta e dotta. Molto lontana, ad esempio, da Camillo Brero un maestro elementare sopravvalutato che Soldati non considerava affatto. Negli ultimi decenni ci eravamo persi perché da quando la Lega voleva salvaguardare a modo suo il patrimonio linguistico piemontese, inserendolo nell’insegnamento scolastico , io mi schierai nettamente contro e per una scuola nazionale uguale dalle Alpi alla Sicilia . Le idee di Farassino erano per me non degne della benché minima considerazione. Lui invece si rinchiuse sempre di più in difesa della piccola patria e della sua lingua. Un discorso che in verità non mi ha mai convinto e da cui anzi sono lontano. Detto con un esempio, io amo il Burzio scienziato della politica, molto meno il piemontese d’antan. Ritengo che funzione della scuola sia quella di insegnare un buon uso dell’Italiano , cosa che non fa come invece dovrebbe. Ma Censin era di un’altra idea e le nostre strade si allontanarono progressivamente. Pich ha messo una vera passione nel culto del vecchio Piemonte che per noi era anche il Piemonte sabaudo. Con lui scompare una razza piemontese , per dirla con Costa, in via di estinzione. Oggi abbiamo troppa gente che cita parole inglesi per moda e non sa l’italiano. Pich, pur sapendo benissimo l’Italiano, preferiva il piemontese, un piemontese letterario che non coincide con quello parlato ad Asti, a Cuneo o Vercelli. Di questo ed altro parlammo molte volte e mi addolora che una figura come lui non ci sia più. Era il simbolo di un vecchio Piemonte che resta parte della nostra storia migliore.
Ci eravamo conosciuti al Gruppo d‘Unione “Camillo di Cavour” con Vittorio Prunas Tola e Metello Rossi di Montelera. Fondammo insieme il centro studi “Gimmy Curreno“, il quindicenne patriota medaglia d’Oro al Valor Militare agli ordini di Mauri, eroicamente caduto per mano dei tedeschi. Eravamo ambedue impegnati per ricordare una Resistenza tricolore, volta a superare le vulgate ideologizzate. Un comune amico fu Domenico Giglio Presidente del circolo “Rex” di Roma, mancato in luglio. Pich aveva una cultura liberal-democratica e vide con simpatia la nascita del Centro Pannunzio , prendendo parte a qualche iniziativa. Fu lui a farmi conoscere ij Brande’, la poesia di Pinin Pacot e di Nino Costa. Un altro comune amico fu Tavo Burat che arrivò a dialettizzare anche il cognome. Fu uno dei fiori all’occhiello del centro studi piemontesi. Il suo identificarsi con la cultura e con la lingua piemontese contribuì ad allentare il nostro rapporto. Qualche volta tramite mio Mario Soldati gli chiedeva la corretta scrittura di parole piemontesi e la sua risposta era sempre pronta e dotta. Molto lontana, ad esempio, da Camillo Brero un maestro elementare sopravvalutato che Soldati non considerava affatto. Negli ultimi decenni ci eravamo persi perché da quando la Lega voleva salvaguardare a modo suo il patrimonio linguistico piemontese, inserendolo nell’insegnamento scolastico , io mi schierai nettamente contro e per una scuola nazionale uguale dalle Alpi alla Sicilia . Le idee di Farassino erano per me non degne della benché minima considerazione. Lui invece si rinchiuse sempre di più in difesa della piccola patria e della sua lingua. Un discorso che in verità non mi ha mai convinto e da cui anzi sono lontano. Detto con un esempio, io amo il Burzio scienziato della politica, molto meno il piemontese d’antan. Ritengo che funzione della scuola sia quella di insegnare un buon uso dell’Italiano , cosa che non fa come invece dovrebbe. Ma Censin era di un’altra idea e le nostre strade si allontanarono progressivamente. Pich ha messo una vera passione nel culto del vecchio Piemonte che per noi era anche il Piemonte sabaudo. Con lui scompare una razza piemontese , per dirla con Costa, in via di estinzione. Oggi abbiamo troppa gente che cita parole inglesi per moda e non sa l’italiano. Pich, pur sapendo benissimo l’Italiano, preferiva il piemontese, un piemontese letterario che non coincide con quello parlato ad Asti, a Cuneo o Vercelli. Di questo ed altro parlammo molte volte e mi addolora che una figura come lui non ci sia più. Era il simbolo di un vecchio Piemonte che resta parte della nostra storia migliore.