Alla scoperta dei monumenti di Torino / I lavori per il ricongiungimento della città storica con il Borgo Nuovo, stravolsero completamente l’area implicando la demolizione dello spalto al quale si appoggiava il giardino. Durante questa fase il monumento a Cesare Balbo subì uno spostamento provvisorio, per poi essere riposizionato, nei primi mesi del 1874, nella nuova Aiuola Balbo
Cari amici lettori e lettrici, eccoci nuovamente pronti per un’altra piacevole (si spera) ed interessante passeggiata per le vie della città alla scoperta delle sue affascinanti opere. Questa settimana vorrei parlarvi di un noto personaggio storico nato nel capoluogo piemontese e divenuto un personaggio di rilevante importanza per la città di Torino; sto parlando di Cesare Balbo e del monumento a lui dedicato. (Essepiesse)
La statua è situata in via Accademia Albertina sull’asse centrale dell’Aiuola Balbo, ai margini della vasca d’acqua centrale. Cesare Balbo è ritratto in posizione seduta, vestito in abiti borghesi con un ampio mantello sulle spalle; con la mano destra stringe gli occhiali, mentre sul ginocchio sinistro tiene aperto con la mano il libro “Le speranze d’Italia”, libro da lui scritto, pubblicato nel 1844 a Parigi e dedicato all’ideale politico dell’unificazione italiana.
Cesare Balbo nacque a Torino il 21 novembre del 1789 da Prospero Balbo già sindaco di Torino e ambasciatore di Parigi ed Enrichetta Taparelli D’Azeglio, fu un uomo politico, scrittore e Presidente del Consiglio del Regno di Sardegna. Cesare Balbo maturò culturalmente in varie città europee a causa della continua peregrinazione che il padre dovette subire nei difficili anni del regno di Vittorio Amedeo III di Savoia; fu così che venne a contatto con le nuove teorie illuministiche che, in quegli anni, stavano prendendo sempre più piede nei maggiori centri culturali europei.
Fu propugnatore dell’indipendenza d’Italia dal dominio austriaco ed uno dei più importanti esponenti della cultura liberale piemontese. Nel 1848, dopo la concessione dello Statuto Albertino, divenne presidente del primo Ministero costituzionale piemontese e fu deputato del Parlamento Subalpino fino alla sua scomparsa. Immediatamente dopo la sua morte, avvenuta a Torino il 3 giugno 1853, alcuni cittadini torinesi decisero di erigergli una statua alla memoria. Venne istituito il “Comitato per l’erezione di un monumento a Cesare Balbo” presieduto da Cesare Alfieri di Sostegno e del quale facevano parte Giuseppe Arconati, Ottavio di Revel, Federico Scoplis e Luigi Torelli.
Apertasi una pubblica sottoscrizione, in pochi mesi la cifra raggiunta superò le 10.000 lire delle quali circa la metà fu costituita da oblazioni private, mentre la restante parte venne donata da enti pubblici. Per ciò che riguardava invece il concorso del Municipio di Torino, si fu inizialmente orientati su due ipotesi diverse: rendere disponibile un’area all’interno del Camposanto generale oppure, nel caso il Comitato avesse voluto erigerlo in sito pubblico, concorrere economicamente alla sua realizzazione. Essendo scelta la seconda opzione, il Municipio decise di stanziare la somma di 3.000 lire, alla quale si aggiunsero i contributi dei Municipi di Pinerolo, Susa e della Provincia di Torino (1.000 lire), raggiungendo così la cifra di 10.554 lire.
Della realizzazione dell’opera venne incaricato Vincenzo Vela (lo stesso autore dell’opera già vista da noi “Alfiere dell’ Esercito Sardo”), da pochi mesi professore di scultura dell’Accademia Albertina di Torino. Vela scelse di rappresentare Cesare Balbo in una posa “naturale”, in un atteggiamento anche posturale, che ricordasse la sua vita, il suo lavoro ed anche il suo impegno di letterato e di scrittore. Per la realizzazione del monumento vennero versate a Vela circa £ 10.000, mentre le rimanenti 554 lire furono spese per la realizzazione di una cancellata di protezione.
Nei primi mesi del 1856, Cesare Alfieri propose al Sindaco Notta di posizionare l’opera nel Giardino dei Ripari, tra il nascente Borgo Nuovo e la città storica; il 5 giugno 1856 il Consiglio Comunale, venendo incontro a questa richiesta, diede il suo consenso alla collocazione della statua in cima al declivio che dalla via della Madonna degli Angeli conduce al Giardino. Il monumento a Cesare Balbo venne inaugurato l’8 luglio del 1856 ed in questa occasione venne donato al Municipio che lo accettò ufficialmente nella seduta del Consiglio Comunale del 15 novembre 1856.
In seguito però, nel 1872 delle nuove politiche condussero alla riconfigurazione dell’area occupata dal Giardino dei Ripari; i pesanti lavori per il ricongiungimento della città storica con il Borgo Nuovo, stravolsero completamente l’area implicando la demolizione dello spalto al quale si appoggiava il giardino. Durante questa fase il monumento a Cesare Balbo subì uno spostamento provvisorio, per poi essere riposizionato, nei primi mesi del 1874, nella nuova Aiuola Balbo dove ancora oggi si può ammirare. Purtroppo, durante la seconda guerra mondiale l’opera venne danneggiata durante i bombardamenti.
Visto che abbiamo accennato alla realizzazione della “nuova” Aiuola Balbo, ricordiamo che essa è un giardino d’origine tardo ottocentesca; è caratterizzata dall’essere realizzata su terrapieno e quindi delimitata da un perimetro murario che la isola, sollevandola, dalle strade che la circondano. Di forma rettangolare, ha come fulcro una importante fontana centrale ed è piantumata con alberi disposti in modo naturale lungo tutto il perimetro.
Il disegno definitivo dell’Aiuola Balbo venne realizzato nel 1873 dall’ingegnere capo Pecco, che progettò un giardino totalmente verde, sollevato di circa un metro e mezzo al di sopra del piano stradale. I monumenti a Cesare Balbo, Eusebio Bava e Daniele Manin vennero ricollocati in modo simmetrico e armonico nell’Aiuola Balbo, nel centro del giardino sul suo asse longitudinale; l’ inserimento dell’ importante fontana centrale vennedeciso solo più tardi, nel febbraio 1874. L’Aiuola Balbo, inaugurata il 19 settembre 1874, oggi ospita complessivamente sei monumenti che la caratterizzano come un giardino dedicato ai patrioti attivi nei moti per l’indipendenza degli stati europei.
Simona Pili Stella
Foto G i a n n i C a n e d d u




 Ingredienti (per 4 persone – circa 500 g di polpette):
Ingredienti (per 4 persone – circa 500 g di polpette):





 RUBRICA SETTIMANALE A CURA DI LAURA GORIA
RUBRICA SETTIMANALE A CURA DI LAURA GORIA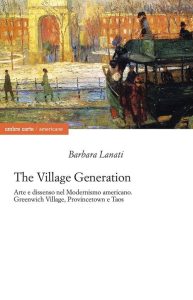 In questo libro -scorrevole e appassionante come un romanzo- ripercorre idee e azioni della generazione di uomini e donne, nata a fine Ottocento, che ha dato il via a cambiamenti epocali, in campo sociale e culturale ed impresso un’accelerazione agli albori del Novecento.
In questo libro -scorrevole e appassionante come un romanzo- ripercorre idee e azioni della generazione di uomini e donne, nata a fine Ottocento, che ha dato il via a cambiamenti epocali, in campo sociale e culturale ed impresso un’accelerazione agli albori del Novecento. Questo libriccino è un’autentica perla preziosa, rara e purtroppo difficile da trovare. L’ha scritto il poeta e scrittore Marco Tornar, nato a Pescara nel 1960, dov’è morto improvvisamente per un malore nel 2015, a soli 54 anni. Uomo di grande sensibilità e profonda cultura, innata classe, una vita dedicata alla poesia e alla patria delle lettere.
Questo libriccino è un’autentica perla preziosa, rara e purtroppo difficile da trovare. L’ha scritto il poeta e scrittore Marco Tornar, nato a Pescara nel 1960, dov’è morto improvvisamente per un malore nel 2015, a soli 54 anni. Uomo di grande sensibilità e profonda cultura, innata classe, una vita dedicata alla poesia e alla patria delle lettere. Mailer è un gigante della letteratura mondiale, nato in New Jersey nel 1923, morto a New York nel 2007, dopo una vita densa come poche altre.
Mailer è un gigante della letteratura mondiale, nato in New Jersey nel 1923, morto a New York nel 2007, dopo una vita densa come poche altre. 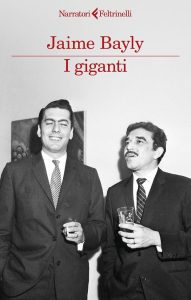 Un lutto ha segnato recentemente il mondo letterario; la morte dello scrittore peruviano Mario Vargas Llosa, nato ad Arequipa il 28 marzo 1936, morto a Lima il 13 aprile scorso 2025. Aveva festeggiato da poco l’89esimo compleanno, circondato dai familiari.
Un lutto ha segnato recentemente il mondo letterario; la morte dello scrittore peruviano Mario Vargas Llosa, nato ad Arequipa il 28 marzo 1936, morto a Lima il 13 aprile scorso 2025. Aveva festeggiato da poco l’89esimo compleanno, circondato dai familiari. 









