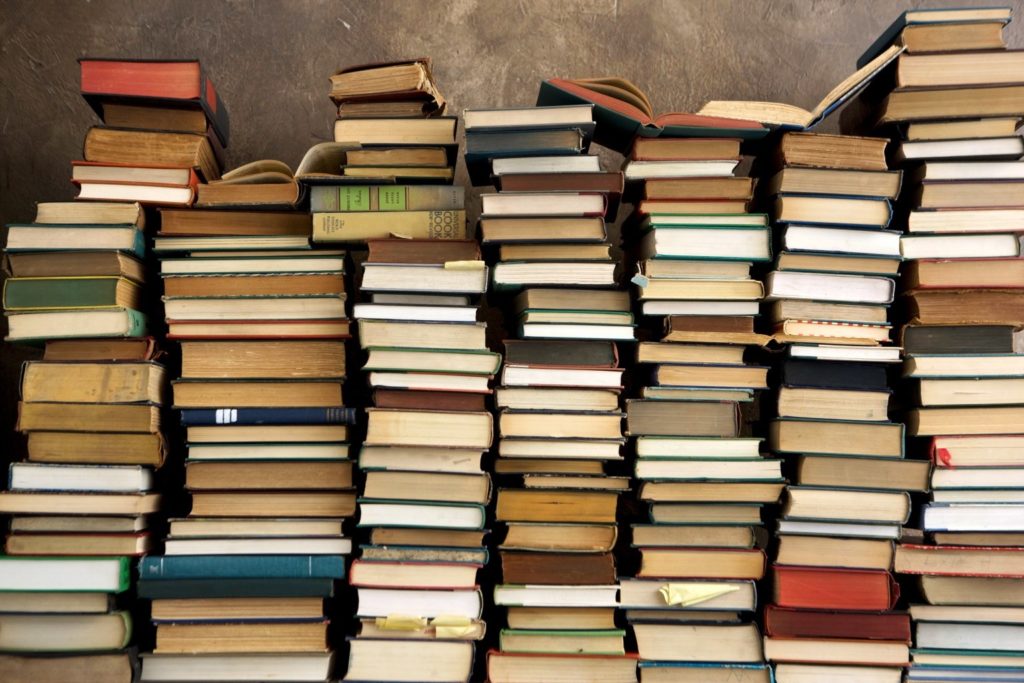Fa parte della sua trilogia romantica definita da Sinopoli esempio di “arte povera”
Sarà Donato Renzetti a dirigere l’Orchestra del Teatro Regio di Torino venerdì 14 dicembre prossimo alle 20 per la prima della Traviata di Giuseppe Verdi, per la regia di Henning Brockhaus e la coreografia di Valentina Escobar. Nel ruolo di Violetta il soprano Maria Grazia Schiavo, in quello di Alfredo Germont Dmytro Popov; in quello di Giorgio Germont Giovanni Meoni; Anna Malavasi vestirà i panni di Flora Bervoix. Verdi scelse il soggetto della Traviata consapevole della sua eccezionalità, traendolo dal dramma “Dame aux camelias” di Alexander Dumas figlio, rappresentato a partire dal febbraio 1852 al Theatre del Vaudeville a Parigi. La Traviata verdiana, che avrebbe incontrato nella sua storia un clamoroso successo, registro’, invece, nella sua prima esecuzione un fiasco, al teatro La Fenice di Venezia, il 6 marzo 1853, per poi riscattarsi sempre a Venezia. Ultima opera della celebre “trilogia romantica” comprendente il Rigoletto ed il Trovatore, con le cui fasi conclusive venne a sovrapporsi nella sua genesi, la Traviata esprime il tema della denuncia dei pregiudizi e delle ipocrisie presenti nella società borghese, di cui Verdi era rimasto in quegli anni vittima nel corso della sua relazione con Giuseppina Strepponi. Ispiratrice della storia riportata nel romanzo, in un contesto decadente, era un personaggio realmente esistito nella prima metà del secolo, Marie Duplessis, ragazza di facili costumi, morta a sol 23 anni di tubercolosi, frequentatrice di ambienti intellettuali, che la posero a contatto con Liszt, Alfred de Musset e Dumas stesso. La Traviata, insieme a “Carmen” e “Boheme”, è l’opera del repertorio lirico più eseguita al mondo. Secondo alcuni critici si tratta di un capolavoro assoluto, secondo altri di un’opera media, se non addirittura mediocre, in cui Verdi ricorre alle consuetudini del melodramma. In realtà si tratta di un’opera straordinaria, ricca di un genio drammatico che non soltanto esce fuori dall’applicazione di regole consuete. La censura volle che la vicenda, ricca di scandali, di una donna che trascorreva la sua vita nell’alta società tra relazioni fugaci fosse retrodatata al Settecento. Fino alla fine dell’Ottocento rimase in voga questa prassi; in seguito l’ambientazione di Verdi e del suo librettista Piave fu ristabilita, diventando la rappresentazione di una nuova società con nuovi problemi etici. L’opera, articolata in tre atti, è fondata su di un dramma interiore, sulla reputazione sociale e su di un amore che diventa impossibile. Il tema, assolutamente innovativo, è incentrato, infatti, sull’impossibilità da parte della protagonista femminile di amare ed essere amata, imposto dalla società. Ancor prima di morire, Violetta è gi morta anche perché , se mutata dall’amore, per tutti rimane, comunque, una prostituta alla quale non è permesso ondurre una vita normale. Quest’opera è definita dal grande direttore Giuseppe Sinopoli un esempio di “arte povera” per la semplicità delle sue forme, unita alla sua forte passionalità. erdi fu criticato per il suo formalismo e fu considerato unico personaggio dell’opera Violetta, igmirando del tutto il ruolo di Germont. La scelta di formalizzare le strutture musicali fu dettata in Verdi da un preciso indirizzo estetico; il “Brindisi”e l’aria ” Di Provenza il mar, il suol” dimostrano come la prassi melodrammatica venga rispettata in ogni suo aspetto con il tema dell’aria introdotto dall’orchestra. Con la Traviata si avvia in Verdi un processo verso la drammatizzazione e la scomparsa del recitativo propriamente detto, con la costruzione di un tessuto musicale di contini crescendo, con un coup de theatre finale, seguendo quella struttura che era stata creata ed era cara a Donizetti.
Mara Martellotta