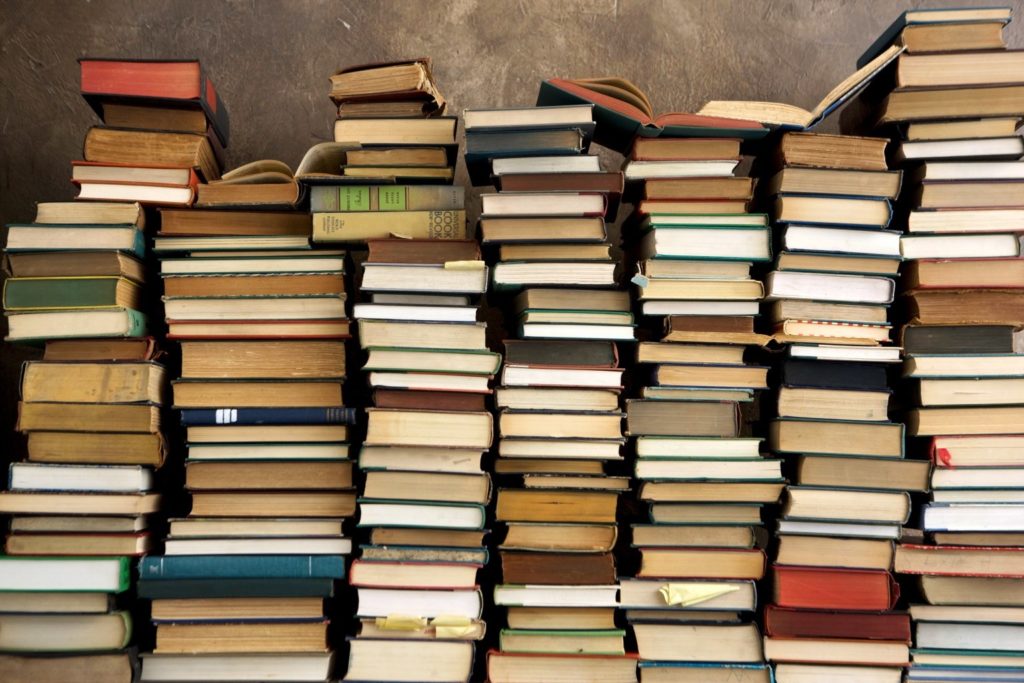Trionfo della sua pittura post espressionista, declinata nella variante di un dialogo tra il chiaro e lo scuro

“Legal Contest. Opere civili ed Opere penali” è il titolo della personale dell’artista torinese Pier Tancredi de-Coll’ che si inaugurerà mercoledì 27 marzo prossimo nella storica sede della Fondazione Croce, a palazzo Capris, in via Santa Maria 1. Saranno presenti insieme all’artista lo scrittore torinese Federico Audisio di Somma, che ha curato con il pittore alcuni volumi di arte e prosa, la curatrice di libri d’arte Paola Gribaudo, l’avvocato Emiliana Olivieri, segretaria della Fondazione Croce, insieme alla storica dell’arte Liletta Fornasari, cui si deve la curatela della mostra. La dicotomia del chiaro e dello scuro rappresenta il fil rouge di un’esposizione in cui emerge in tutta la sua evidenza il carattere post espressionista della pittura di Tancredi de-Coll’, un chiaro ed uno scuro che sono espressioni non soltanto cromatiche, ma sono capaci, invece, di  diventare metafore delle inquietudini espresse dalle tematiche che emergono dalle opere. È post espressionista la pittura di Pier Tancredi de-Coll’, in quanto risulta capace di inglobare una visione soggettiva sia nell’uso del colore, sia nella scelta dei soggetti figurativi, dai ritratti ai paesaggi, fino alle scene di vita quotidiana. L’uso che egli fa del colore risponde, infatti, ad una funzione emozionale e passionale, accompagnata da una estrema semplificazione delle forme, con una netta eliminazione degli elementi superflui. Tancredi de-Coll’, artista che ha mosso i suoi primi passi nel mondo della pittura presso lo studio del pittore Serafino “Sergi” Geninatti, ha poi esordito come vignettista per i quotidiani torinesi Stampa Sera (1982-95) e La Stampa (1984-1995), imponendosi come uno dei massimi rappresentanti della grafica italiana. Particolarmente significativa la sinergia che si è creata negli anni tra Tancredi de-Coll’ e lo scrittore torinese Federico Audisio di Somma, accomunati dal carattere post espressionista delle rispettive arti. Insieme il vincitore del Premio Bancarella nel 2002 per il romanzo intitolato “L’uomo che curava i fiori” ed il pittore hanno realizzato opere di disegni e
diventare metafore delle inquietudini espresse dalle tematiche che emergono dalle opere. È post espressionista la pittura di Pier Tancredi de-Coll’, in quanto risulta capace di inglobare una visione soggettiva sia nell’uso del colore, sia nella scelta dei soggetti figurativi, dai ritratti ai paesaggi, fino alle scene di vita quotidiana. L’uso che egli fa del colore risponde, infatti, ad una funzione emozionale e passionale, accompagnata da una estrema semplificazione delle forme, con una netta eliminazione degli elementi superflui. Tancredi de-Coll’, artista che ha mosso i suoi primi passi nel mondo della pittura presso lo studio del pittore Serafino “Sergi” Geninatti, ha poi esordito come vignettista per i quotidiani torinesi Stampa Sera (1982-95) e La Stampa (1984-1995), imponendosi come uno dei massimi rappresentanti della grafica italiana. Particolarmente significativa la sinergia che si è creata negli anni tra Tancredi de-Coll’ e lo scrittore torinese Federico Audisio di Somma, accomunati dal carattere post espressionista delle rispettive arti. Insieme il vincitore del Premio Bancarella nel 2002 per il romanzo intitolato “L’uomo che curava i fiori” ed il pittore hanno realizzato opere di disegni e  pittura quali “Il jazz del torello verde” e “Femmes, donne elettriche” (1984) con la prefazione di Gianni Versace. Secondo premio al Concorso “Sunday Painters 2015”, in occasione della Fiera internazionale di Arte contemporanea Artissima di Torino, Tancredi de-Coll’ ha poi ottenuto il primo premio della giuria della Mostra internazionale Artes 2017. Lo scorso anno ha esposto in una personale curata da Diletta Fornasari presso la Galleria Comunale di arte contemporanea di Arezzo. Prossimi suoi appuntamenti artistici saranno la partecipazione fino al 27 aprile prossimo alla manifestazione curata a Vieste da Stefania Maggiulli Alfieri e, dal 10 al 26 maggio prossimi, ad una personale a Salerno curata dal maestro Antonio Perotti, presso il Teatro delle Arti.
pittura quali “Il jazz del torello verde” e “Femmes, donne elettriche” (1984) con la prefazione di Gianni Versace. Secondo premio al Concorso “Sunday Painters 2015”, in occasione della Fiera internazionale di Arte contemporanea Artissima di Torino, Tancredi de-Coll’ ha poi ottenuto il primo premio della giuria della Mostra internazionale Artes 2017. Lo scorso anno ha esposto in una personale curata da Diletta Fornasari presso la Galleria Comunale di arte contemporanea di Arezzo. Prossimi suoi appuntamenti artistici saranno la partecipazione fino al 27 aprile prossimo alla manifestazione curata a Vieste da Stefania Maggiulli Alfieri e, dal 10 al 26 maggio prossimi, ad una personale a Salerno curata dal maestro Antonio Perotti, presso il Teatro delle Arti.
Mara Martellotta