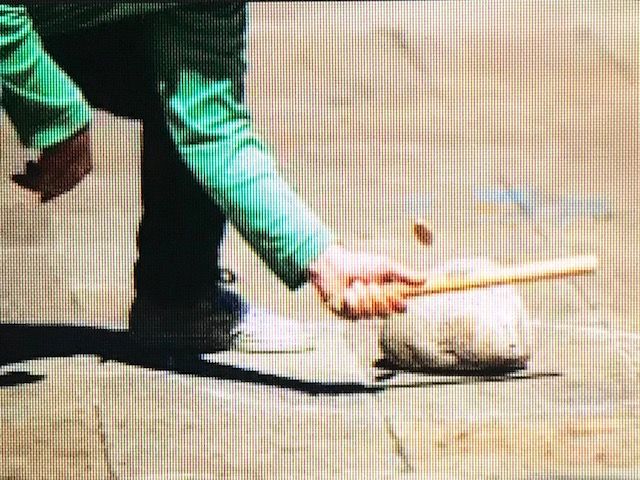La notizia, lì e nei dintorni, girava già da qualche settimana. A mezza voce, tra ammiccamenti e gomitate, si era sparsa la voce che “La Beccaccia”, un’osteria con locanda, ospitasse una signora dedita alla promozione dell’altrui piacere.

Ovviamente, dietro pagamento di una modica somma perché, com’è noto, il “mestiere più vecchio del mondo”, come tutte le attività che si rispettino, non era gratis. Natalino e Pacifico, un po’ per curiosità, un po’ per l’indole trasgressiva che li accomunava, decisero di andare a vedere se quanto si sentiva dire corrispondesse poi al vero. “Un sopralluogo s’impone”, sentenziò Pacifico, che per mestiere s’occupava a tempo pieno della tutela dei lavoratori ( “di tutti i lavoratori”). Ovviamente Natalino, operaio e pubblico amministratore, non obiettò alcunché, trovandosi d’accordo con l’amico in tutto e per tutto. Quindi, inforcate le bici, partirono. La strada non era molta tra il loro paese e quello dell’osteria. Pedalando di buona gamba, i sette chilometri e mezzo s’accorciarono in un baleno e i due amici, raggiunto il campanile del paese, svoltarono a sinistra, imboccando la strada che saliva verso la stazione ferroviaria, dove – un po’ prima dello spiazzo davanti all’edificio – si scorgeva, sulla facciata di una vecchia casa a due piani, l’insegna de “La Beccaccia”. Lasciate le bici- nell’apposita rastrelliera collocata tra la Stazione e la locanda, i due entrarono. L’oste, tal Tossichini Aristide, detto “Burbero” per il carattere
ruvido e scontroso, in maniche di camicia, era intento ad asciugare dei bicchieri. Vedendo comparire sull’uscio Natalino e Pacifico, non tradì particolare curiosità. Continuando a passare i calici nell’asciugamano, senza dire una sola parola e con un cenno del mento, chiese ragione della loro presenza. Un po’ impacciati, i due esitarono a parlare per qualche istante. Poi, incrociato lo sguardo interrogativo del Tossichini, Natalino prese coraggio e, schiaritasi la voce, chiese: “Si può vederla?”. “Burbero”, senza scomporsi più di tanto, con fare svogliato, indicò la scala in fondo al locale che portava al piano superiore. I due amici, ringraziando, salirono svelti i gradini di legno, trovandosi davanti ad un corridoio dove, da una parte e dall’altra, s’aprivano tre
porte. Due a sinistra e una a destra. Quale delle tre era quella giusta? Tentarono a destra ma la porta era chiusa a chiave. Afferrata la maniglia della prima a sinistra, il risultato fu lo stesso: bloccata. Rimaneva l’ultima porta. E questa s’aprì, con un lieve cigolio. Entrati nella stanza, restarono a bocca aperta, sgranando gli occhi davanti alla scena che si presentò davanti al loro sguardo smarrito. Altro che femmina compiacente e lussuriosa! Nella penombra della stanza, sdraiata sul letto, vestita di nero e con il rosario in mano, s’intravvedeva il cadavere di un’anziana donna. Ai fianchi del letto quattro grossi ceri accesi diffondevano una luce tremolante e fioca da far venire i brividi. Pacifico e Natalino si guardarono in faccia e, quasi di scatto, fecero dietrofront, uscendo dalla stanza, chiudendosi rumorosamente la porta alle spalle. La scala dalla quale erano saliti con un po’ d’imbarazzo e circospezione, venne ridiscesa in fretta e furia. Quell’impazienza insospettì l’oste che non ci mise molto a capire la situazione, considerando che i due non erano i primi a sbagliare indirizzo e credere che nella sua locanda si praticasse il mercimonio. Rosso in volto, furibondo perché i due avevano scambiato la vecchia zia Giuditta, morta il giorno prima a ottant’anni d’infarto , per una poco di buono, “Burbero” iniziò ad inveire. Brandendo minaccioso una vecchia scopa di saggina, si lanciò all’inseguimento dei malcapitati che, inforcate al volo le biciclette, pedalarono via come due indemoniati. Giunti al paese, trafelati e stanchi, si presentarono ansimando all’osteria dell’Uva Pigiata. Paolino Pianelli, a conoscenza della loro avventura, vedendoli in quello stato, fece l’occhiolino sussurrando: “L’avete vista, eh?”. Pacifico, con un filo di fiato e una buona dose d’ironia, rispose che sì, l’avevano vista. Ma che già al primo sguardo, avevano capito subito che non faceva per loro e se n’erano andati via.
Marco Travaglini