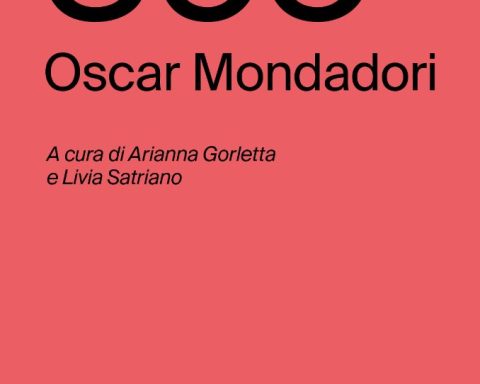“La forma delle cose” al Gobetti sino a domenica 19 gennaio
Come un piccolo granello di sabbia che viene a frapporsi tra gli ingranaggi della vita è questa Evelyn Thompson, un accadimento dirompente nelle esistenze altrui: che scalza, che scoordina, che sconvolge. La ragazza viene sorpresa da Adam, un ragazzo che per arrotondare le entrate utili a proseguire gli studi universitari s’è trovato un’occupazione in qualità di sorvegliante in una delle sale di un ricco museo della California d’inizio millennio, mentre supera un cordone di divisione con la sua bella bomboletta spray in mano. Un atto di piccola smania rivoluzionaria a infrangere le convenzioni sociali ma anche a superare quella al momento – o sempre – insormontabile frontiera che esiste tra vita reale e area artistica, tra quelle norme credute imposizioni e una pretesa libertà d’espressione. E poi, un vistoso pene da colorare sulla statua che le sta di fronte: ovvero, abbasso la censura. Neil LaBute, ormai sessantenne, discusso quanto talentuoso drammaturgo americano ma anche sceneggiatore e regista abituato a portare sullo schermo con riconosciuti successi opere dapprima pensate per il palcoscenico (“Nella società degli uomini” è stato il primo esempio una trentina d’anni fa), accompagna nella “Forma delle cose”, scritto nel 2001, il suo deflagrante personaggio – una donna, a esprimere l’incisività di una parte del genere umano – ad affrontare nelle scene successive il cambiamento del povero Adam, il cesellamento dello spirito e del corpo. Venti e più anni prima che i social di oggi spingessero nel quotidiano e nell’immediato al mutamento anche funesto di certe esistenze.

Perché Adam, nella mente di Evelyn, Pigmalione atroce dei nostri decenni, va cambiato. Sapremo alla fine perché. Rivoltato come un calzino da un deus ex machina contemporaneo, guardato nella sua forza e nella sua fragilità, nell’aspetto fisico e nei comportamenti, nelle azioni di tutti i giorni, nei contatti sociali sino a quel momento sicuri. Il taglio di capelli, il modo di vestire, i chili che sono di troppo, anche quel viso all’improvviso inaccettabile dove dovrà essere fatto un intervento di rinoplastica, tutto è là da modificare, come un artista farebbe con l’opera che le sta tra le mani. Un blocco di marmo in cui già individuare una nuova sembianza. Vedendoci già con un piccolo quanto simbolico scalpello in mano un accattivante “restyling metodico”. Anche gli amici che circondano Adam, il loro mondo di abitudini e sicurezze, dovrà essere affrontato e mutato, si dovrà lavorare all’interno (come faceva decenni fa il visitatore del “Teorema” pasoliniano dentro la famiglia del grande industriale), creare delle fessure e degli squarci difficilmente risanabili. Tutti a convivere e a sbranarsi in quella scatola di specchi realissimi e deformanti al tempo stesso, che osservano e dentro cui è facile controllare, a riflettere immagini di noi insicure, bugiarde, ingannevoli. È lento il cammino che LaBute percorre in questa sua parabola dell’oggi, è più che convincente la costruzione che avviene attraverso i dialoghi, fatti di stringatezza e di finte dolcezze e di ferocia – mentre si cerca di mantenere le apparenze con educati brindisi, quasi si fosse dalle parti di quelli verdiani. Nella scrittura s’abbandonano poco a poco i riferimenti artistici, l’autore li lascia più sul fondo, per far esplodere quelli comportamentali (“trasferire le proprie idee o sentimenti nelle menti altrui: questo è potere”, è stato scritto), per studiare appieno i caratteri, i gesti e le ribellioni e i soprusi di quanti occupano la scena: e la sua è una scrittura che lascia davvero il segno.
“La forma delle cose” è sino a domenica 19 gennaio sul palcoscenico del Gobetti per la stagione dello Stabile torinese, affidata nella sua realizzazione (e con la traduzione di Masolino D’Amico) alla giovane Marta Cortellazzo Wiel, attrice cresciuta nel vivaio della Scuola dello Stabile e già trasmigrata in altre preziose produzioni (l’abbiamo vista e apprezzata di recente nella “Locandiera” di Latella): che oggi torna a casa e vince questa sua scommessa di regista. Strapazza come più non potrebbe i dialoghi di LaBute, ne mantiene la frammentazione, li insegue e immediatamente li rimanda attraverso le voci dei suoi attori, metallici e fendenti, sanguinosi su quel ring, lavora con giusti sguardi sullo sfaldamento di Adam, di Jenny (Celeste Gugliandolo) e di Philip (Christian Di Filippo), mantiene ogni momento con mano ben ferma, senza compiacimenti, senza sbavature, senza fastidiose ripetizioni. Insomma, ha ben visto chi ha deciso di credere in lei. Come lei allieva della stessa Scuola di recitazione, Beatrice Vecchione è Evelyn, perfetta nel dare nuova forma alle proprie vittime, ancor più di lei convincente l’Adam di Marcello Spinetta, sicurezza e annientamento, su quel cammino di distruzione in cui lo pone lo sfrontato disegno altrui.
Elio Rabbione
Le immagini dello spettacolo sono di Luigi De Palma.
Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE