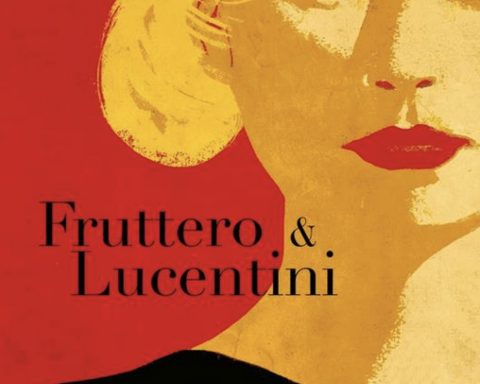Una delle pellicole più note, di successo e discusse di questa prima parte di stagione cinematografica autunnale, è, sicuramente, Joker, diretto da Todd Philips, interpretato da Joaquin Phoenix e con attori del calibro di Robert De Niro nel cast.
Il film, vincitore del Leone d’oro alla Mostra del Cinema di Venezia, parte dal pretesto di raccontare le origini dell’avversario per eccellenza di Batman, impresa giàtentata in passato da altri lungometraggi, discostandosi da qualunque corrispondenza con ottant’anni di fumetti incentrati sul personaggio, per esplorare un ampio spettro di tematiche che conferiscono al film dignità di opera a se stante e sicuramente con finalità di lavoro d’autore e impegnato.
Certamente la prima qualifica che scaturisce alle labbra, dopo averne concluso la visione, due ore di tensione mai sciolta e sempre in crescendo, è di disturbante, una vicenda tormentata, violenta, disperata e disperante, senza alcuna luce che possa accendersi né nel corso della narrazione né al suo fondo dove, invece, l’oscurità sorge e lascia ad intendere tutto ciò che seguirà e che i fan di Batman – cui non mi ascrivo, anzi, sono totalmente ignorante nell’ambito dei supereroi – conoscono.
Devo fare una premessa: non sono un grande cinefilo e, al termine della visione, mi sono apparsi chiari i due motivi per cui tendo a preferire la narrazione su carta rispetto a quella del grande schermo.
Il primo di essi è il più rilassante rapporto che si può avere con la parola scritta, capace di coinvolgere ma mantenere un sufficiente distacco che, al contrario, l’immagine supera, acquisendo un’intrinseca forza, ma anche invadenza e violenza, in quanto sempre gettata in faccia allo spettatore, colpendolo ad un livello emozionale che si rivela sicuramente più conturbante; il secondo è rappresentato dalla maggior libertà esplorativa e riflessiva che la scrittura possiede rispetto alla narrazione visuale, contingentata spazialmente e temporalmente, costretta a ricorrere molto di più al sottinteso o alla suggestione di una rapida inquadratura, in un certo senso più vicina alla poesia che alla prosa.

Se il primo termine di questo confronto è qualcosa di soggettivo che dipende dalla capacità “digestiva” di ciascuno, dunque insignificante per qualunque critica costruttiva, sul secondo punto si vogliono invece fondare le osservazioni e le riflessioni svolte nel presente articolo.
Partiamo dall’interpretazione “politica”: Joker come film di “denuncia”, attributo che si potrebbe dare al film appena letta la trama o viste le prime scene, cosiccome a partire dall’intero ambiente relazionale e sociale che la Gotham City grigia, piovosa, degradata e spaventosamente diseguale descrive.
Questo primo aspetto, per quanto possa apparire controintuitivo, è quello che rimane meno articolato e meno chiarito nel film; forse ciò cui la sceneggiatura punta è proprio il caos, facendo chiari riferimenti alla contemporaneità, senza però necessariamente avere una tesi da dimostrare, bensì mostrare una condizione di tumulto crescente, di confusione sempre più imperante.
Il film narra, di fatto, l’esplosione di una serie di bombe ad orologeria che emergono sia dal singolo, la frustrazione crescente di Arthur Fleck, il futuro Jocker, abbandonato a se stesso e alla malattia mentale, privato dall’amministrazione del supporto clinico e psicologico, del lavoro e del rispetto che merita come essere umano in lotta per un’esistenza difficile, gravata dalla madre da curare, sia dalla collettività, che interseca in più punti l’evoluzione, in realtà sempre in solitaria, del protagonista, lo erge a simbolo, senza che a lui questo possa minimamente interessare – al più, da criminale e malvagio come diverrà, potrà cinicamente approfittarne o sfruttarlo per solleticare il proprio ego – risolta nella rivolta finale, un sabba di fuoco, violenza, sangue, e nell’assassinio dei genitori di Bruce Wayne, un giorno, molti anni più avanti, Batman, paradossalmente unico gesto non compiuto da Jocker — che pure durante il film contro la famiglia Wayne catalizza e sviluppa motivi veri e presunti di rancore – bensì da un personaggio anonimo, ladro e al più associabile alla categoria del mitomane, del solitario autore del gesto eclatante, colui che colpisce il simbolo in un modo più simile all’assassinio di John Lennon che al delitto politico contro il nemico di classe o di ideologia.
Non è chiaro se il film abbia una finalità di analisi socio-politica con una tesi precisa e, se questa voleva essere inserita, è trattata con una certa fretta, e in questo senso l’opera cinematografica perde rispetto agli spazi riflessivi che la narrazione scritta avrebbe potuto avere, ed è ulteriormente limitata anche nello svolgere ciò che pure potrebbe compiere con efficacia.
In particolare, Joker non fornisce una risposta néche questa sia, detto molto grossolanamente, “a sinistra”, “marxisticamente” in quanto, pur ponendo alcuni problemi, manifestando la difficoltà e la disparità etica, morale, sociale, politica (la sospensione del supporto psicologico e farmacologico, l’abbandono dei derelitti, la violenza gratuita e la sopraffazione, il fatto che “sono io o gli altri sono tutti pazzi?” cioè la perdita da parte degli esseri umani di qualunque forma di empatia, disponibilità, quei valori qualificati spicciamente da certuni con lo sprezzante “buonismo”) non li sviluppa, li scioglie in una rivolta disorganizzata e violenta che diventa una regressione alla devastazione ed alla legge della giungla, una protesta che non ha argomento né richieste, ma soltanto l’attacco all’élite, vera o presunta; non è sicuramente una rivoluzione come quella francese o quella bolscevica, quella di cui siamo spettatori, ma neppure una sollevazione connotata come quella venezuelana, di Hong Kong, o quella cilena di questi giorni; ricorda, tutt’al più, la degenerazione che il movimento dei gilet gialli ha avuto, settimana dopo settimana, da protesta della Francia provinciale e rurale contro i rincari del carburante a vandalismo generalizzato e rivolta viscerale contro il governo Macron, o il movimento dei forconi che qualche anno fa aveva paralizzato per un paio di giorni l’Italia intera.
Ma, d’altra parte, è evidente che il film non è neppure reazionario, non sposa le tesi che potremmo considerare “conservatrici”, quelle racchiuse nell’argomento dell’invidia che le persone, incapaci di adattarsi al nostro modello di società, provano verso chi ce l’ha fatta ambendo piuttosto al parassitismo dello stato sociale; il film non propone una risposta “ a destra” alla condizione di Gotham City, perché gli uomini d’ordine sono chiaramente descritti come negativi e antipatici, a partire da Thomas Wayne, élite facile al giudizio, al paternalismo e del tutto priva di empatia, prepotente e spietata, come i tre ragazzotti uccisi dal protagonista in una circostanza che specialmente la mentalità americana potrebbe configurare come ai limiti della legittima difesa e che a noi ricordano le vicende del delitto del Circeo.
Le uniche forze dell’ordine neutre o, in questa situazione così esasperata, poco più che buonuomini impotenti, desiderosi di fare il proprio lavoro, ma di fatto privi di mezzi, sono i due poliziotti che indagano sui misfatti e arrivano ad Arthur Fleck, invano, finendo nel più classico degli equivoci del poliziotto che spara all’innocente, anch’esso però liquidato con una facilità che non rende giustizia alle note questioni poste dalla facilità della polizia americana al ricorso alle armi, e ancor più insoddisfacenti per il pubblico italiano che da quarant’anni almeno, senza mai venir meno all’attualità, è abituato a vicende di cronaca relative ad abusi accertati o sospettati delle forze dell’ordine.
Jocker, da questo punto di vista, è un progetto incompleto, forzato anche dalla necessità di costruire un supercattivo, ma non può ambire agli scopi del cinema neorealista italiano – si pensi a quale esito potrebbe avere lo sviluppo del tema del malato privato, diciamolo brevemente e seccamente, delle cure passate dalla mutua, una tragedia a suo modo vicinissima alla condizione del protagonista di “Ladri di biciclette”, film che tutt’oggi potrebbe essere riproposto a partire dalla vicenda, ad esempio di un rider privato di un mezzo che, assieme al cellulare, entrambi spesso di proprietà, è veramente la chiave del proprio sostentamento – , o agli sforzi letterari di autori come Hugo nei Miserabili, dove di nuovo tutto ruota attorno al criminale, o di tanti romanzi dostoevskiani.
Dostoevskij può consentirci, forse, di trovare una chiave di lettura per Joker, ma certamente non andandolo a confrontare con l’assassino per eccellenza della sua produzione, il Raskol’nikov di Delitto e Castigo: Joker, invece, rappresenta uno degli archetipi di quei personaggi dalle vocazioni superomistiche, amorali e, in definitiva, criminose, prive di qualunque valore, tantomeno quello della vita umana, che popolano i Demoni.
Questa interpretazione di Joker può essere avvicinata al glaciale, spaventoso ed affascinante Stavrogin, la condensazione di tutti i terrori dostoevskiani spogliata da qualunque vocazione politica o filosofica, i Demoni non sono certamente né i filosofi atei con una personale statura morale (Ivan Karamazov, Svidrigailov), né i giovani portati all’anarchia o al socialismo da ideali progressisti rigettati dall’ultimo Dostoevskij, imbevuto ormai del mito conservatore e assieme esistenzialistico della Santa Madre Russia. Joker potrebbe figurare in mezzo a quei “nichilisti”, termine cui sono adusi i lettori dei grandi romanzi russi dell’Ottocento; ha una dimensione superomistica e negatrice che, però, distorce, primo di una lunga serie di travisatori, l’ideale nietzschiano che, invece, pone sempre in grande valore l’uomo, ha un suo sentimento e umanità e, certamente, non può concepire il matricidio (e in questo non c’è nulla di freudiano, né nel rapporto con la madre né con il presunto padre Wayne) di cui Arthur Fleck si macchia.
Tutto ciò, però, vuol dire postulare, dal punto di vista dell’analisi politica e sociale, una totale assenza di risposte che non sia appunto il caos e un individualismo sfrenato in cui, però, uno non vale né uno né mille, ma poco più che nulla, l’esistenza umana si può spegnere a piacimento con le armi, i morti non si contano più.

È dunque un nichilismo che non ha nulla a che fare neppure con lo Zarathustra che, al contrario, crea dietro di sé un’accolita di reietti e di individui grotteschi e deformi, ma proprio per questo ancor più unici e connotati (non diversi dagli scherzi di natura che tirano a campare nell’azienda di intrattenimento dove Fleck lavora), così come di fatto Jocker non è neppure populista, nel senso che, pur eretto a simbolo, non cavalca di fatto la rivolta, si limita a goderne, ma non se ne fa capo, pur potendone in teoria trarre grande vantaggio.
Il riferimento al comico che fonda un movimento politico, a orecchie italiane, e non solo, particolarmente evidente, non è, comunque, così calzante nel nostro caso; Joker non ha nulla del leader carismatico di una rivolta, non è né un Hitler che magnetizza le folle nelle osterie bavaresi né un Danton, è più un capo ultrà, paradossalmente ha più del Renzo che diventa improvvisamente simbolo della rivolta del pane che del capopopolo: la sua danza sulla volante della polizia accartocciata rappresenta i suoi quindici minuti di celebrità del mito televisivo.
L’interpretazione potrebbe, allora, essere portata sull’aspetto prerazionale, persino premorale, della compassione, della comprensione verso questo personaggio, un uomo costretto ad essere un fallito pur avendo qualche possibilità, che si sforza di essere figlio affettuoso, che affronta a capo chino interminabili rampe di scale: sicuramente, ma ad un certo punto anche questo viene meno, perché la condotta del protagonista diventa sempre più abnorme ed ingiustificabile, sproporzionata ed incline al lato oscuro, e più cresce la sua crudeltà, più noi non possiamo che staccarcene, dichiararci incapaci di giustificare ciò che all’inizio potremmo aver anche tollerato, tutto si discioglie anche qui nel caos e nella semplice manifestazione di una malattia mentale che diventa pericolosa ed inarrestabile.
Quando Fleck non prende più i farmaci, non libera una persona che era tenuta sedata e repressa, e che pure finché era in cura lasciava intuire ciò che di positivo (non si può proprio, in questo film, parlare di buono) poteva nutrire dentro di sé, lascia scatenare semplicemente la follia, tutto si scioglie nell’assurdo, nel paradossale, anzi, per trarre un vocabolo dalla terminologia clinica, molto appropriato in questo contesto, paradosso.
Pertanto, se è vero che il film ambisce ad essere, ed effettivamente lo è, una grande parabola, se non addirittura un ammonimento, sul tema della compassione, della simpatia intesa etimologicamente come capacità di soffrire con l’altro, di comprendere le sue difficoltà e sofferenze, sostare per cercare di condividerne o alleviarne la strada, per quanto il mondo descritto sia un universo di persone e relazioni che domandano o che avrebbero bisogno di pietà ed invece ricevono solo insulti, percosse od insofferenze, il climax finale rende sempre più impossibile da giustificare, e soprattutto investe di un miscuglio fatto di male e follia, il moto di comprensione che pure, sin dall’inizio della narrazione, lo spettatore prova nei confronti del personaggio; ancora una volta, il richiamo è ai tanti fatti di cronaca, anche recenti, quelli che più dividono l’opinione pubblica solitamente tra chi condanna a testa bassa e chi invece, pur cercando di osservare prospetticamente la questione, si trova in tutta a coscienza a dover formulare un giudizio che tenga in giusto conto fattori come le colpe della società, del clima di sempre crescente intolleranza, di estremizzazione, di vicende umane dolorose che, accumulandosi, hanno però avuto come valvola di sfogo gesti in cui da vittima si passa a carnefici, dove è evidente la natura criminale e necessariamente sbagliata dell’azione compiuta.
Se però gli aspetti sociali, politici e morali risultano sviluppati o difficoltosamente o con una tesi che preclude qualunque forma di speranza, dove il film veramente la vince è sul tema del riso.
Il tema del pagliaccio triste, che diventa addirittura diabolico, ribaltando quindi quello che dovrebbe essere il suo ruolo, è un topos che va indietro almeno fino all’opera di Ruggero Leoncavallo, la lacerazione tra la parte che si deve recitare e il tormento che si vive conosce infinite declinazioni: l’interpretazione, estremamente contemporanea, che il film dà del tema risiede nel fatto che tutti ridono, ma nessuno sorride.
Meglio ancora, non c’è neppure riso nel film, c’è solo risata, c’è soltanto il vocalizzo, il verso, non dissimile dalla fonazione animale: non è un riso, ma una risata, lo spasmo di Arthur Fleck, inopportuno, patologico, sardonico e tormentato, causato dalla sua malattia, che passa pian piano da gesto incompreso, quint’essenza della sua solitudine, causa di stigma sociale non dissimile dalla pirandelliana esclamazione di condanna “Tu ridi!” alla base della celebre novella che molto ha in comune con i temi trattati dalla pellicola, a simbolo del riso malvagio e agghiacciante del nuovo criminale nemico pubblico numero uno.
Ma sono altrettanto poco più che vocalizzi, spesso guidati da una luce in studio espressione delle direttive di regia, le risate dei tanti spettatori dello show serale condotto da Murray Franklin, unica e totalizzante distrazione nella difficile vita degli abitanti di Gotham, che si riduce però a gesto vuoto, grossolano, insignificante; allo stesso modo è vuoto il divertimento dei maggiorenti di fronte alla maschera sempre triste, e solo superficialmente comica, di Charlie Chaplin in Tempi moderni.
Non c’è vera gioia, se è il conduttore a decidere che cosa faccia ridere e che cosa no, tutto si inquadra in determinazioni semplicistiche: niente humour nero, niente sesso (se non grossolanamente inteso), niente volgarità (a meno che non sia facile e già precotta) ma neanche niente approfondimento, riflessione, satira od umorismo.
E Arthur Fleck, nel suo desiderio di diventare un comico, cerca di conformarsi a tale società, bussa disperatamente perché gli si aprano le porte del mondo dei cabaret, dei piano bar, persino della televisione, ma in modo assolutamente conformista: oltre a non far ridere come comico, perché evidentemente non solo incapace e, comprensibilmente, privo della disposizione d’animo per essere gaio e spensierato, se anche riuscisse nel suo intento, giungerebbe semplicemente all’omologazione, perché la sua comicità è la stessa comicità greve ed approssimativa, conformistica, di tutti gli altri che nel mondo dello spettacolo vivono.
Il punto di rottura, preludio all’assassinio in diretta del conduttore, gesto eclatante e mediatico per eccellenza, si verifica quando Arthur comprende, in un rigurgito di malata dignità, e noi con lui, che tale comicità oltre ad essere vuota e superficiale, distrattrice, è anche spietata, perché è politicamente corretta soltanto verso la gran parte del pubblico, “i normali”, mentre non si fa scrupoli di mettere alla berlina chi a questa normalità non si adegua o non può appartenere: la televisione che si fa trash, un trash “per famiglie”, ancora diverso dalla spettacolarizzazione della rissa, dell’insulto o del dolore, più vicino alla “Corrida” che ai programmi della D’Urso.
Tale riso diventa la quintessenza dell’inautenticità, per parlare il linguaggio caro agli esistenzialisti, in cui l’individualità si discioglie nel “Si”, per posticipare ed ignorare i veri problemi, nel dimenticare la complessità per riposare in una distraente e confortante superficialità.
Si tratta, in sostanza, dello stesso riso sul quale si fonda la gran parte della comunicazione e della produzione che circola in rete: tutto deve essere divertente, tutto deve essere facile, tutto deve essere gioco; è il caso dei tanti video, divertenti o presunti tali, che infestano i nostri social media, quelli con cui, si vede sovente sui mezzi pubblici, per strada, sulle panchine, i genitori inondano i bambini proprio con lo scopo di distrarli, ai quali tanti adulti anche ritornano, di fatto con una regressione infantile, senza comprendere le potenzialità che la rete ci mette a disposizione, ignorando lo sforzo dei tanti produttori di contenuti ricchi di qualità e sfaccettature che fanno leva sulla facilità di accesso dei nuovi mezzi di comunicazione.
È il riso del fenomeno da baraccone, da scemo del villaggio, ma è anche il riso di tanti meme, le immagini umoristiche il cui nome riprende un concetto elaborato negli anni ‘80 dal biologo Richard Dawkins per indicare un elemento culturale e sociale che si riproduce oltre ogni aspettativa e comincia a vivere di vita propria, come se fosse un gene mutante e talvolta impazzito.
Se si parla di riso, inevitabilmente, non possiamo che tornare ad Umberto Eco, agli strali che Jorge da Burgos getta sul gesto che storce il volto dell’uomo e lo rende simile alla scimmia, alla sua lotta disperata e censoria per nascondere e infine distruggere le parti della Poetica di Aristotele dedicate alla comicità – e, sia detto per inciso, la commedia greca, pur permettendo allo Stagirita la riflessione teorica nel suo dualismo con la tragedia, non è certo un punto particolarmente elevato di humour e acutezza, al contrario condivide molto della volgarità e del conformismo, in fondo conservatore, dell’avanspettacolo –, alimentando l’atmosfera di repressione sociale, intellettuale, sessuale, che campeggia sull’abbazia scardinata dall’intelligenza, dallo spirito critico ed illuminato, e da una buona dose di humour squisitamente inglese, rappresentati da Guglielmo da Baskerville.
Il riso che Jorge vuole reprimere e che, invece, Umberto Eco difende è il riso ironico, distruttore di qualunque verità precostituita, l’ironia maieutica di Socrate (e dello stesso Eco, il cui humour è forse il più gradevole aspetto della sua scrittura) o la risata destinata a seppellire, motto dell’anarchia sin dalla fine dell’Ottocento, la distruzione dei parafernali inutili, che sovraccaricano di forma l’assenza di contenuto o la sua natura retriva.
Se Il nome della rosa difende il riso, Joker lo distrugge: da che parte si può stare allora?
Dalla parte che comprende che gli argomenti svolti dalle due opere non sono antitetici, ma complementari: Eco tanto difende la forza del ridere e la sua valenza positiva nel suo primo romanzo quanto si spende a lungo ad analizzare e criticare i meccanismi del trash e della comicità facilona televisiva, le gaffe di Mike Bongiorno, le produzioni televisive dai paradigmi conformisti e democristiani della Rai anni ‘60 fino a quelli volgari, ma dirompenti, della Mediaset anni ‘80.

Per mostrare quanto bene questi argomenti si concilino, basta considerare che il tempo in cui vive Joker sono proprio i primi anni ‘80, i mezzi di comunicazione a disposizione sono soltanto i giornali e la televisione onnipresente e imperante, che occupa tutti gli spazi ora erosi e contesi dagli altri social media, con linguaggi diversi – limitazione cronologica che in un certo senso è un’altra debolezza del film, che perde in parte di vista le dinamiche più contemporanee di aggregazione delle persone e diffusione del malcontento, necessariamente mediate dai social network – ; non c’è contrasto, c’è sfaccettatura, una sfaccettatura che, riproiettata sulla nostra contemporaneità, si traduce nella viralità dei video di scherno, sopraffazione, umiliazione o inconsapevole autoumiliazione.
Tuttavia, se la presa in giro, lo scemo del villaggio e la berlina sono dinamiche purtroppo sempre esistite, spesso tanto più forti quanto più la comunità è provinciale e chiusa – e certamente la provincializzazione del villaggio globale, dunque dell’intero mondo, è un rischio concreto –, più squisitamente tipico della nostra epoca è proprio la riduzione di ogni cosa al riso e alla dimensione ludica, per cui tutto è facile, tutto è assimilabile al divertissement pascaliano, ai giochi da cellulare con i quali riempire i tempi morti senza un vero coinvolgimento spirituale o intellettuale, alla produzione invasiva e priva di originalità del meme che schiaccia in una non-prospettiva primitiva e semplifica ogni cosa, non soltanto dissacrante, ma di fatto privo della comprensione e della forza interpretativa che ogni prodotto con un significato dovrebbe possedere, al politico che imita l’imitatore, che svuota di contenuti la sua attività comprendendo che, per rendersi riconoscibile, deve passare dalla semplificazione del linguaggio e, possibilmente, dal gesto che lo renda immediatamente individuabile, e che cosa c’è di più facile che accentuare i propri tic, i propri comportamenti paradossali, le proprie incoerenze, sbeffeggiate dall’imitatore, che fa satira, e indossate dal personaggio reale come una parte da recitare continuamente, alla quale si finisce forse per credere, sapendo che ricade a proprio vantaggio.
Joker avvolge, ammorba, strazia nel cinismo, è cinica persino la colonna sonora, la voce di Frank Sinatra che canta il sogno americano e conclude con un That’s life crudelissimo ma perfettamente adattato al genere di follia incarnato dal protagonista, persino la grafica utilizzata, più simile ad una commedia musicale che ad un film di supereroi e tantomeno ad un thriller psicologico, segna il contrasto: il mondo di Joker è pieno di rumore, di grida e di risa, spari e degrado, sferraglio di vagoni e vociare di folle, ma manca di sorriso, questo sì gesto empatico e cordiale, tranne forse il mezzo sorriso stiracchiato alla base dell’infatuazione del protagonista per la vicina, che non è né una semplice fantasia sessuale né un’opportunità di redenzione, ma un miscuglio, anch’esso, di volontà di potenza e bisogno, presto anch’esso dissolto in pulsioni di morte, di umanità.
Non è certo il caso di stabilire se il film sia destinato ad entrare nell’olimpo dei grandi film, ha le sue forze e le sue debolezze, ma certamente è contemporaneo, è adatto al momento in cui viviamo e come tale, inevitabilmente, fa parlare di sé, suscita discussioni ed interroga; persino, in conclusione, interroga sul motivo per il quale siamo andati a vederlo: passione per il personaggio fumettistico, interesse per la vicenda narrata, semplice desiderio di spettacolo, andiamo a vederlo e poi ci riflettiamo su o è solo un altro film con celebri attori e soprattutto il nuovo inizio di una saga supereroistica?
La risposta che ognuno dà è a sua volta parte dell’interpretazione di questo film, in quanto ci schiera nel mosaico di atteggiamenti che ciascuno ha nei confronti del confine tra realtà, spettacolo e finzione, serietà e intrattenimento, che caratterizza il nostro mondo.
Andrea Rubiola
Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE