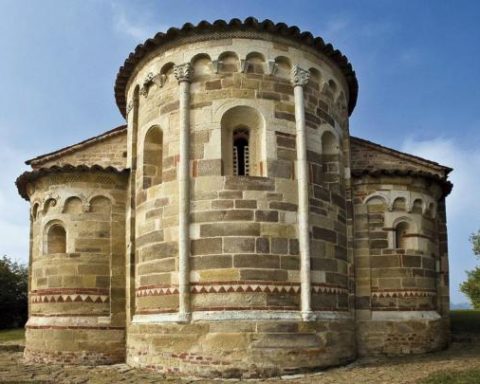Le storie spesso iniziano là dove la Storia finisce.
Non tutte le storie vengono raccontate, anche se così non dovrebbe essere. Ci sono vicende che fanno paura agli autori stessi, che sono talmente brutte da non distinguersi dagli incubi notturni, eppure sono storie che vanno narrate, perché i protagonisti meritano di essere ricordati. I personaggi che popolano queste strane vicende sono “matti”,” matti veri”, c’è chi ha paura della guerra nucleare, chi si crede un Dio elettrico, chi impazzisce dalla troppa tristezza e chi, invece, perde il senno per un improvviso amore. Sono marionette grottesche di cartapesta che recitano in un piccolo teatrino chiuso al mondo, vivono bizzarre avventure rinchiusi nei manicomi che impediscono loro di osservare come la vita intanto vada avanti, lasciandoli spaventosamente indietro. I matti sono le nostre paure terrene, i nostri peccati capitali, i nostri peggiori difetti, li incolpiamo delle nostre sciagure e ci rifugiamo nel loro eccessivo gridare a squarciagola, per non sentirci in colpa, per non averli capiti e nemmeno ascoltati. (ac)
***
4. La pazzia è donna
Quando venne internata, Ida aveva quarantatré anni, pesava cento chili e appariva “esaltata, gaia, logorroica”. Il medico scrisse nella diagnosi che la donna soffriva di “psicosi periodica”, (esaltazione maniaca), così Ida venne in seguito trasferita a Collegno, e lì rimase fino a quando morì di cancro il 1 ottobre 1922. Attraverso la lettura della sua cartella clinica sappiamo che la fanciulla aveva smesso di studiare dopo le classi elementari, quando iniziò a recitare. Giovanissima si innamorò follemente di un ragazzo, Emilio, che sposò e con cui ebbe quattro figli. I due erano soliti tirare di scherma insieme, e insieme facevano lunghissime passeggiate sulle rive del Po, fino a quando Emilio divenne alcolista e talvolta violento; lo stato del compagno influì sulla donna, che iniziò a bere a sua volta e ad avere  atteggiamenti pericolosi per sé e per gli altri. La felicità abbandonò i due innamorati attraverso le tristi parole del medico di famiglia che propose il ricovero come unica soluzione. Emilio, che faceva lo scrittore, inviò una lettera all’editore, a cui domandò credito per coprire le spese per assistere la compagna, in cambio gli avrebbe mandato cento cartelle al più presto. Bemporad, l’editore, tre giorni dopo inviò la somma di denaro richiesta, ma la risposta non fu sufficientemente celere: Emilio si tolse la vita il 25 aprile 1911, tagliandosi il ventre con un rasoio sulle colline torinesi, sopraffatto dalla vita che con lui era stata troppo crudele. Emilio Salgari, questo il nome completo dell’infelice, si suicidò sguainando la propria arma affilata così come il Conte di Ventimiglia era solito sfoderare la spada; egli amò fino alla morte la sua sposa, Aida Peruzzi, che lo contraccambiò fino alla pazzia. La storia di Ida è solo una fra le innumerevoli vicende femminili che trovarono la fine tra le vuote stanze dei manicomi. Quello di via Giulio divenne il “Manicomio Femminile di Città”, quando gli uomini furono spostati a Collegno, a metà dell’Ottocento. Non solo, era la minaccia più temuta e ricorrente per le figlie capricciose e svogliate, rimproverate e minacciate al grido di “Finirai in via Giulio!”. Le pazienti erano nascoste agli occhi del mondo da alte mura e altrettanto imponenti pini sempreverdi, vivevano una realtà parallela, immobile come la loro condizione, mentre il mondo vero le sfiorava con i suoni lontani dei clacson, i rombi delle automobili, il rintocco delle campane e il vocio del quartiere. Le donne di via Giulio origliavano la vita che sfuggiva loro, ferme, sotto l’ombra dei grandi pini, sempre uguali, come loro. Le pazienti più tranquille erano occupate come lavandaie o come sarte per piccoli lavori di taglio e cucito che servivano alla produzione di coperte, uniformi, grembiuli, camici, tovaglie, o fodere; quelle più agitate, invece, erano costrette a letto, legate con fettucce e cinghie. Molte
atteggiamenti pericolosi per sé e per gli altri. La felicità abbandonò i due innamorati attraverso le tristi parole del medico di famiglia che propose il ricovero come unica soluzione. Emilio, che faceva lo scrittore, inviò una lettera all’editore, a cui domandò credito per coprire le spese per assistere la compagna, in cambio gli avrebbe mandato cento cartelle al più presto. Bemporad, l’editore, tre giorni dopo inviò la somma di denaro richiesta, ma la risposta non fu sufficientemente celere: Emilio si tolse la vita il 25 aprile 1911, tagliandosi il ventre con un rasoio sulle colline torinesi, sopraffatto dalla vita che con lui era stata troppo crudele. Emilio Salgari, questo il nome completo dell’infelice, si suicidò sguainando la propria arma affilata così come il Conte di Ventimiglia era solito sfoderare la spada; egli amò fino alla morte la sua sposa, Aida Peruzzi, che lo contraccambiò fino alla pazzia. La storia di Ida è solo una fra le innumerevoli vicende femminili che trovarono la fine tra le vuote stanze dei manicomi. Quello di via Giulio divenne il “Manicomio Femminile di Città”, quando gli uomini furono spostati a Collegno, a metà dell’Ottocento. Non solo, era la minaccia più temuta e ricorrente per le figlie capricciose e svogliate, rimproverate e minacciate al grido di “Finirai in via Giulio!”. Le pazienti erano nascoste agli occhi del mondo da alte mura e altrettanto imponenti pini sempreverdi, vivevano una realtà parallela, immobile come la loro condizione, mentre il mondo vero le sfiorava con i suoni lontani dei clacson, i rombi delle automobili, il rintocco delle campane e il vocio del quartiere. Le donne di via Giulio origliavano la vita che sfuggiva loro, ferme, sotto l’ombra dei grandi pini, sempre uguali, come loro. Le pazienti più tranquille erano occupate come lavandaie o come sarte per piccoli lavori di taglio e cucito che servivano alla produzione di coperte, uniformi, grembiuli, camici, tovaglie, o fodere; quelle più agitate, invece, erano costrette a letto, legate con fettucce e cinghie. Molte  indossavano delle camicie di forza, quelle stesse che Edmondo De Amicis aveva visto presso il manicomio di Collegno e che gli erano sembrate delle vesti infantili ed ingenue, ma quando il celebre scrittore chiese all’inserviente che tipo di abiti fossero, la risposta lo raggelò: “è la camicia di forza, in riposo per adesso”. Le donne di via Giulio erano casalinghe, contadine, operaie, prostitute, disoccupate, vedove, domestiche, o venditrici ambulanti, erano povere per la maggior parte, poiché le ragazze di buona famiglia venivano inserite all’interno di cliniche private e in genere seriamente curate dagli stessi medici che poco si adoperavano per le pazienti meno abbienti e più sfortunate. Alcune donne riuscivano a uscire, ma fuori le aspettava una vita ancora più difficile, se possibile: l’onta del manicomio era ancora peggiore rispetto a quella del carcere e spesso chi veniva rilasciato non poteva ricominciare. Nei primi del Novecento molte delle ricoverate in via Giulio trovavano lavoro come sartine. Fino alla Seconda Guerra Mondiale, a Torino si era sviluppata un’intensa attività di sartoria, seconda solo a Parigi. Il bisogno di manodopera aumentava in primavera e in autunno, e le ragazze che venivano stagionalmente reclutate erano le stesse che poi venivano rimandate indietro quando non c’era più bisogno di loro; talvolta accadeva che non venissero più contattate, esse precipitavano così in una profonda depressione, che le conduceva dritte, dritte a cucire nelle stanze di via Giulio.
indossavano delle camicie di forza, quelle stesse che Edmondo De Amicis aveva visto presso il manicomio di Collegno e che gli erano sembrate delle vesti infantili ed ingenue, ma quando il celebre scrittore chiese all’inserviente che tipo di abiti fossero, la risposta lo raggelò: “è la camicia di forza, in riposo per adesso”. Le donne di via Giulio erano casalinghe, contadine, operaie, prostitute, disoccupate, vedove, domestiche, o venditrici ambulanti, erano povere per la maggior parte, poiché le ragazze di buona famiglia venivano inserite all’interno di cliniche private e in genere seriamente curate dagli stessi medici che poco si adoperavano per le pazienti meno abbienti e più sfortunate. Alcune donne riuscivano a uscire, ma fuori le aspettava una vita ancora più difficile, se possibile: l’onta del manicomio era ancora peggiore rispetto a quella del carcere e spesso chi veniva rilasciato non poteva ricominciare. Nei primi del Novecento molte delle ricoverate in via Giulio trovavano lavoro come sartine. Fino alla Seconda Guerra Mondiale, a Torino si era sviluppata un’intensa attività di sartoria, seconda solo a Parigi. Il bisogno di manodopera aumentava in primavera e in autunno, e le ragazze che venivano stagionalmente reclutate erano le stesse che poi venivano rimandate indietro quando non c’era più bisogno di loro; talvolta accadeva che non venissero più contattate, esse precipitavano così in una profonda depressione, che le conduceva dritte, dritte a cucire nelle stanze di via Giulio.
 atteggiamenti pericolosi per sé e per gli altri. La felicità abbandonò i due innamorati attraverso le tristi parole del medico di famiglia che propose il ricovero come unica soluzione. Emilio, che faceva lo scrittore, inviò una lettera all’editore, a cui domandò credito per coprire le spese per assistere la compagna, in cambio gli avrebbe mandato cento cartelle al più presto. Bemporad, l’editore, tre giorni dopo inviò la somma di denaro richiesta, ma la risposta non fu sufficientemente celere: Emilio si tolse la vita il 25 aprile 1911, tagliandosi il ventre con un rasoio sulle colline torinesi, sopraffatto dalla vita che con lui era stata troppo crudele. Emilio Salgari, questo il nome completo dell’infelice, si suicidò sguainando la propria arma affilata così come il Conte di Ventimiglia era solito sfoderare la spada; egli amò fino alla morte la sua sposa, Aida Peruzzi, che lo contraccambiò fino alla pazzia. La storia di Ida è solo una fra le innumerevoli vicende femminili che trovarono la fine tra le vuote stanze dei manicomi. Quello di via Giulio divenne il “Manicomio Femminile di Città”, quando gli uomini furono spostati a Collegno, a metà dell’Ottocento. Non solo, era la minaccia più temuta e ricorrente per le figlie capricciose e svogliate, rimproverate e minacciate al grido di “Finirai in via Giulio!”. Le pazienti erano nascoste agli occhi del mondo da alte mura e altrettanto imponenti pini sempreverdi, vivevano una realtà parallela, immobile come la loro condizione, mentre il mondo vero le sfiorava con i suoni lontani dei clacson, i rombi delle automobili, il rintocco delle campane e il vocio del quartiere. Le donne di via Giulio origliavano la vita che sfuggiva loro, ferme, sotto l’ombra dei grandi pini, sempre uguali, come loro. Le pazienti più tranquille erano occupate come lavandaie o come sarte per piccoli lavori di taglio e cucito che servivano alla produzione di coperte, uniformi, grembiuli, camici, tovaglie, o fodere; quelle più agitate, invece, erano costrette a letto, legate con fettucce e cinghie. Molte
atteggiamenti pericolosi per sé e per gli altri. La felicità abbandonò i due innamorati attraverso le tristi parole del medico di famiglia che propose il ricovero come unica soluzione. Emilio, che faceva lo scrittore, inviò una lettera all’editore, a cui domandò credito per coprire le spese per assistere la compagna, in cambio gli avrebbe mandato cento cartelle al più presto. Bemporad, l’editore, tre giorni dopo inviò la somma di denaro richiesta, ma la risposta non fu sufficientemente celere: Emilio si tolse la vita il 25 aprile 1911, tagliandosi il ventre con un rasoio sulle colline torinesi, sopraffatto dalla vita che con lui era stata troppo crudele. Emilio Salgari, questo il nome completo dell’infelice, si suicidò sguainando la propria arma affilata così come il Conte di Ventimiglia era solito sfoderare la spada; egli amò fino alla morte la sua sposa, Aida Peruzzi, che lo contraccambiò fino alla pazzia. La storia di Ida è solo una fra le innumerevoli vicende femminili che trovarono la fine tra le vuote stanze dei manicomi. Quello di via Giulio divenne il “Manicomio Femminile di Città”, quando gli uomini furono spostati a Collegno, a metà dell’Ottocento. Non solo, era la minaccia più temuta e ricorrente per le figlie capricciose e svogliate, rimproverate e minacciate al grido di “Finirai in via Giulio!”. Le pazienti erano nascoste agli occhi del mondo da alte mura e altrettanto imponenti pini sempreverdi, vivevano una realtà parallela, immobile come la loro condizione, mentre il mondo vero le sfiorava con i suoni lontani dei clacson, i rombi delle automobili, il rintocco delle campane e il vocio del quartiere. Le donne di via Giulio origliavano la vita che sfuggiva loro, ferme, sotto l’ombra dei grandi pini, sempre uguali, come loro. Le pazienti più tranquille erano occupate come lavandaie o come sarte per piccoli lavori di taglio e cucito che servivano alla produzione di coperte, uniformi, grembiuli, camici, tovaglie, o fodere; quelle più agitate, invece, erano costrette a letto, legate con fettucce e cinghie. Molte  indossavano delle camicie di forza, quelle stesse che Edmondo De Amicis aveva visto presso il manicomio di Collegno e che gli erano sembrate delle vesti infantili ed ingenue, ma quando il celebre scrittore chiese all’inserviente che tipo di abiti fossero, la risposta lo raggelò: “è la camicia di forza, in riposo per adesso”. Le donne di via Giulio erano casalinghe, contadine, operaie, prostitute, disoccupate, vedove, domestiche, o venditrici ambulanti, erano povere per la maggior parte, poiché le ragazze di buona famiglia venivano inserite all’interno di cliniche private e in genere seriamente curate dagli stessi medici che poco si adoperavano per le pazienti meno abbienti e più sfortunate. Alcune donne riuscivano a uscire, ma fuori le aspettava una vita ancora più difficile, se possibile: l’onta del manicomio era ancora peggiore rispetto a quella del carcere e spesso chi veniva rilasciato non poteva ricominciare. Nei primi del Novecento molte delle ricoverate in via Giulio trovavano lavoro come sartine. Fino alla Seconda Guerra Mondiale, a Torino si era sviluppata un’intensa attività di sartoria, seconda solo a Parigi. Il bisogno di manodopera aumentava in primavera e in autunno, e le ragazze che venivano stagionalmente reclutate erano le stesse che poi venivano rimandate indietro quando non c’era più bisogno di loro; talvolta accadeva che non venissero più contattate, esse precipitavano così in una profonda depressione, che le conduceva dritte, dritte a cucire nelle stanze di via Giulio.
indossavano delle camicie di forza, quelle stesse che Edmondo De Amicis aveva visto presso il manicomio di Collegno e che gli erano sembrate delle vesti infantili ed ingenue, ma quando il celebre scrittore chiese all’inserviente che tipo di abiti fossero, la risposta lo raggelò: “è la camicia di forza, in riposo per adesso”. Le donne di via Giulio erano casalinghe, contadine, operaie, prostitute, disoccupate, vedove, domestiche, o venditrici ambulanti, erano povere per la maggior parte, poiché le ragazze di buona famiglia venivano inserite all’interno di cliniche private e in genere seriamente curate dagli stessi medici che poco si adoperavano per le pazienti meno abbienti e più sfortunate. Alcune donne riuscivano a uscire, ma fuori le aspettava una vita ancora più difficile, se possibile: l’onta del manicomio era ancora peggiore rispetto a quella del carcere e spesso chi veniva rilasciato non poteva ricominciare. Nei primi del Novecento molte delle ricoverate in via Giulio trovavano lavoro come sartine. Fino alla Seconda Guerra Mondiale, a Torino si era sviluppata un’intensa attività di sartoria, seconda solo a Parigi. Il bisogno di manodopera aumentava in primavera e in autunno, e le ragazze che venivano stagionalmente reclutate erano le stesse che poi venivano rimandate indietro quando non c’era più bisogno di loro; talvolta accadeva che non venissero più contattate, esse precipitavano così in una profonda depressione, che le conduceva dritte, dritte a cucire nelle stanze di via Giulio.Le donne degenti erano giovani, vecchie, inquiete, taciturne, c’era chi rideva sempre e chi era incline alle lacrime, ma tutte insieme erano state in grado di dare vita ad una sorta di comunità composita, con un ordine preciso e delle regole da rispettare. La vita all’interno delle mura scorreva lenta, scandita dalla ripetizione degli stessi gesti, iniziava con la sveglia alle sette, continuava con il pranzo alle undici e trenta e finiva temporaneamente con la cena alle sei e trenta, per poi riprendere identica il giorno successivo. Tra le forzate ospiti c’era Margherita, sarta e contadina, entrata in manicomio all’età di vent’anni, poiché aveva iniziato a sostenere che tutta la famiglia le faceva dei dispetti; Rosa, a ventidue anni era stata ingannata da una mezzana e poi ingravidata da un farmacista, venne internata mentre stava cercando di abortire in ogni modo; Teresa, si era sposata con un uomo che amava fare baldoria, perse la ragione quando iniziò a ribellarsi al consorte; c’era anche la figlia di uno scialacquatore e di un’isterica, che si sposò a diciassette anni, partorì due volte ed ebbe un aborto, nessuno sa perché iniziò a stare male e la ricoverarono in manicomio. Queste erano le degenti di via Giulio, malate più di sfortuna e solitudine, che di qualche malattia specifica. Ancorate a quella struttura che perlomeno permetteva loro un briciolo di compagnia, c’è chi dice che in realtà non riescano tutt’oggi ad andarsene. Il manicomio di via Giulio chiuse nel 1973, venne utilizzato nel 1979 dal Movimento delle Donne di Torino come luogo in cui riunirsi, a partire dagli anni ’80 diventò sede dell’Anagrafe centrale di Torino. Ed è qui che la storia si fa davvero spettrale, infatti alcuni impiegati raccontano di strane presenze, porte che si chiudono da sole, un senso diffuso di inquietudine e auree di freddo che aleggiano a caso per i corridoi. Venne chiamato a verificare la situazione Gianni Cerruti, il quale, con alcuni dipendenti e appositi strumenti per rilevare onde elettromagnetiche, ispezionò la struttura con attenzione, i risultati che ottenne confermarono le testimonianze dei dipendenti: le anime buone e innocue delle pazienti erano ancora lì. Immobili e immutate, come i pini sempreverdi.
alle undici e trenta e finiva temporaneamente con la cena alle sei e trenta, per poi riprendere identica il giorno successivo. Tra le forzate ospiti c’era Margherita, sarta e contadina, entrata in manicomio all’età di vent’anni, poiché aveva iniziato a sostenere che tutta la famiglia le faceva dei dispetti; Rosa, a ventidue anni era stata ingannata da una mezzana e poi ingravidata da un farmacista, venne internata mentre stava cercando di abortire in ogni modo; Teresa, si era sposata con un uomo che amava fare baldoria, perse la ragione quando iniziò a ribellarsi al consorte; c’era anche la figlia di uno scialacquatore e di un’isterica, che si sposò a diciassette anni, partorì due volte ed ebbe un aborto, nessuno sa perché iniziò a stare male e la ricoverarono in manicomio. Queste erano le degenti di via Giulio, malate più di sfortuna e solitudine, che di qualche malattia specifica. Ancorate a quella struttura che perlomeno permetteva loro un briciolo di compagnia, c’è chi dice che in realtà non riescano tutt’oggi ad andarsene. Il manicomio di via Giulio chiuse nel 1973, venne utilizzato nel 1979 dal Movimento delle Donne di Torino come luogo in cui riunirsi, a partire dagli anni ’80 diventò sede dell’Anagrafe centrale di Torino. Ed è qui che la storia si fa davvero spettrale, infatti alcuni impiegati raccontano di strane presenze, porte che si chiudono da sole, un senso diffuso di inquietudine e auree di freddo che aleggiano a caso per i corridoi. Venne chiamato a verificare la situazione Gianni Cerruti, il quale, con alcuni dipendenti e appositi strumenti per rilevare onde elettromagnetiche, ispezionò la struttura con attenzione, i risultati che ottenne confermarono le testimonianze dei dipendenti: le anime buone e innocue delle pazienti erano ancora lì. Immobili e immutate, come i pini sempreverdi.
 alle undici e trenta e finiva temporaneamente con la cena alle sei e trenta, per poi riprendere identica il giorno successivo. Tra le forzate ospiti c’era Margherita, sarta e contadina, entrata in manicomio all’età di vent’anni, poiché aveva iniziato a sostenere che tutta la famiglia le faceva dei dispetti; Rosa, a ventidue anni era stata ingannata da una mezzana e poi ingravidata da un farmacista, venne internata mentre stava cercando di abortire in ogni modo; Teresa, si era sposata con un uomo che amava fare baldoria, perse la ragione quando iniziò a ribellarsi al consorte; c’era anche la figlia di uno scialacquatore e di un’isterica, che si sposò a diciassette anni, partorì due volte ed ebbe un aborto, nessuno sa perché iniziò a stare male e la ricoverarono in manicomio. Queste erano le degenti di via Giulio, malate più di sfortuna e solitudine, che di qualche malattia specifica. Ancorate a quella struttura che perlomeno permetteva loro un briciolo di compagnia, c’è chi dice che in realtà non riescano tutt’oggi ad andarsene. Il manicomio di via Giulio chiuse nel 1973, venne utilizzato nel 1979 dal Movimento delle Donne di Torino come luogo in cui riunirsi, a partire dagli anni ’80 diventò sede dell’Anagrafe centrale di Torino. Ed è qui che la storia si fa davvero spettrale, infatti alcuni impiegati raccontano di strane presenze, porte che si chiudono da sole, un senso diffuso di inquietudine e auree di freddo che aleggiano a caso per i corridoi. Venne chiamato a verificare la situazione Gianni Cerruti, il quale, con alcuni dipendenti e appositi strumenti per rilevare onde elettromagnetiche, ispezionò la struttura con attenzione, i risultati che ottenne confermarono le testimonianze dei dipendenti: le anime buone e innocue delle pazienti erano ancora lì. Immobili e immutate, come i pini sempreverdi.
alle undici e trenta e finiva temporaneamente con la cena alle sei e trenta, per poi riprendere identica il giorno successivo. Tra le forzate ospiti c’era Margherita, sarta e contadina, entrata in manicomio all’età di vent’anni, poiché aveva iniziato a sostenere che tutta la famiglia le faceva dei dispetti; Rosa, a ventidue anni era stata ingannata da una mezzana e poi ingravidata da un farmacista, venne internata mentre stava cercando di abortire in ogni modo; Teresa, si era sposata con un uomo che amava fare baldoria, perse la ragione quando iniziò a ribellarsi al consorte; c’era anche la figlia di uno scialacquatore e di un’isterica, che si sposò a diciassette anni, partorì due volte ed ebbe un aborto, nessuno sa perché iniziò a stare male e la ricoverarono in manicomio. Queste erano le degenti di via Giulio, malate più di sfortuna e solitudine, che di qualche malattia specifica. Ancorate a quella struttura che perlomeno permetteva loro un briciolo di compagnia, c’è chi dice che in realtà non riescano tutt’oggi ad andarsene. Il manicomio di via Giulio chiuse nel 1973, venne utilizzato nel 1979 dal Movimento delle Donne di Torino come luogo in cui riunirsi, a partire dagli anni ’80 diventò sede dell’Anagrafe centrale di Torino. Ed è qui che la storia si fa davvero spettrale, infatti alcuni impiegati raccontano di strane presenze, porte che si chiudono da sole, un senso diffuso di inquietudine e auree di freddo che aleggiano a caso per i corridoi. Venne chiamato a verificare la situazione Gianni Cerruti, il quale, con alcuni dipendenti e appositi strumenti per rilevare onde elettromagnetiche, ispezionò la struttura con attenzione, i risultati che ottenne confermarono le testimonianze dei dipendenti: le anime buone e innocue delle pazienti erano ancora lì. Immobili e immutate, come i pini sempreverdi.Alessia Cagnotto