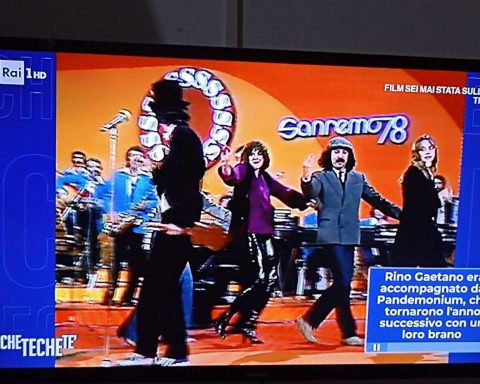Il Selvaspessa nasce dal Mottarone. Lì, dalla “montagna dei milanesi“, da  rigagnolo si fa torrente mano a mano che scende a valle. Per un bel po’ della sua strada è un lungo, stretto e tortuoso filo d’acqua corrente che prende forza per caduta fino a spegnersi nel lago a Baveno, tra il Lido e il parco della Villa Fedora . Questa villa fu acquistata nel 1904 da Umberto Giordano, autore dell’Andrea Chènier, della Cena delle Beffe e – appunto – di Fedora. E’ lì che per vent’anni, fino al 1924, il compositore visse e lavorò nella pace di questa villa che s’affaccia sul lago Maggiore. Ma a quella villa non sono legati solo ricordi gioiosi. Resta anche l’ombra dei “portatori di morte” dell’Obersturmführer delle SS Herbert Schnelle . A villa Fedora, nel settembre del 1943, era alloggiata la famiglia israelita dei Serman. Era il 17 settembre quando le SS fecero irruzione nella villa , uccidendo quattro dei componenti della famiglia (solo Sofia, assente, si salvò, scampando al massacro). Prima di allontanarsi, le SS fecero razzia di ogni oggetto di valore. I Serman furono tra le prime vittime dell’odio razziale nazista che, dopo aver colpito all’albergo Sempione di Arona ( ad opera del “cacciatore di teste” nazista Krüger , “il biondo capitano dagli occhi azzurri e gelidi” ), continuò nei giorni successivi a Baveno e sul lago Maggiore fino alla strage degli ebrei dell’Hotel Meina.Difficile scordarsi i racconti di chi visse in quei luoghi a quel tempo, riannodando i ricordi dei mesi che seguirono le stragi, quando affiorarono dall’acqua del lago i cadaveri con i piedi e le mani legati con il filo spinato.
rigagnolo si fa torrente mano a mano che scende a valle. Per un bel po’ della sua strada è un lungo, stretto e tortuoso filo d’acqua corrente che prende forza per caduta fino a spegnersi nel lago a Baveno, tra il Lido e il parco della Villa Fedora . Questa villa fu acquistata nel 1904 da Umberto Giordano, autore dell’Andrea Chènier, della Cena delle Beffe e – appunto – di Fedora. E’ lì che per vent’anni, fino al 1924, il compositore visse e lavorò nella pace di questa villa che s’affaccia sul lago Maggiore. Ma a quella villa non sono legati solo ricordi gioiosi. Resta anche l’ombra dei “portatori di morte” dell’Obersturmführer delle SS Herbert Schnelle . A villa Fedora, nel settembre del 1943, era alloggiata la famiglia israelita dei Serman. Era il 17 settembre quando le SS fecero irruzione nella villa , uccidendo quattro dei componenti della famiglia (solo Sofia, assente, si salvò, scampando al massacro). Prima di allontanarsi, le SS fecero razzia di ogni oggetto di valore. I Serman furono tra le prime vittime dell’odio razziale nazista che, dopo aver colpito all’albergo Sempione di Arona ( ad opera del “cacciatore di teste” nazista Krüger , “il biondo capitano dagli occhi azzurri e gelidi” ), continuò nei giorni successivi a Baveno e sul lago Maggiore fino alla strage degli ebrei dell’Hotel Meina.Difficile scordarsi i racconti di chi visse in quei luoghi a quel tempo, riannodando i ricordi dei mesi che seguirono le stragi, quando affiorarono dall’acqua del lago i cadaveri con i piedi e le mani legati con il filo spinato.

Tornando al Selvaspessa, a far da cornice al corso d’acqua, da una parte e dall’altra del torrente,scendono dalla vetta del Mottarone fitti boschi cedui di latifoglie. Castagno, faggio, betulla, rovere, cerro, frassino, acero, ontano, sorbo, robinia si alternano nei boschi misti che arrivavano a lambire le ultime case della Tranquilla, a Oltrefiume. della via Fraccaroli, dietro al cimitero, e ai margini del Bertarello. Al tempo in cui si era ragazzini era quello il nostro campo di gioco e di battaglia. Pietre scagliate nelle pozze, per schizzarci l’acqua addosso; arrampicate sui sassi , spesso verdi di scivolosissima “lita”, attorno ai quali la corrente disegnava dei piccoli gorghi; scorribande d’inverno quando l’acqua era assente e larghe e più o meno spesse lastre di ghiaccio livellavano gli anfratti, collegando i sassi uno con l’altro. Anche la pesca sul fiume era ben diversa da quella di lago. Qui si trattava di misurarsi con le trote di fiume che, a parità di prestazioni, sono più scaltre e smaliziate delle loro consorelle lacustri. Si nascondono sotto i sassi, sospettose. Scovarle è un bell’impegno.

La lenza, senza galleggianti e bilanciata con il giusto peso dei piombi, va fatta scorrere nella corrente, mettendo in bella mostra l’esca: un grasso lombrico, infilato sull’amo a regola d’arte. I lombrichi li  trovavamo scavando nella fossa del letame che stava pochi passi dietro la grande cascina dove il Guerra teneva le vacche e qualche animale da cortile. Ai vermi s’associavano anche le camole del miele, fornite dal vecchio Brambilla, un milanese che – dopo la guerra – aveva scelto di vivere sul lago dopo esservi arrivato per sfuggire ai bombardamenti alleati. Aveva due dozzine di arnie e produceva un miele dolcissimo e denso. Nel far sparire quelle larve dai bozzoli biancastri e robusti gli facevamo un piacere perché la “galleria mellonella“, la tarma maggiore della cera, più comunemente chiamata camola del miele, è un lepidottero infestante degli alveari.
trovavamo scavando nella fossa del letame che stava pochi passi dietro la grande cascina dove il Guerra teneva le vacche e qualche animale da cortile. Ai vermi s’associavano anche le camole del miele, fornite dal vecchio Brambilla, un milanese che – dopo la guerra – aveva scelto di vivere sul lago dopo esservi arrivato per sfuggire ai bombardamenti alleati. Aveva due dozzine di arnie e produceva un miele dolcissimo e denso. Nel far sparire quelle larve dai bozzoli biancastri e robusti gli facevamo un piacere perché la “galleria mellonella“, la tarma maggiore della cera, più comunemente chiamata camola del miele, è un lepidottero infestante degli alveari. E al Brambilla davano un sacco di noie. Così, riempiti i barattoli di lombrichi o di camole, pescavamo a striscio nelle pozze, seguendo il filo della corrente, fino a quando uno strappo secco ci comunicava la soddisfazione della cattura della preda. Sgusciavano tra la mani, vivaci e ribelli, le “fario” grigio-olivastre sul dorso, argenteo-giallastre sui fianchi e più bianche sul ventre. Le macchioline nere e rosso-aranciate che punteggiavano la parte superiore del corpo le distinguevano da quelle di lago, dove le macchie erano nere e irregolari. Eravamo espertissimi in questo tipo di pesca dove la scelta del piombo era importante quanto la scelta dell’amo, perché lungo il torrente dove l’acqua corre veloce è fondamentale riuscire a far lavorare bene l’esca. Al Selvaspessa non si andava solo a “bagnare” la lenza ma anche a prendere il sole, srotolando gli asciugamani sui sassi più larghi e piani , allungandoci sopra come lucertole al sole. Oppure, come facevo io d’estate, a leggere. Passavo lì le mie vacanze, da luglio a settembre. Il rumore dell’acqua corrente rappresentava il sottofondo ideale per estraniarsi dal mondo. Non disturbava affatto, aiutando la concentrazione, favorendo la riflessione, stimolando la fantasia. E’ lì che ho letto i
E al Brambilla davano un sacco di noie. Così, riempiti i barattoli di lombrichi o di camole, pescavamo a striscio nelle pozze, seguendo il filo della corrente, fino a quando uno strappo secco ci comunicava la soddisfazione della cattura della preda. Sgusciavano tra la mani, vivaci e ribelli, le “fario” grigio-olivastre sul dorso, argenteo-giallastre sui fianchi e più bianche sul ventre. Le macchioline nere e rosso-aranciate che punteggiavano la parte superiore del corpo le distinguevano da quelle di lago, dove le macchie erano nere e irregolari. Eravamo espertissimi in questo tipo di pesca dove la scelta del piombo era importante quanto la scelta dell’amo, perché lungo il torrente dove l’acqua corre veloce è fondamentale riuscire a far lavorare bene l’esca. Al Selvaspessa non si andava solo a “bagnare” la lenza ma anche a prendere il sole, srotolando gli asciugamani sui sassi più larghi e piani , allungandoci sopra come lucertole al sole. Oppure, come facevo io d’estate, a leggere. Passavo lì le mie vacanze, da luglio a settembre. Il rumore dell’acqua corrente rappresentava il sottofondo ideale per estraniarsi dal mondo. Non disturbava affatto, aiutando la concentrazione, favorendo la riflessione, stimolando la fantasia. E’ lì che ho letto i  racconti avventurosi di Emilio Salgari, immaginandomi a Mompracem , nel mar di Malesia, attraversando il Riff, gli oceani o le praterie del West. Ho conosciuto nei romanzi di Cesare Pavese le langhe, Santo Stefano Belbo, il mare di Varigotti e il rigore livido dei viali di Torino. Con l’immaginazione ho viaggiato nell’ America di John Steinbeck grazie alle pagine di Furore, Uomini e Topi, la Valle dell’Eden o tra il Vicolo Cannery e Pian della Tortilla . Ho incontrato i moschettieri di Dumas, attraversato le foreste al confine con il Canada insieme all’ultimo dei Mohicani, frequentato pirati e
racconti avventurosi di Emilio Salgari, immaginandomi a Mompracem , nel mar di Malesia, attraversando il Riff, gli oceani o le praterie del West. Ho conosciuto nei romanzi di Cesare Pavese le langhe, Santo Stefano Belbo, il mare di Varigotti e il rigore livido dei viali di Torino. Con l’immaginazione ho viaggiato nell’ America di John Steinbeck grazie alle pagine di Furore, Uomini e Topi, la Valle dell’Eden o tra il Vicolo Cannery e Pian della Tortilla . Ho incontrato i moschettieri di Dumas, attraversato le foreste al confine con il Canada insieme all’ultimo dei Mohicani, frequentato pirati e  bucanieri all’isola della Tortuga e sognato con Giulio Verne di scendere nel ventre della terra, fuggire con Michele Strogoff, viaggiare verso la luna e navigare ventimila leghe sotto i mari insieme al capitano Nemo. Il fiume – perché definirlo torrente ci pareva riduttivo – mi faceva dimenticare la predilezione che avevo per gli alberi. Era sui rami bassi di un albero, infatti, che passavo ore e ore a leggere libri e fumetti quand’ero da mia nonna, lontano dall’acqua del Selvaspessa. Ora di quel mondo fantastico e misterioso resta solo un ricordo. La parte bassa del fiume è completamente stravolta e mai nessuno s’avvia in quella direzione con un asciugamano e un libro sottobraccio. E’ un peccato perché la parte a nord del Selvaspessa, merita ancora. Ma oggi, si sa, il divertimento è meno semplice e l’acqua che scorre non accompagna più la fantasia dei ragazzi.
bucanieri all’isola della Tortuga e sognato con Giulio Verne di scendere nel ventre della terra, fuggire con Michele Strogoff, viaggiare verso la luna e navigare ventimila leghe sotto i mari insieme al capitano Nemo. Il fiume – perché definirlo torrente ci pareva riduttivo – mi faceva dimenticare la predilezione che avevo per gli alberi. Era sui rami bassi di un albero, infatti, che passavo ore e ore a leggere libri e fumetti quand’ero da mia nonna, lontano dall’acqua del Selvaspessa. Ora di quel mondo fantastico e misterioso resta solo un ricordo. La parte bassa del fiume è completamente stravolta e mai nessuno s’avvia in quella direzione con un asciugamano e un libro sottobraccio. E’ un peccato perché la parte a nord del Selvaspessa, merita ancora. Ma oggi, si sa, il divertimento è meno semplice e l’acqua che scorre non accompagna più la fantasia dei ragazzi.
Marco Travaglini
Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE